|
 *Recensione apparsa sulla webplatform Visioni Di Uomini e di Cani *Recensione apparsa sulla webplatform Visioni Di Uomini e di Cani
|Adele Cacciagrano| Nella sala bianca di Lenz Teatro a Parma – nella cornice del festival Nd’T 2011 – una donna e un cane si concedono il tempo per l’apparizione di una impercettibile danza. Cristina Rizzo e un cane, meglio una cagna, razza Schnauzer a pelo nero, di nome Gaia, si incontrano per quasi un mese ogni giorno, in una sala del Lenz prima, in una piccola stanzetta del centro città poi, per segnare una coreografia fatta principalmente di avvicinamento e di costanza che andrà a costituire la performance/spettacolo intitolata Micro-Danze con un cane addestrato. La cagna arriva, annusa la sua compagna, osa manovre di instabile avvitamento, tenta un morso che è segno d’amore, trasgressione e libertà rispetto a quello che è il suo codice di addestramento. La danza è l’esile cucitura finale di una partitura che è già scritta nelle manovre di conoscenza e di accostamento, nelle anse di movimento che il cane e la sua compagna umana sperimentano ogni giorno lavorando sul confine tra permettibile e non concesso. Del concetto stesso di rappresentazione questa micro-coreografia mantiene solo il lacerto di una composizione che arriva, come un atto cogente di chiusura, a determinare un primo punto di assestamento e, quindi, un momentaneo finale. Non così le musiche, una playlist che Cristina Rizzo ha commissionato a Michele Di Stefano e che nelle sue diverse coloriture ambientali, ritmiche ed emotive, diventano parte dell’ossatura di questo viaggio di conoscenza tra la danzatrice e la controparte canina-animale. Cristina, infatti, mette su la musica e Gaia si lascia andare, sospende per un attimo le inibizioni dovute all’apprendimento di un codice di comportamento e interagisce con salti, pause, avvitamenti e scatti densi di una bellezza che è pura energia animale. Le due repliche delle Microdanze con un cane addestrato che si sono svolte nella Sala Est di Lenz Teatro a Parma il 22 e 23 Novembre sono, quindi, istantanee di assestamento di una creazione altamente instabile e, proprio per questa sua qualità fragile, preziosa. Qui il fine della creazione, se ce n’è uno, non è neppure lontanamente la rappresentazione, ma l’agguantamento di un corpo di cagna prepotente in scena che chiede, all’altra, di non rappresentarsi mai, meno che mai di fingersi, ma di replicare istante per istante alla sua imponente sferzata di presenza anche quando, in teatro, decide di sottrarsi trasformandosi così in una inconfortevole e sconvolgente assenza. Due corpi presi in una relazione intima, cangiante e mutevole, in cui la partitura dell’incontro, se è vero che esiste, è costantemente minacciata non solo dalle incognite legate alla durata o alle diverse modalità di reazione in avvento, ma nella possibilità stessa di una effettiva rispondenza al desiderio di attuazione.
Cristina Rizzo e Gaia entrano in scena. Gaia decide di ispezionare gli astanti, incuriosita e vogliosa di scoprire qualcuno che, per odore, corrispondenza, simpatia o calore, possa risultare, alla sua percezione, interessante. Chi più chi meno, ogni spettatore risponde al muso di quella scodinzolante presenza. Poi Gaia se ne va. Decide che nessuno dei presenti seduti in fila risponde ai suoi requisiti di decenza e torna da lei, la coreografa, che l’attende e chiama, gentilmente, per nome: «Gaia!». Lei ci sta. A volte no. Quando decide di starci, cammina al fianco della compagna danzatrice e coreografa, si esibisce in una elegante passeggiata in circolo molto simile a quelle cliché di una qualsiasi esposizione canina. Cammina con schiena ben dritta e gambe posteriori inarcate. Alla destra della danzatrice, ne segue o ne anticipa i passi, mai inseguendo o lasciandosi trascinare. È fiera: una bestia di razza superiore che di tanto in tanto ci perscruta dall’alto di un’antica sapienza animale fatta di istinto e rispondenza ad un qui ed ora che, per lei, è improrogabile legge di vita. Le micro-danze, se Gaia ci sta, si svolgono come un filo dipanato al rotolo e dalla passeggiata si passa ad un gioco di andirivieni in quinta, quando da sotto il telo bianco che funge da micro-sipario tra il corridoio dei camerini e il palco, Gaia spunta e scompare, si assenta del tutto e poi riappare, per quarti donandoci in pasto la sua metà posteriore con tanto di buco anale e coda ben alzata, o come quando, decide di restare da sola su quella soglia della scena e per un attimo si volta e ci guarda.  C’è poi il momento della lotta, con Cristina Rizzo che torna in scena munita di un giubbotto nero impellicciato e Gaia che si aggancia al braccio offerto per un appuntato gioco d’azzanno su una colonna sonora ritmata e vivace. E ancora, Cristina Rizzo che appoggia il suo peso a quello di Gaia e lei che per un po’ la trascina, poi scivola via, ma infine ritorna, si accuccia distante, mentre con la coda duetta con un movimento di braccio battuto a terra che la danzatrice ha evidentemente preso in copia dall’animale. E poi la cagna gira, volteggi e salta, atterra malamente con le zampe sul pavimento scivoloso e si lascia slittare, pattina e si rialza pronta per un altro balzo, come una improbabile danzatrice hip hop di decennale esperienza. Ma Gaia, alla prima serata, decide, invece, che a quel gioco al teatro decisamente non ci sta. La presenza del pubblico la infastidisce. Quegli sguardi insoliti e appuntati sul suo corpo, devono crearle la sensazione di poter diventare una preda, e questo la secca e irretisce. C’è poi il momento della lotta, con Cristina Rizzo che torna in scena munita di un giubbotto nero impellicciato e Gaia che si aggancia al braccio offerto per un appuntato gioco d’azzanno su una colonna sonora ritmata e vivace. E ancora, Cristina Rizzo che appoggia il suo peso a quello di Gaia e lei che per un po’ la trascina, poi scivola via, ma infine ritorna, si accuccia distante, mentre con la coda duetta con un movimento di braccio battuto a terra che la danzatrice ha evidentemente preso in copia dall’animale. E poi la cagna gira, volteggi e salta, atterra malamente con le zampe sul pavimento scivoloso e si lascia slittare, pattina e si rialza pronta per un altro balzo, come una improbabile danzatrice hip hop di decennale esperienza. Ma Gaia, alla prima serata, decide, invece, che a quel gioco al teatro decisamente non ci sta. La presenza del pubblico la infastidisce. Quegli sguardi insoliti e appuntati sul suo corpo, devono crearle la sensazione di poter diventare una preda, e questo la secca e irretisce.
|
|
Leggi tutto...
|
|
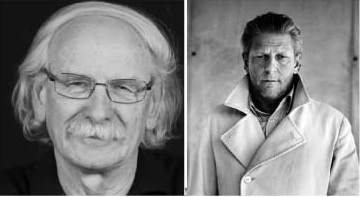
Racconto di un dialogo mancato tra arte e neuroscienza.
|Giada Lusardi| Si è tenuto lunedì 7 novembre presso il Teatro Due di Parma l'incontro tra l'artista Jan Fabre e il neuroscienziato Giacomo Rizzolatti. La conferenza, organizzata dalla Fondazione Teatro Due in collaborazione con il Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Parma, si è svolta alla presenza di una sala affollata di gente ansiosa di assistere al dialogo pubblico tra arte e neuroscienza che vedeva coinvolti il padre-scopritore dei Neuroni Mirror e l’artista poliedrico e geniale di fama internazionale. L’incontro inizia con puntualità chirurgica, alle 17:00, con il professor Rizzolatti che, rivolgendosi al pubblico, introduce l'artista fiammingo con queste parole: “Presentare Jan Fabre non è facile come presentare uno scienziato di cui si dice: ha fatto questo, ha studiato questo...E’ molto più difficile!”. In effetti Jan Fabre è un'artista complesso il cui lavoro non è sintetizzabile in poche frasi o parole. Nato nel 1958 ad Anversa, nipote del celebre entomologo Jean Henri-Fabre, inizia la sua formazione artistica presso l’Istituto di Arti Decorative e Belle Arti di Anversa per poi proseguire presso la Royal Academy della stessa città.
Per amore di una donna, ci racconta sempre Rizzolatti, Fabre si appassiona al teatro e inizia a disegnare i costumi di scena di alcuni spettacoli. Negli anni '80, ad Anversa, dirige il suo primo spettacolo: Theatter geschreven met een K is een kater e This is theatre like it was to be expected and foreseen, uno spettacolo della durata di otto ore, dal tramonto all’alba. Ricorda, sempre Rizzolatti, che nel 2008 Jan Fabre è stato invitato ad esporre il proprio lavoro al Louvre, nelle sale dedicate alla pittura fiamminga, dove l’artista ha presentato un progetto intitolato The Angel of Metamorphosis. Dopo la breve introduzione di presentazione, la parola passa direttamente a Jan Fabre che, sul filo dei ricordi, inizia ad auto-raccontarsi con queste parole: “Per me il cervello è la parte più importante del corpo”. E in effetti il cervello è stato ed è da sempre un elemento fondamentale nella sua opera. Il suo avvicinamento ai temi della percezione e dell’espressione artistica per mezzo del corpo inizia nel 1977, quando l’artista fiammingo entrò per la prima volta in contatto con la performance art scoprendo la possibilità di utilizzare “il corpo” come linguaggio espressivo. Quelli erano anche gli anni in cui Fabre sperimentava, attraverso la Blood painting, le potenzialità espressive dei liquidi corporei quali urina e sangue (si ricordi la performance My body, my blood, my landscape realizzata nel 1978 ad Anversa).
Fabre è da sempre, poi, interessato alla significazione erotica del corpo: aspetto, quello della sessualità, trattato anche nel progetto From the Feet to the Brain realizzato nel 2009 negli spazi dell’Arsenale Novissimo a Venezia. Grazie ai racconti dell’artista stesso e alle immagini proiettate alle sue spalle, anche gli ascoltatori di questo dialogo che si svolge nel foyer del Teatro Due di Parma, possono intraprendere un percorso ideale lungo le sale dell’imponente istallazione. Il progetto From the Feet to the Brain, presentato precedentemente in Austria (2008 alla Kunsthaus Bregenz), si sviluppa su cinque livelli e riprendendo lo schema del corpo umano, crea un percorso che inizia dal livello più basso, quello dei piedi, per finire, con il cervello, al livello superiore. Nel ripercorrere questo progetto Jan Fabre racconta un mondo di orrore, di bellezza e metamorfosi oscillante tra sogno e realtà.
Il percorso visivo e ideale che ci viene riproposto in questo pomeriggio d’autunno inizia, quindi, dai “piedi” sede di quella zona che l’artista definisce lo “Studio/rifugio” degli artisti, un laboratorio dove nascondersi e lavorare. Fabre ha ideato questo ambiente basandosi su diversi modelli da lui ideati negli anni ‘90.
|
|
Leggi tutto...
|
|
 Natura Dèi Teatri Natura Dèi Teatri
Performing Arts Festival
XVI edizione
Di Uomini e Di Cani
Parma | Lenz Teatro
11>25 Novembre 2011
*Intervista apparsa sulla webplatform Visioni Di Uomini e di Cani
La nuova edizione di Natura Dèi Teatri ha per titolo “di Uomini e di Cani”. Il rapporto uomo-animale è da sempre centrale nel pensiero filosofico, ma è anche un perno fondativo dell'espressione artistica e in particolare di quella teatrale. Penso alle rappresentazioni animali dell'arte preistorica o ai rituali dove l'animale aveva una funzione sacrificale, o ancora alla tragedia e alla commedia o al dramma satiresco e alla loro originaria connessione con i culti di Dioniso. L’animale come alterità-in-noi è l’elemento essenziale nel poema ovidiano Metamorphoseon libri XV che è stato vostro ispiratore per numerosi spettacoli. Quella tra uomo e animale è una relazione stratificata, intima e misteriosa, capace di riconvocare la zoomorfia delle favole e il fantastico, il perturbante e il postumano, e il campo semantico che instaura convoca sessualità, violenza, bestialità, crudeltà, ma anche istinto, pazzia, infantilismo, grazia. Lenz Rifrazioni edifica un nuovo ambiente di riflessione legando problematicamente la nozione di animalità e quella di immaginario contemporaneo…
Per risponderti devo tornare alle origini. Il pensiero corre a tre anni fa, quando Francesco Pititto e io abbiamo pensato il progetto triennale che con questa edizione si conclude. Oggi posso constatare che il tempo ha sostanzialmente trasformato l’idea originale. Ero partita, come si faceva nel ‘500, sottraendo da un’opera letta, in maniera quasi insensata, alcune parole. Ho selezionato quelle che mi facevano vibrare in Exilium che abbiamo ideato a partire da Tristia ed Epistulae ex Ponto di Ovidio, opere su cui stavamo lavorano sentendoci nella posizione del poeta isolato, sostanzialmente strappato dalla sua patria e esiliato ai confini dell’occidente, che è poi la condizione dell’artista nel nostro periodo storico. E da lì abbiamo provato a esperire e sperimentare attraverso il nostro pensiero e la nostra sensibilità le parole di Ovidio. Queste sottrazioni, questi calchi, o singole grafie erano dei luoghi vuoti che abbiamo provato a riempire da un lato con la nostra esperienza artistico-estetica, ma anche attivando vibrazioni e risonanze nel dialogo con gli altri artisti.
Oggi tutto assume un significato più ampio. Campi, titolo dell’edizione 2009, nasceva, all’inizio, dal desiderio di allargare la visione del teatro da una dimensione percettivo-sensoriale alla configurazione di “campi” emotivi, geografici, sonori. Dunque a un’idea di teatro che non fosse legata solo al corpo, alla parola, a quei segni funzionali già molto impoveriti dall’utilizzo. Aprire questi campi. Che nel caso di Ovidio erano campi vuoti. Ciò che si celava dietro al nome era l’idea di sfaccettare lo spazio artistico. Il progetto dello scorso anno aveva per titolo il nodo concettuale la Cute. In quella edizione era in gioco la dimensione politica della superficie, membrana sottile e resistente dove tutto si contagia, si contatta e si brucia nella relazione artistica. Questi primi due momenti trovano uno sviluppo in di Uomini e di Cani. Questa grafia si stacca dai Tristia ovidiani e fa riferimento a quel momento in cui il poeta è solo nel suo rifugio-studio e sente “solo voci di uomini e di cani” equiparando le sonorità animali con quelle emesse dalla voce barbara che lui non capisce: non-latino paragonato alla vocalità animale.
Non c’è nel nostro disegno un rimando esplicito alla dimensione vocale, vorremmo fosse una linea sotterranea che possa riemergere nei lavori ospiti. Dei cani ululanti di Ovidio resta piuttosto un’ombra, qualcosa che ci sollecita non in quanto fisicità stretta, anche se nel festival ci saranno molti cani. La relazione uomo-animale, che muove da quella prima suggestione, procede verso un’elaborazione autonoma in cui i poli non sono necessariamente declinati in una contrapposizione, né d’altra parte si possono sovrapporre. Si tratta semmai di dimensioni che risuonano pericolosamente allo stesso modo. C’è qui il desiderio di cogliere una dimensione non domestica della visione animale, come della visione umana. Ogni cultura non sviluppa forse il proprio rapporto con il sé animale?
“di Uomini e di Cani” sembra configurarsi come la messa in gioco di un problema che si vuole fare carico di un margine di fuori controllo. La tessitura plurale del festival non si costruisce infatti su linee estetiche e poetiche capaci di dare conto o verificare un’idea di partenza…
Questo è stato il motore per pensare un’edizione che non avesse un orientamento stilistico. Non siamo andati alla ricerca – come è accaduto per l’edizione dello scorso anno – di artisti che, in colloquio con noi, vibrassero in una medesima direzione, ma di aprire un campo sterminato di possibilità dove animali e non, uomini e cani, potevano mettere in crisi la funzione performativa. Il porre l’altro dentro di noi. La parte di noi sconosciuta, bestiale… o la parte desiderata di noi. Questa è la domanda  forte che anima e motiva il festival. La possibilità di mettere in movimento quindi, nella proposta ad altri artisti, come a noi stessi – che siamo presenti nella duplice funzione di creatori intellettuali della cornice e artisti – di creare un cumulo di azioni piuttosto che una via dichiarata e chiara. Si è trattato di accendere un processo. Io non sono un curatore. Vivendo, leggendo, osservando e assorbendo anche indirettamente da altre persone, provo a costruirmi una casa affettiva in cui gli artisti occupano una stanza. Credo che sia questo senso, anche architettonico, che si possa riconoscere il tratto distintivo di Nd’T, nella sua costruzione di spazi, stanze, piani, livelli. Il nostro progetto di quest’anno non mette in campo dunque una dimensione orizzontale dove ci sono vie e percorsi, ma una casa al cui interno, un tuo primo movimento si spazia per accogliere l’altro, intercettato da frammenti di visioni, da occasioni precedenti, da incontri fortuiti. In questo modi si è progressivamente focalizzata l’attenzione per l’artista che viene dall’Est Europa. In questa edizione lo possiamo riconoscere nell’idea di coinvolgere l’artista polacco Paul Wirkus, uno dei massimi musicisti contemporanei elettronici, già nostro ospite per due edizioni, che ha curato materia sonora del terzo atto Il polmone di AENEIS, ricoinvolgendolo in un dialogo stretto e addirittura in una coproduzione. Anche il collettivo sloveno Via Negativa, presenti al LENZ TEATRO con molti lavori, sono un segno evidente della costruzione della nostra casa affettiva. Attraverso la loro riflessione estetica e poetica posso interrogarmi su quale sia la funzione non solo dell’artista, ma anche la funzione dell’artista che pensa il proprio fare con i mezzi che gli sono propri attraverso l’azione creativa. Altro artista est-europeo è Ivo Dimchev, coreografo, performer e attore bulgaro di straordinaria intensità e capacità auto-analitica. Una forma di auto interrogazione è anche quella agita dalla coreografa austriaca Doris Uhlich che nel suo Rising Swan, prendendo come punto di partenza la coreografia di Michel Fokine The Dying Swan interroga la sua capacità di divenire-cigno attraverso la propria povertà autobiografica. Su questo piano anche la presenza dei Kinkaleri con I AM THAT AM I, formazione che reputo simmetrica alla nostra per rigore e per spinta non esibitiva ma introspettiva, rappresentano un punto molto alto. L’incontro con SPELL, la nuova creazione di Zapruder è stata una folgorazione. Il desiderio che avevamo da tempo, di aprire Nd’T alla produzione filmica e all’installazione multimediale, aspetto che si sintonizza con l’imagoturgia di Francesco Pittito, si è finalmente concretizzato. La sensazione generale è quella di qualcosa che via via si inanella. E lo spettatore non l’ultimo di questa catena di presenze è l’ospite che arriva nella tua casa intellettuale e artistica e vive nella tua stanza di fronte a un quadro che si compone con esperienze non-analoghe. forte che anima e motiva il festival. La possibilità di mettere in movimento quindi, nella proposta ad altri artisti, come a noi stessi – che siamo presenti nella duplice funzione di creatori intellettuali della cornice e artisti – di creare un cumulo di azioni piuttosto che una via dichiarata e chiara. Si è trattato di accendere un processo. Io non sono un curatore. Vivendo, leggendo, osservando e assorbendo anche indirettamente da altre persone, provo a costruirmi una casa affettiva in cui gli artisti occupano una stanza. Credo che sia questo senso, anche architettonico, che si possa riconoscere il tratto distintivo di Nd’T, nella sua costruzione di spazi, stanze, piani, livelli. Il nostro progetto di quest’anno non mette in campo dunque una dimensione orizzontale dove ci sono vie e percorsi, ma una casa al cui interno, un tuo primo movimento si spazia per accogliere l’altro, intercettato da frammenti di visioni, da occasioni precedenti, da incontri fortuiti. In questo modi si è progressivamente focalizzata l’attenzione per l’artista che viene dall’Est Europa. In questa edizione lo possiamo riconoscere nell’idea di coinvolgere l’artista polacco Paul Wirkus, uno dei massimi musicisti contemporanei elettronici, già nostro ospite per due edizioni, che ha curato materia sonora del terzo atto Il polmone di AENEIS, ricoinvolgendolo in un dialogo stretto e addirittura in una coproduzione. Anche il collettivo sloveno Via Negativa, presenti al LENZ TEATRO con molti lavori, sono un segno evidente della costruzione della nostra casa affettiva. Attraverso la loro riflessione estetica e poetica posso interrogarmi su quale sia la funzione non solo dell’artista, ma anche la funzione dell’artista che pensa il proprio fare con i mezzi che gli sono propri attraverso l’azione creativa. Altro artista est-europeo è Ivo Dimchev, coreografo, performer e attore bulgaro di straordinaria intensità e capacità auto-analitica. Una forma di auto interrogazione è anche quella agita dalla coreografa austriaca Doris Uhlich che nel suo Rising Swan, prendendo come punto di partenza la coreografia di Michel Fokine The Dying Swan interroga la sua capacità di divenire-cigno attraverso la propria povertà autobiografica. Su questo piano anche la presenza dei Kinkaleri con I AM THAT AM I, formazione che reputo simmetrica alla nostra per rigore e per spinta non esibitiva ma introspettiva, rappresentano un punto molto alto. L’incontro con SPELL, la nuova creazione di Zapruder è stata una folgorazione. Il desiderio che avevamo da tempo, di aprire Nd’T alla produzione filmica e all’installazione multimediale, aspetto che si sintonizza con l’imagoturgia di Francesco Pittito, si è finalmente concretizzato. La sensazione generale è quella di qualcosa che via via si inanella. E lo spettatore non l’ultimo di questa catena di presenze è l’ospite che arriva nella tua casa intellettuale e artistica e vive nella tua stanza di fronte a un quadro che si compone con esperienze non-analoghe.
|
|
Leggi tutto...
|
|

[ Silvia Mei ] A Reggio Emilia Danza, in intersezione col Festival Aperto, si è succeduta una costellazione di appuntamenti, dal balletto moderno alla performance, passando per il teatrodanza francese, la danza d’autore italiana e le creazioni d’arte del coreografo Shen Wei in collaborazione con la Collezione Maramotti.
Due supernove, due abbaglianti flash, di raffinata origine francese: il Ballet de Marseille e la Compagnie Maguy Marin. Il balletto di Marsiglia (che è anche Centre corégraphique), diretto dal 2004 da Frédéric Flamand, rinnova la sua presenza reggiana aprendo il festival e la stagione di danza dei Teatri di Reggio Emilia con un programma letteralmente postmoderno: Lucinda Childs, William Forsythe, Annabelle Lopez Ochoa, succedutisi però in senso inverso.
Quello che fu dal 1972 il “balletto” di Roland Petit, recentemente scomparso e con questo programma omaggiato, è uno degli ensemble di danza teatrale più interessanti, soprattutto nell’espletamento del progetto artistico pluridisciplinare, e transdisciplinare, di Flamand, oggi anche alla direzione del Festival de Danse de Cannes per il biennio 2011-13, dopo l’esperienza della prima edizione della Biennale Danza di Venezia nel 2003.
Inverses - titolo quanto mai suggestivo e ambiguo, a partire dalle diverse grafie con cui lo si trova scritto - è un quadro astratto, ideato e coreografato dalla belga-colombiana Annabelle Lopez Ochoa, fatto di linee e rotondità rotte da una figurina energica ed espressiva, scalzata e scalza, che monologa nell’apollineo universo di un ensemble dagli echi balanchiniani (ricorda Agon anche la struttura, oltre il bicromia bianco-nero e l’essenzialità del décor). La formazione accademica della danzatrice e coreografa passata nel filtro della tradizione olandese (ha lavorato come solista dal 1997 al 2004 allo Scapino Ballet di Rotterdam) decanta tuttavia una danza patinata e poco ardita, più sostenuta dalla drammaturgia musicale di David van Bouwel sugli inserti poetici della scrittrice e architetta americana Hollace M. Metzger, senza provare una reale inversione linguistica. È comunque un’ottima premessa e preparazione alle spezzature e rotture di un Forsythe d’antan, proposto in programma con Herman Schmerman Pas de deux (1992). La chiusa in duo dell’omonimo balletto è una cristallina espressione della rivoluzione postclassica del coreografo americano, che tornerà nuovamente ospite con la sua Compagnia ai Teatri di Reggio Emilia nel prossimo aprile. Lo scambio di genere, non privo di un’ironia velatamente erotica, trasforma in flirt la classica combinazione, ora spigoloso e graffiante gioco-forza di coppia sulla musica concreta, un tappeto ritmico su cui scivolare, di Tom Willems.
In chiusura, una coreografia perdutamente americana, Tempo vicino di Lucinda Child, nome che non necessita di commenti. Il corpo naturale, sociale, tanto vagheggiato dagli utopisti della Judson, trova espressione e forma ancora oggi in una scrittura coreografica lineare e semplice, al tempo presente. La paratassi apparente diventa sintassi di corpi negli scambi liquidi di linee orizzontali e attraversamenti veloci. C’è la scioglievolezza di un tessuto leggero e serico che cela strutture complesse, principi essenziali di un bios che è movimento cellulare, molecolare, algebrico.
All’interno della terza edizione di FranceDanse, programma di promozione e focus lanciato dal rinnovato Institut Français nel 2007, arriva in Italia, con date esclusive a TorinoDanza e ad Aperto Festival di Reggio Emilia, Salves, ultima creazione della coreoregista franco-spagnola Maguy Marin, in co-produzione con la Biennale de la dance de Lyon e il Théâtre de la Ville de Paris. La figlia ribelle di Béjart, nota per la bruta pratica del dispiacere nel pubblico, lungo il filo di spettacoli mai colpevoli dell’estetica della bellezza, avanza nella sua riflessione sui destini dell’umanità. Come nel precedente Turba, ispirato all’opera di Lucrezio, un giardino pensile faceva da paravento a errabonde e prelinguistiche figure di uomini, ora in Salves (riecheggia nuovamente nel titolo l’eufonia del latino) una varia umanità (di sette performer interetnici), evoluta e progredita, mette in salvo se stessa e le sue, non troppo imperiture, icone - tracce o testimoni dell’arte in un mondo crudele. Piccoli gruppi di fuggiaschi, con cappottini anni Quaranta, come precipitosi e incauti sfollati, spauriti sotto luci da coprifuoco, smobilitano pezzi di case e avanzi di musei su uno sconcerto di eliche falcianti, sirene, ventole e fruscii di nastri magnetici. Oppure imbandiscono ultime cene, apparando in grande stile mense decorate con argenti e limoges, in una catena di montaggio che si dà il ritmo a colpi di voce.
Salves è una composizione per quadri, un montaggio di flash, di reperti di una memoria emotiva e visiva frammentaria e di azioni, sempre nella parsimonia di Marin per la danza pura, residuata in un lift classico o in una corsa duncaniana in diagonale, subito inghiottita dal buio. L’impressione è quella di un film e il montaggio con forti stacchi in nero, cesure ritmiche nell’alternanza tra interni ed esterni, conferma quel già provato talento cinematografico della coreografa. Ma c’è anche un côté tragico-burlesco e un’accelerazione sulle forme del grottesco e del kitsch anni Ottanta che colorano una testura color seppia: un poster di Elvis Presley, religiosamente disteso sulla parete in un’azione reiterata da cloni di donne-modello; un doppie ruote motrici telecomandato che si aggira come blindato tra tavole di esuli; inserti esotici che appaiono da sotto un tavolo o irrompono inattesi; poi, il finale “dipinto” con getti di vernice e risse clownesche tra centrotavola e portate in polimeri.
C’è però un’immagine, centrale, che orienta la visione di un barcone della speranza come questo: è la figura della treccia, quella di una ragazza di spalle con parrucca bionda, sorpresa nell’intimità della sua cura. Questa treccia è il filo di Arianna, è la trama della storia, è l’intrigo della narrazione, ora sfilacciata e smagliata a colpi di shock, come lo stridore di un piatto irrimediabilmente rotto, che scivolando di mano interrompe la catena di montaggio dei suoi attori – un tramandarsi appunto della storia, delle storie, di gesti e di tradizioni. Neanche i tre registratori magnetici, che perimetrano su due lati l’azione, possono archiviare se non parzialmente i fatti, malgrado il loro instancabile moto circolare – un nastro che si avvolge su se stesso ma che annoda e annida solo pezzi di cose. É così allora che interviene il finale - o forse un incipit - su un festino orgiastico, con una citazione, cinematografica, esemplare, dalla Dolce vita di Fellini: un elicottero giocattolo con appeso un Cristo dalle braccia aperte sorvola la sibaritica libagione, quasi fosse una benedizione, o un segno divino, o forse solo l’arrivo in assordante ritardo di un ospite, che si inventa un entrata trionfale a festa finita.
|
|
|




 *Recensione apparsa sulla webplatform Visioni Di Uomini e di Cani
*Recensione apparsa sulla webplatform Visioni Di Uomini e di Cani C’è poi il momento della lotta, con Cristina Rizzo che torna in scena munita di un giubbotto nero impellicciato e Gaia che si aggancia al braccio offerto per un appuntato gioco d’azzanno su una colonna sonora ritmata e vivace. E ancora, Cristina Rizzo che appoggia il suo peso a quello di Gaia e lei che per un po’ la trascina, poi scivola via, ma infine ritorna, si accuccia distante, mentre con la coda duetta con un movimento di braccio battuto a terra che la danzatrice ha evidentemente preso in copia dall’animale. E poi la cagna gira, volteggi e salta, atterra malamente con le zampe sul pavimento scivoloso e si lascia slittare, pattina e si rialza pronta per un altro balzo, come una improbabile danzatrice hip hop di decennale esperienza. Ma Gaia, alla prima serata, decide, invece, che a quel gioco al teatro decisamente non ci sta. La presenza del pubblico la infastidisce. Quegli sguardi insoliti e appuntati sul suo corpo, devono crearle la sensazione di poter diventare una preda, e questo la secca e irretisce.
C’è poi il momento della lotta, con Cristina Rizzo che torna in scena munita di un giubbotto nero impellicciato e Gaia che si aggancia al braccio offerto per un appuntato gioco d’azzanno su una colonna sonora ritmata e vivace. E ancora, Cristina Rizzo che appoggia il suo peso a quello di Gaia e lei che per un po’ la trascina, poi scivola via, ma infine ritorna, si accuccia distante, mentre con la coda duetta con un movimento di braccio battuto a terra che la danzatrice ha evidentemente preso in copia dall’animale. E poi la cagna gira, volteggi e salta, atterra malamente con le zampe sul pavimento scivoloso e si lascia slittare, pattina e si rialza pronta per un altro balzo, come una improbabile danzatrice hip hop di decennale esperienza. Ma Gaia, alla prima serata, decide, invece, che a quel gioco al teatro decisamente non ci sta. La presenza del pubblico la infastidisce. Quegli sguardi insoliti e appuntati sul suo corpo, devono crearle la sensazione di poter diventare una preda, e questo la secca e irretisce.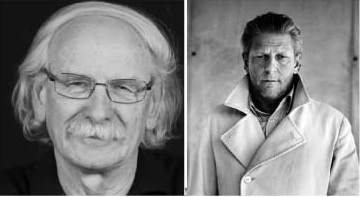
 Natura Dèi Teatri
Natura Dèi Teatri  forte che anima e motiva
forte che anima e motiva