|
 Albero senza ombra Albero senza ombra
una piece teatrele in bilico tra arte e giornalismo
[ Giulia D'Amico ] Ancora una volta, una corrente di teatro civile oltre oceano attraversa l’Italia. Dopo il successo internazionale di spettacoli come i Sandali del tempo, Dentro un sole giallo e Otra vez Marcelo, il regista argentino César Brie, continua la propria mission e artistica d’indagine e di denuncia sulle problematiche politiche e sociali della Bolivia, Paese in cui ha fondato il Teatro de los Andes e dove ha vissuto negli ultimi vent’anni. Già gli spettacoli precedenti erano caratterizzati da una fase di ricerca sul campo, sia conducendo interviste ad personam, sia attraverso l’analisi di fonti scritte, documenti ufficiali piuttosto che romanzi autobiografici o testimonianze. Per l’ultimo monologo Albero senza ombra le indagini hanno assunto tutte le caratteristiche di un'inchiesta giornalistica, minuziosa e accurata, dando vita, ancor prima del testo teatrale, ad un documentario audio-visivo: Tahuamanu, Morir en el Pando. Il Pando è una regione della giungla Boliviana, dove l’11 settembre 2008 si è consumato l’efferato massacro di alcuni campesinos ad opera di un gruppo di squadristi, in seno ad una manifestazione. Undici i morti accertati. Ma secondo alcune fonti decine di corpi erano stati occultati nelle foreste. La sensibilità politica di Brie, ha spinto l’artista ad indagare intorno alle omissioni dei fatti realmente accaduti, recandosi sul luogo della strage per intervistare le persone direttamente o indirettamente coinvolte e trovare una pista che lo potesse condurre alla scoperta della verità. Dopo mesi di lavoro, grazie al fondamentale contributo del medico legale Alberto Brailovsky, Brie è finalmente riuscito a fare luce sulla morte di alcuni scomparsi, sulla vera dinamica degli eventi, sull’occultamento e distorsione di prove ed infine sulla falsificazione di atti giudiziari e perizie necroscopiche. Inevitabilmente, la diffusione del documentario ha provocato delle ripercussioni sia nella vita di Brie che del medico argentino. Entrambi hanno ricevuto minacce di morte e Brailovsky è tutt’ora perseguitato dal capo della Polizia Federale Argentina Nestor Valleca, con l’accusa di aver fatto una perizia che non doveva assolutamente essere compiuta. e artistica d’indagine e di denuncia sulle problematiche politiche e sociali della Bolivia, Paese in cui ha fondato il Teatro de los Andes e dove ha vissuto negli ultimi vent’anni. Già gli spettacoli precedenti erano caratterizzati da una fase di ricerca sul campo, sia conducendo interviste ad personam, sia attraverso l’analisi di fonti scritte, documenti ufficiali piuttosto che romanzi autobiografici o testimonianze. Per l’ultimo monologo Albero senza ombra le indagini hanno assunto tutte le caratteristiche di un'inchiesta giornalistica, minuziosa e accurata, dando vita, ancor prima del testo teatrale, ad un documentario audio-visivo: Tahuamanu, Morir en el Pando. Il Pando è una regione della giungla Boliviana, dove l’11 settembre 2008 si è consumato l’efferato massacro di alcuni campesinos ad opera di un gruppo di squadristi, in seno ad una manifestazione. Undici i morti accertati. Ma secondo alcune fonti decine di corpi erano stati occultati nelle foreste. La sensibilità politica di Brie, ha spinto l’artista ad indagare intorno alle omissioni dei fatti realmente accaduti, recandosi sul luogo della strage per intervistare le persone direttamente o indirettamente coinvolte e trovare una pista che lo potesse condurre alla scoperta della verità. Dopo mesi di lavoro, grazie al fondamentale contributo del medico legale Alberto Brailovsky, Brie è finalmente riuscito a fare luce sulla morte di alcuni scomparsi, sulla vera dinamica degli eventi, sull’occultamento e distorsione di prove ed infine sulla falsificazione di atti giudiziari e perizie necroscopiche. Inevitabilmente, la diffusione del documentario ha provocato delle ripercussioni sia nella vita di Brie che del medico argentino. Entrambi hanno ricevuto minacce di morte e Brailovsky è tutt’ora perseguitato dal capo della Polizia Federale Argentina Nestor Valleca, con l’accusa di aver fatto una perizia che non doveva assolutamente essere compiuta.
|
|
Leggi tutto...
|
|
Intervista a Guy Regis
 [a cura di Rosaria Ruffini] Guy Regis jr. è una delle maggiori promesse del teatro francofono (www.lesfrancophonies.com/maison-des-auteurs/regis-guy-junior). Regista, attore e drammaturgo di successo, il giovane artista haitiano sarà una delle figure più in vista al prossimo Festival di Avignone. Il pubblico italiano ha avuto la fortuna di applaudirlo nell’unica data italiana di Moi fardeau inhérent, al teatro Santa Marta dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Uno spettacolo che ribalta sottilmente tutte le convenzioni sceniche, proponendo una estetica nuova intrisa di concretezza. Moi fardeau inhérent obbliga lo spettatore a guardare diversamente, a indagare il buio sotterraneo che copre la scena e che riveste il dramma di una donna che aspetta sotto la pioggia, per vendicare uno stupro. Il monologo è sostenuto con coraggio e mestiere dalla sorprendente interprete Nanténé Traoré, che accompagnerà Regis anche nel nuovo spettacolo commissionato dal Festival di Avignone. In una breve pausa di lavoro a Parigi, l’artista ci illustra il suo inusuale percorso. [a cura di Rosaria Ruffini] Guy Regis jr. è una delle maggiori promesse del teatro francofono (www.lesfrancophonies.com/maison-des-auteurs/regis-guy-junior). Regista, attore e drammaturgo di successo, il giovane artista haitiano sarà una delle figure più in vista al prossimo Festival di Avignone. Il pubblico italiano ha avuto la fortuna di applaudirlo nell’unica data italiana di Moi fardeau inhérent, al teatro Santa Marta dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Uno spettacolo che ribalta sottilmente tutte le convenzioni sceniche, proponendo una estetica nuova intrisa di concretezza. Moi fardeau inhérent obbliga lo spettatore a guardare diversamente, a indagare il buio sotterraneo che copre la scena e che riveste il dramma di una donna che aspetta sotto la pioggia, per vendicare uno stupro. Il monologo è sostenuto con coraggio e mestiere dalla sorprendente interprete Nanténé Traoré, che accompagnerà Regis anche nel nuovo spettacolo commissionato dal Festival di Avignone. In una breve pausa di lavoro a Parigi, l’artista ci illustra il suo inusuale percorso.
Moi Fardeau è una pièce sotterraneamente femminile
Scrivo perché sono indignato e credo che sia doveroso essere consapevoli di quanto accade, dell’aggressione sottile e costante che viene esercitata sulle donne. Una violenza quotidiana che diventa sempre più visibile. Quando ho scritto il testo, pensavo a un mercato che si trova a Port-au-Prince, di giorno frequentato da donne e di notte deserto. Una donna, in questo luogo, aspetta. La pièce è ombrosa, quasi interamente buia. Quando ho messo in scena il testo ho pensato per prima cosa alla luce. Mi sono messo al posto della spettatore, cercando quello che vorrei vedere. E in questa pièce, bisogna ammetterlo, ci sono molte cose che non vorrei vedere. Per questo l’attrice è spesso di spalle, negando il suo viso allo spettatore. Lavoro molto sulla suggestione. Su una risonanza quasi interiore, con il pubblico. Insisto molto sulla persistenza retinica. All’inizio dello spettacolo un grosso faro è acceso verso il pubblico, quasi accecandolo. Quando poi viene spento e l’attrice entra in scena, non si capisce se è un’immagine vera o presunta.
Si direbbe quasi un teatro dell’assenza
L’assenza mi è cara. In teatro cerco l’assenza per avere una presenza, per avere delle apparizioni che mi nutrono. La parola essa stessa è già un’apparizione. Prima di cominciare uno spettacolo si spengono le luci. “E la luce fu”… ma prima ci deve essere il buio. Prima della nostra data italiana a Venezia, ci siamo detti che forse dovevamo rendere lo spettacolo più “visibile”, dal momento che il testo in francese non sarebbe stato comprensibile ai più. Dovevamo calibrare più luce per lavorare sull’aspetto visivo? Alla fine non ho voluto cambiare le cose e sono rimasto sorpreso dal pubblico italiano: privato della comprensione letterale del testo, si è immerso nello spettacolo. Ha colto a fondo l’immagine.
E il tempo…
Certo il tempo. In fondo l’artista lavora sempre con le stesse cose, l’amore, il sesso e la morte. È il tempo che permette la sorpresa. Per questo uso sempre tempi molto lunghi, metto strati e livelli, proposte che si aprono autonomamente, se si aspetta. In questa pièce c’è una donna che prende il tempo. Che conosce il tempo.
Nel suo teatro colpisce la cura per i dettagli, la precisione chirurgica delle immagini
Il mio rapporto con i dettagli è quasi maniacale…non riesco a immaginare il teatro diversamente. Amo l’improvvisazione ma conto i passi che fa il mio attore…Sarà per questo che amo Mejerchol’d, il teatro teatrale, il teatro di convenzione. Credo che forse potrei inserirmi in questa linea. Amo molto Dario Fo e la sua costruzione della realtà dal nulla, la sua spazialità e il suo lavoro con la maschera. Quando ero giovane a Haiti …
Lei è giovane…
Ho 36 anni. Non sono giovane. Ad Haiti sono già della vecchia generazione a 36 anni, non tutti ci arrivano…Dunque quando ero giovane andavo tutti i giorni in biblioteca per leggere i maestri del teatro. Ad Haiti non passavano i loro spettacoli, ma le immagini mi facevano presagire il teatro che ho poi conosciuto in Europa. Ed è interessante vedere come in un paese come Haiti, dove non ci sono mezzi, si possa fare del teatro teatrale. Con la mia compagnia recitavamo con delle piccolissime scene mobili - delle quinte nere che l’attore portava con sé in mano - ovunque, nei mercati, nelle università. Cercavamo di andare verso le persone, di essere nella polis, ci consideravamo dei cittadini-attori, prima ancora di essere personaggi. I testi erano molto politici. Si trattava di interventi veloci, brevi. A volte eravamo invitati da un quartiere per creare uno spettacolo, una forma, su un tema da loro deciso. Il pubblico si appropria così del teatro che diventa una sorta di servizio civico.
I primi passi teatrali a Haiti sono stati fondamentali. Anche perché il pubblico dell’isola ha un rapporto stretto con tutto quello che è cerimoniale, è predisposto a scorgere nel teatro elementi ultra-terreni. In Repubblica Dominicana, quando arrivavamo vestiti in nero, la gente urlava “el diablo, el diablo”. Lavorare con questo pubblico mi ha obbligato a integrare tutto questo nel mio teatro. Anche le presenze che abitano la scena e i suoi fantasmi.
Cosa presenterà a Avignone?
De toute la terre è un lavoro sul corpo. Un corpo conteso tra il sotterraneo e lo stellare. Due donne contano le parole e le stelle, consapevoli della fortuna di essere in piedi su questa terra. E parlerà certamente del terremoto. Lo presenteremo all’aperto, in uno dei cortili storici di Avignone. |
|
 Il teatro musicale di Giacomo Cuticchio e del suo Ensemble Il teatro musicale di Giacomo Cuticchio e del suo Ensemble
di Silvia Mei
È un poema sinfonico quello composto da Giacomo Cuticchio per il suo Ensemble, cinque amici di medesima scuola musicale, quella del violoncellista Giovanni Sollima, nella Palermo di via Bara all’Olivella, dove ha sede l’antico teatro di famiglia. Dirimpetto al grandioso Teatro Massimo, la famiglia Cuticchio, da nonno Giacomo al nipote che continua la tradizione fin dal nome, mantiene accesa la fiamma di un’arte in via d’estinzione, quella dell’opra e del cunto, che hanno visto in Mimmo Cuticchio, puparo-cuntista di fama internazionale, padre del compositore, e puparo anch’esso, Giacomo, un momento di ricerca e sperimentazione in continuità coi dettami di un mestiere e di un artigianato non contraffabile e solo trasmissibile (www.figlidartecuticchio.com).
Giacomo Cuticchio percorre l’alveo segnato dal padre, avvinto dalla rutilanza delle gloriose armature dei cavalieri al seguito di Orlando (www.giacomocuticchio.it). A sette anni già manovrava piccoli pupi e negli spettacoli in cartellone azionava, come tutti i garzoni di bottega, la manovella del pianino a tamburo, colore e collante alle avventure delle Chansons de geste nelle musichette monocordi e meccaniche che sostituirono gli antichi sunatura, musici tradizionali diventati troppo costosi per le loro singole esecuzioni. cavalieri al seguito di Orlando (www.giacomocuticchio.it). A sette anni già manovrava piccoli pupi e negli spettacoli in cartellone azionava, come tutti i garzoni di bottega, la manovella del pianino a tamburo, colore e collante alle avventure delle Chansons de geste nelle musichette monocordi e meccaniche che sostituirono gli antichi sunatura, musici tradizionali diventati troppo costosi per le loro singole esecuzioni.
Oggi, appena trentenne, Giacomo, nello spirito di ricerca e sperimentazione di suo padre Mimmo, ha voluto fare dell’opra un’opera d’arte totale componendo musiche “a programma” per le diverse saghe, avventure, storie d’amore. Una musica “cavalleresca”, come la definisce lui stesso, dalle qualità non semplicemente o banalmente evocativo-narrative ma plastico-illustrative. Si potrebbe addirittura parlare di un affresco sinestetico godibile anche quando è sprovvisto del suo soggetto, vale a dire i pupi.
È questa infatti una delle possibilità con cui performa il Giacomo Cuticchio Ensemble che ha presentato in anteprima lo scorso 16 febbraio al Teatro di Santa Marta dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, laboratorio di giovani scritture sceniche alla prova col palco, l’inedita Rapsodia fantastica, una suite che riassume (sinesteticamente) un intero ciclo di rappresentazioni dell’opra facendo da colonna sonora al video-documentario di Chiara Andrich sul noto teatro di figura siciliano.
 Giacomo compone, suona il pianoforte e dirige il suo organico ma in altre occasioni manovra i pupi, a vista o dietro le quinte, lasciando ai compagni la partitura musicale da interpretare. E la scorsa sera ha offerto un concerto che era musica per gli occhi: oltre alla già citata Rapsodia anche Quaderno di danze e battaglie dell’Opera dei Pupi, in cinque quadri, che scandisce le diverse fasi del racconto dell’opra riproponendone anche le dinamiche. Come in taluni passaggi della narrazione il cuntista evoca una metrica e un ritmo che restituisce plasticamente il movimento scenico, le qualità visive, la partitura sonora di singolar tenzoni, battaglie, investiture e cortei, così la musica di Giacomo, appassionatamente eseguita dal suo Ensemble, traduce musicalmente queste qualità compositive: “i ritmi – spiega Giacomo – sono sostanzialmente importati dai passi delle marionette (binari o ternari), legati alle loro qualità meccaniche. Ma ci sono anche i ritmi del battito del piede e dello zoccolo dell’oprante al momento dei duelli. La battaglia fra due principi ha il ritmo dello squadrone in sette, quelle campali invece sono in tre. Nei Quaderni ho anche pensato ad un movimento più lungo per rilassare i nervi e l’orecchio dalle scene aspre dei duelli, proprio perché richiedono molta attenzione per lo spettatore alle strutture musicali. Si tratta in questo caso di una sorta di love song, per così dire. Ma non sto troppo attento alle forme musicali in sé, ciò da cui parto e su cui lavoro è il suono che mi conduce al ritmo”. Giacomo compone, suona il pianoforte e dirige il suo organico ma in altre occasioni manovra i pupi, a vista o dietro le quinte, lasciando ai compagni la partitura musicale da interpretare. E la scorsa sera ha offerto un concerto che era musica per gli occhi: oltre alla già citata Rapsodia anche Quaderno di danze e battaglie dell’Opera dei Pupi, in cinque quadri, che scandisce le diverse fasi del racconto dell’opra riproponendone anche le dinamiche. Come in taluni passaggi della narrazione il cuntista evoca una metrica e un ritmo che restituisce plasticamente il movimento scenico, le qualità visive, la partitura sonora di singolar tenzoni, battaglie, investiture e cortei, così la musica di Giacomo, appassionatamente eseguita dal suo Ensemble, traduce musicalmente queste qualità compositive: “i ritmi – spiega Giacomo – sono sostanzialmente importati dai passi delle marionette (binari o ternari), legati alle loro qualità meccaniche. Ma ci sono anche i ritmi del battito del piede e dello zoccolo dell’oprante al momento dei duelli. La battaglia fra due principi ha il ritmo dello squadrone in sette, quelle campali invece sono in tre. Nei Quaderni ho anche pensato ad un movimento più lungo per rilassare i nervi e l’orecchio dalle scene aspre dei duelli, proprio perché richiedono molta attenzione per lo spettatore alle strutture musicali. Si tratta in questo caso di una sorta di love song, per così dire. Ma non sto troppo attento alle forme musicali in sé, ciò da cui parto e su cui lavoro è il suono che mi conduce al ritmo”.
La scelta dei timbri è infatti del tutto “irregolare”:  un corno inglese (Mauro Vivona), due violoncelli (Francesco Biscari, Alessio Pianelli), il sax soprano e tenore (Nicola Mogavero), il pianoforte, strumenti usati al limite della loro identità timbrica ed esecutiva, secondo un uso percussivo e ripetitivo all’insegna del miglior minimalismo: “Philip Glass, Steve Reich, Meredith Monk, Michael Nyman sono astri di riferimento nel mio immaginario musicale accanto alla musica barocca”, rispetto alla quale risaltano immediatamente le affinità. un corno inglese (Mauro Vivona), due violoncelli (Francesco Biscari, Alessio Pianelli), il sax soprano e tenore (Nicola Mogavero), il pianoforte, strumenti usati al limite della loro identità timbrica ed esecutiva, secondo un uso percussivo e ripetitivo all’insegna del miglior minimalismo: “Philip Glass, Steve Reich, Meredith Monk, Michael Nyman sono astri di riferimento nel mio immaginario musicale accanto alla musica barocca”, rispetto alla quale risaltano immediatamente le affinità.
Un minimalismo, una serialità e ripetizione che richiamano il movimento meccanico della marionette, con la loro attitudine marziale, rigorosa e plastica, impersonale ma efficace, che ha segnato, come è noto, tutta la rifondazione teatrale del secolo scorso.
|
|
di Valentina Valentini
0. Introduzione
 Questa riflessione sul teatro di Emma Dante è mossa dall’interrogarsi sui motivi del successo – di critica e di pubblico – che gli spettacoli dell’autrice palermitana riscuotono. In che misura, vorrei tentare di comprendere, tale consenso è da ascriversi alla matrice locale inscritta come tratto distintivo del suo teatro e come tale “genius loci” siciliano declini l’estetica dei suoi spettacoli. Con il concetto di genius loci riconosciamo la creazione di un luogo mentale, di un dispositivo generatore di immagini e passioni che alimentano il mondo poetico di un autore. Un paesaggio particolare con la sua geografia, clima, aria, luce che si trasforma in spazio della rappresentazione. Per Heiner Müller, ad esempio, con la sua costante riflessione sulle due Germanie prima della caduta del muro, l'est è la civiltà, l'identità, mentre l'Ovest è la barbarie, la mancanza di identità. Secondo il suo ragionamento la Germania Est corrisponde al "locale" ( e alla forza e potere del teatro), mentre la Germania dell'Ovest al globale (alla forza e al potere dei media di massa). "[…]. l'attrazione che la Germania federale esercitava sui giovani, è motivata dal fatto che nell'Est cercano "quelle radici che la rivoluzione informatica ha completamente eliminato." Come si spiega che "i testi che vengono dalla Repubblica Federale sono linguisticamente più complessi e più densi, motivo per cui offrono maggior resistenza all'americanizzazione, alla cultura dell'usa e getta, all'unidimensionalità della produzione tedesco-occidentale, anche in campo artistico" (H. Müller, 1994. p. 137). Questa riflessione sul teatro di Emma Dante è mossa dall’interrogarsi sui motivi del successo – di critica e di pubblico – che gli spettacoli dell’autrice palermitana riscuotono. In che misura, vorrei tentare di comprendere, tale consenso è da ascriversi alla matrice locale inscritta come tratto distintivo del suo teatro e come tale “genius loci” siciliano declini l’estetica dei suoi spettacoli. Con il concetto di genius loci riconosciamo la creazione di un luogo mentale, di un dispositivo generatore di immagini e passioni che alimentano il mondo poetico di un autore. Un paesaggio particolare con la sua geografia, clima, aria, luce che si trasforma in spazio della rappresentazione. Per Heiner Müller, ad esempio, con la sua costante riflessione sulle due Germanie prima della caduta del muro, l'est è la civiltà, l'identità, mentre l'Ovest è la barbarie, la mancanza di identità. Secondo il suo ragionamento la Germania Est corrisponde al "locale" ( e alla forza e potere del teatro), mentre la Germania dell'Ovest al globale (alla forza e al potere dei media di massa). "[…]. l'attrazione che la Germania federale esercitava sui giovani, è motivata dal fatto che nell'Est cercano "quelle radici che la rivoluzione informatica ha completamente eliminato." Come si spiega che "i testi che vengono dalla Repubblica Federale sono linguisticamente più complessi e più densi, motivo per cui offrono maggior resistenza all'americanizzazione, alla cultura dell'usa e getta, all'unidimensionalità della produzione tedesco-occidentale, anche in campo artistico" (H. Müller, 1994. p. 137).
Per Franco Scaldati “[...] a Palermo comincia tutto e non finisce niente. Ma questo non finire non riguarda soltanto Palermo – la Sicilia – il Sud: riguarda tutta l'umanità, è il suo – è il nostro – problema. Scrivere di Palermo significa scrivere dell'uomo. Io scrivo dell'uomo e del suo rapporto irrisolto con la morte, con la fine delle cose. Probabilmente è più facile farlo a Palermo, tutto questo” (F. Scaldati, 1993, p. 39). Altrove afferma: "Napoli respira la commedia, noi respiriamo la tragedia. In Sicilia, a Palermo in particolare, tutto è mistero. Noi siamo legati da una matassa che è impossibile sciogliere. La nostra è la terra delle culture sconfitte, sconfitte perciò misteriose ,perciò trionfanti. Le nostre sono verità sapienziali, non sono mai verità definite come quelle delle culture vincenti, come le verità di quelle società dello sviluppo che oggi sembrano così livellate” (ibidem, p. 33).
|
|
Leggi tutto...
|
|
|


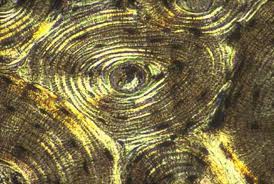 gli alla cultura (spettacolo e affini in primis) e recupero della territorialità (linguistica, economica, etc.), il Veneto potrebbe giustamente apparire come il rigurgito più acido del provincialismo italiano sulla scorta del Carroccio e del suo villaggio, di cui tutti ricordano l’esilarante presa nel 1997 del campanile di San Marco, con il cosiddetto tanco dei prodi padani che girava a vuoto nella piazza del Sansovino in attesa di una sommossa civile collettiva. Sappiamo tutti com’è finita, a disonor della storia (d’Italia).
gli alla cultura (spettacolo e affini in primis) e recupero della territorialità (linguistica, economica, etc.), il Veneto potrebbe giustamente apparire come il rigurgito più acido del provincialismo italiano sulla scorta del Carroccio e del suo villaggio, di cui tutti ricordano l’esilarante presa nel 1997 del campanile di San Marco, con il cosiddetto tanco dei prodi padani che girava a vuoto nella piazza del Sansovino in attesa di una sommossa civile collettiva. Sappiamo tutti com’è finita, a disonor della storia (d’Italia). Albero senza ombra
Albero senza ombra [a cura di
[a cura di  Il teatro musicale di Giacomo Cuticchio e del suo Ensemble
Il teatro musicale di Giacomo Cuticchio e del suo Ensemble cavalieri al seguito di Orlando (
cavalieri al seguito di Orlando ( Giacomo compone, suona il pianoforte e dirige il suo organico ma in altre occasioni manovra i pupi, a vista o dietro le quinte, lasciando ai compagni la partitura musicale da interpretare. E la scorsa sera ha offerto un concerto che era musica per gli occhi: oltre alla già citata Rapsodia anche Quaderno di danze e battaglie dell’Opera dei Pupi, in cinque quadri, che scandisce le diverse fasi del racconto dell’opra riproponendone anche le dinamiche. Come in taluni passaggi della narrazione il cuntista evoca una metrica e un ritmo che restituisce plasticamente il movimento scenico, le qualità visive, la partitura sonora di singolar tenzoni, battaglie, investiture e cortei, così la musica di Giacomo, appassionatamente eseguita dal suo Ensemble, traduce musicalmente queste qualità compositive: “i ritmi – spiega Giacomo – sono sostanzialmente importati dai passi delle marionette (binari o ternari), legati alle loro qualità meccaniche. Ma ci sono anche i ritmi del battito del piede e dello zoccolo dell’oprante al momento dei duelli. La battaglia fra due principi ha il ritmo dello squadrone in sette, quelle campali invece sono in tre. Nei Quaderni ho anche pensato ad un movimento più lungo per rilassare i nervi e l’orecchio dalle scene aspre dei duelli, proprio perché richiedono molta attenzione per lo spettatore alle strutture musicali. Si tratta in questo caso di una sorta di love song, per così dire. Ma non sto troppo attento alle forme musicali in sé, ciò da cui parto e su cui lavoro è il suono che mi conduce al ritmo”.
Giacomo compone, suona il pianoforte e dirige il suo organico ma in altre occasioni manovra i pupi, a vista o dietro le quinte, lasciando ai compagni la partitura musicale da interpretare. E la scorsa sera ha offerto un concerto che era musica per gli occhi: oltre alla già citata Rapsodia anche Quaderno di danze e battaglie dell’Opera dei Pupi, in cinque quadri, che scandisce le diverse fasi del racconto dell’opra riproponendone anche le dinamiche. Come in taluni passaggi della narrazione il cuntista evoca una metrica e un ritmo che restituisce plasticamente il movimento scenico, le qualità visive, la partitura sonora di singolar tenzoni, battaglie, investiture e cortei, così la musica di Giacomo, appassionatamente eseguita dal suo Ensemble, traduce musicalmente queste qualità compositive: “i ritmi – spiega Giacomo – sono sostanzialmente importati dai passi delle marionette (binari o ternari), legati alle loro qualità meccaniche. Ma ci sono anche i ritmi del battito del piede e dello zoccolo dell’oprante al momento dei duelli. La battaglia fra due principi ha il ritmo dello squadrone in sette, quelle campali invece sono in tre. Nei Quaderni ho anche pensato ad un movimento più lungo per rilassare i nervi e l’orecchio dalle scene aspre dei duelli, proprio perché richiedono molta attenzione per lo spettatore alle strutture musicali. Si tratta in questo caso di una sorta di love song, per così dire. Ma non sto troppo attento alle forme musicali in sé, ciò da cui parto e su cui lavoro è il suono che mi conduce al ritmo”. un corno inglese (Mauro Vivona), due violoncelli (Francesco Biscari, Alessio Pianelli), il sax soprano e tenore (Nicola Mogavero), il pianoforte, strumenti usati al limite della loro identità timbrica ed esecutiva, secondo un uso percussivo e ripetitivo all’insegna del miglior minimalismo: “Philip Glass, Steve Reich, Meredith Monk, Michael Nyman sono astri di riferimento nel mio immaginario musicale accanto alla musica barocca”, rispetto alla quale risaltano immediatamente le affinità.
un corno inglese (Mauro Vivona), due violoncelli (Francesco Biscari, Alessio Pianelli), il sax soprano e tenore (Nicola Mogavero), il pianoforte, strumenti usati al limite della loro identità timbrica ed esecutiva, secondo un uso percussivo e ripetitivo all’insegna del miglior minimalismo: “Philip Glass, Steve Reich, Meredith Monk, Michael Nyman sono astri di riferimento nel mio immaginario musicale accanto alla musica barocca”, rispetto alla quale risaltano immediatamente le affinità. Questa riflessione sul teatro di Emma Dante è mossa dall’interrogarsi sui motivi del successo – di critica e di pubblico – che gli spettacoli dell’autrice palermitana riscuotono. In che misura, vorrei tentare di comprendere, tale consenso è da ascriversi alla matrice locale inscritta come tratto distintivo del suo teatro e come tale “genius loci” siciliano declini l’estetica dei suoi spettacoli. Con il concetto di genius loci riconosciamo la creazione di un luogo mentale, di un dispositivo generatore di immagini e passioni che alimentano il mondo poetico di un autore. Un paesaggio particolare con la sua geografia, clima, aria, luce che si trasforma in spazio della rappresentazione. Per Heiner Müller, ad esempio, con la sua costante riflessione sulle due Germanie prima della caduta del muro, l'est è la civiltà, l'identità, mentre l'Ovest è la barbarie, la mancanza di identità. Secondo il suo ragionamento la Germania Est corrisponde al "locale" ( e alla forza e potere del teatro), mentre la Germania dell'Ovest al globale (alla forza e al potere dei media di massa). "[…]. l'attrazione che la Germania federale esercitava sui giovani, è motivata dal fatto che nell'Est cercano "quelle radici che la rivoluzione informatica ha completamente eliminato." Come si spiega che "i testi che vengono dalla Repubblica Federale sono linguisticamente più complessi e più densi, motivo per cui offrono maggior resistenza all'americanizzazione, alla cultura dell'usa e getta, all'unidimensionalità della produzione tedesco-occidentale, anche in campo artistico" (H. Müller, 1994. p. 137).
Questa riflessione sul teatro di Emma Dante è mossa dall’interrogarsi sui motivi del successo – di critica e di pubblico – che gli spettacoli dell’autrice palermitana riscuotono. In che misura, vorrei tentare di comprendere, tale consenso è da ascriversi alla matrice locale inscritta come tratto distintivo del suo teatro e come tale “genius loci” siciliano declini l’estetica dei suoi spettacoli. Con il concetto di genius loci riconosciamo la creazione di un luogo mentale, di un dispositivo generatore di immagini e passioni che alimentano il mondo poetico di un autore. Un paesaggio particolare con la sua geografia, clima, aria, luce che si trasforma in spazio della rappresentazione. Per Heiner Müller, ad esempio, con la sua costante riflessione sulle due Germanie prima della caduta del muro, l'est è la civiltà, l'identità, mentre l'Ovest è la barbarie, la mancanza di identità. Secondo il suo ragionamento la Germania Est corrisponde al "locale" ( e alla forza e potere del teatro), mentre la Germania dell'Ovest al globale (alla forza e al potere dei media di massa). "[…]. l'attrazione che la Germania federale esercitava sui giovani, è motivata dal fatto che nell'Est cercano "quelle radici che la rivoluzione informatica ha completamente eliminato." Come si spiega che "i testi che vengono dalla Repubblica Federale sono linguisticamente più complessi e più densi, motivo per cui offrono maggior resistenza all'americanizzazione, alla cultura dell'usa e getta, all'unidimensionalità della produzione tedesco-occidentale, anche in campo artistico" (H. Müller, 1994. p. 137).