|

[Silvia Mei] La Biennale Teatro apre sotto gli auspici (infausti?) della fresca e discussa nomina di Giulio Malgara a nuovo presidente della Biennale di Venezia nelle sue sei sezioni (Arte, Danza, Cinema, Musica, Teatro). Paolo Baratta, presidente uscente, aveva aperto la conferenza stampa sulla sezione teatrale parlando di Venezia come urbe modello per un laboratorio espanso, un progetto pedagogico e professionalizzante transdisciplinare, dall’Atelier della danza al Laboratorio internazionale delle arti sceniche che Àlex Rigola, direttore artistico della sezione teatro, regista catalano e dal 2003 direttore del teatro Lliure, ha fortemente voluto in preparazione e anche in contemporanea alla settimana di spettacoli che si è aperta il 10 ottobre 2011.
Sette registi affermati, provenienti da culture teatrali e ideologie differenti, con immaginari plastici e sensibilità artistiche polari – il nostalgico Ricardo Bartís, l’irriverente Calixto Bieito, l’iconoclasta Romeo Castellucci, l’incendiario Jan Fabre, il blasfemo Rodrigo García, l’eclettico Jan Lawers, l’algido Thomas Ostermeier – quasi emblemi di sette peccati capitali, hanno lavorato con gruppi di attori, ricercatori, tecnici, operatori entrando nelle fibre dei processi scenici: ideazione, progettazione, messinopera, modalità di pensare la scena, percorrerne i margini, esplorarne i limiti, varcarne i confini. Si aggiungono così in coda i nuovi laboratori (www.labiennale.org/it/teatro/laboratori2011/), paralleli alla settimana di spettacoli, con Stefan Kaegi/Rimini Protokoll, battitore di tracce urbane; i due danzattori Virgilio Sieni e Josef Nadj, diversamente figurativi, dove il corpo è il fantasma di un’azione sospesa in atmosfere rarefatte. E ancora il workshop di live video di Àlex Serrano, di illuminotecnica con Carlos Marquerie, di recitazione del verso scespiriano condotto da Will Keen e María Fernández Ache.
La celebrazione d’apertura ha consegnato il Leone d’oro a Thomas Ostermeier, dal 2004 direttore della Schaubühne, un regista capace di lavorare tra passato e presente rendendo futuribile i classici. Per la Biennale propone appunto l’allestimento scespiriano, Hamlet, debuttato al festival d’Avignon nel 2008, in sola rappresentazione lunedì 10 ottobre. L’algido tedesco, di cui ricordiamo il livido John Gabriel Borkman, passato in Italia recentemente, ricorda nel suo discorso di ringraziamento la resistenza di teatri italiani come il Valle a Roma e il teatro Marinoni a Venezia dedicando ai suoi attori, al suo ensemble, il premio veneziano. Leone d’argento invece ai Rimini Protokoll, collettivo svizzero di registi, sound designer, drammaturghi, video maker guidata da Stefan Kaegi, tra le più innovative realtà di drammaturgia contemporanea capace di performare la vita nel filtro dei differenti dispositivi che la comunicano.
La settimana di spettacoli prosegue dall’11 al 16 ottobre con due sezioni: la Young Italian Brunch, ideata dai curatori Carlo Mangolini ed Enrico Bettiniello, in orario prandiale che vede come protagonisti rappresentativi gruppi della nouvelle vague italiana,  Santasangre, Teatropersona, Anagoor, Muta Imago, ricci/forte; e la sezione dei maestri che, dopo l’apertura di Ostermeier, vede un vero e proprio duello tra due temperature teatrali, quella latina di Bartís, Bieito, García e quella nordica di Fabre/Troubleyn, Lauwers/Needcompany, Kaegi, cui si accoda nell’estetica glaciale e cristallina Romeo Castellucci (www.labiennale.org/it/teatro/programma2011/). Santasangre, Teatropersona, Anagoor, Muta Imago, ricci/forte; e la sezione dei maestri che, dopo l’apertura di Ostermeier, vede un vero e proprio duello tra due temperature teatrali, quella latina di Bartís, Bieito, García e quella nordica di Fabre/Troubleyn, Lauwers/Needcompany, Kaegi, cui si accoda nell’estetica glaciale e cristallina Romeo Castellucci (www.labiennale.org/it/teatro/programma2011/).
Significativa la presenza di due danzattori e coreografi fuori classe, Virgilio Sieni e Josef Nadj, che propongono un teatrodanza non etichettabile, difficilmente contraffabile, indice dell’opportunità di travalicare i generi e rompere i confini.
Tutti i giorni mattina e tardo pomeriggio incontri-intervista non solo con gli autori-registi ma anche con gli artefici dello spazio scenico, quali l’architetto Jan Pappelbaum, la scenografa Margherita Palli e Nick Ormerod, i designer Anne Viebrock e Jim Clayburgh, co-fondatori in alcuni casi degli ensemble e coautori delle regie in programma.
Festa conclusiva sabato 16 ottobre con un attraversamento dalle 11 alle 22 negli esiti spettacolari dei sette laboratori.
|
|
Leggi tutto...
|
|
 Tratti di poetica di Plumes dans la tête. Tratti di poetica di Plumes dans la tête.
[a cura di Adele Cacciagrano] Si è conclusa il 4 settembre la XVIII edizione di Crisalide, il festival curato e organizzato da Masque Teatro a Forlì che della propria sede ha fatto il punto diramante di produzioni spettacolari e visioni teorico-diagonali sul dispiegarsi del concetto di normalizzazione e alienazione nelle pratiche artistiche del contemporaneo. Silvia Costa/Plumes dans la tête, compagnia che ha potuto beneficiare di un periodo di residenza durate il Festival, spiega come questi due concetti vengano declinati costantemente all’interno dei suo lavori e, in particolare, in Stato di grazia, secondovolet del progetto Formazione Pagana e ultmio lavoro della compagnia nato proprio nellasede dei Masque a Forlì.
Nei tuoi lavori c’è sempre una tensione tra una spinta matriciale della figura a rimanere nell’apertura informe e la necessità di agguantare, a volte letteralmente fasciandola, la figura umana. Come si esprime questa doppia tensione aperto/chiuso nel trittico di Formazione Pagana?
Avverto un continuo bisogno di sfuggire. Forse è per questa ragione che nei lavori fatti finora c’è sempre un senso di divisione e di cesura, un senso del doppio che si traduce in un affermare e negare tanto la contraddizione quanto i significati e i dati acquisiti e certi come la consistenza della figura umana.
In Formazione Pagana c’è la volontà di accostare qualcosa di grezzo, materico, a qualcosa di sublime. Accostare. Comporre. Ci sono in Insorta Distesa, prima tappa di Formazione Pagana, dei cocci informi di gesso che fanno insorgere un corpo, una nascita gloriosa, aurea. C’è in Stato di Grazia l’idea di una deviazione, spaziale e mentale di una vita illuminata da un fondo d’oro. Non si tratta di una manifestazione metafisica. Piuttosto di uno stupore come quello che si prova davanti alla visione di un’icona dove la figura emerge, misteriosamente e potentemente, dal fondo oro che la illumina. Mi colpisce la semplicità dei tratti delle icone: pochi, ma chiari e netti. Precisi. Della stessa precisione e nettezza che cerco di raggiungere nei miei lavori.
In che modo hai trattato i gesti e le vite tratteggiate da Richard von Krafft-Ebing nel suo Psychopathia sexualis per renderli elementi corruttori dell’oro e portatori di una storia infame?
A volte usare un elemento come simbolo è la chiave per aggirarlo e portare quel senso misterioso che non si dà completamente e, pur tuttavia, si coglie. Per la composizione di Stato di Grazia ho letto tutti i casi registrati da Krafft-Ebing e ne ho composto uno in cui emergesse un’idea della deviazione assiomatica, slegata, cioè, da un particolare carattere sessuale. Poi, ho cercato di rendere scenicamente concreta la deviazione di questa vita cosicché il mio corpo è effettivamente inclinato di 45° contro il muro, sono appoggiata ad esso rigidamente: come un oggetto; come un pezzo di legno.
In questo dissidio oro-tenebra, luce-buio, il suono che tipo di tessitura cromatica costituisce?
Anche il suono sottostà allo stesso bisogno di sfuggire, in continuazione. Nella composizione del suono, abbiamo cercato di evitare la struttura del crescendo per cercare, piuttosto, la strada della trasformazione del suono e giocare sulla sua finzione di darsi. Nella parte testuale, Lorenzo Tomio ed io abbiamo lavorato sull’idea di suoni concreti d’ambiente i quali hanno il potere di inserire immediatamente lo spettatore in un dubbio ( sono suoni volontari o accidentali?). Generare questo tipo di dubbio era ciò che ci interessava, così come ci interessava avere un contesto concreto che nessun suono registrato ci avrebbe mai concesso. Da parte mia, desideravo che il testo fosse anch’esso un oggetto come uno di quegli oggetti di scena che vengono continuamente mossi e maneggiati. Per questo il testo è dato tutto d’un fiato, in un monoblocco in cui non succede nient’altro fuorché questo darsi incessante del testo. il testo è dato tutto d’un fiato, in un monoblocco in cui non succede nient’altro fuorché questo darsi incessante del testo.
Per le parti visive, invece, il suono ha la stessa densità del colore: dà la temperatura emotiva di quello che accade. Il momento dell’oro, per esempio, si manifesta con una musica liberatoria in cui il fuoco di una pira, assolutamente fuori misura e falsa, è uno scoppiettare di legni che si trasforma in danza tribale: battito di tamburi che risveglia la terra colpendola al suo centro.
|
|
Leggi tutto...
|
|
La deriva iconografica e i limiti della rappresentazione in The Dead di Città di Ebla

[Silvia Mei] A B.Motion teatro (all’interno di Operaestate festival veneto) di Bassano del Grappa ha debuttato The Dead del collettivo forlivese Città di Ebla, che dopo l’abbozzo del 2010 per Romaeuropa Festival resetta tutto (o quasi tutto) e reinventa il medium: teatrale e fotografico.
Che lo scatto fotografico sia in qualche modo connesso alla morte, ne aveva reso conto con acume teorico Susan Sontag nell’aureo libretto Sulla fotografia (tr. it. 1978) - è del resto con lo stesso termine inglese “trigger” che si indica il grilletto (di armi da fuoco) e lo scatto dell’otturatore: “Come la macchina fotografica è una sublimazione della pistola, fotografare qualcuno è un omicidio sublimato”. E Roland Barthes in La camera chiara (tr. it. 1980) si spinse a rappresentare la “Fotografia” come “una micro-esperienza della morte (della parentesi): io divento veramente spettro”. È per di più noto come i primi atelier degli scrittori della luce fossero en plein air, cimiteriali set inondati di sole, riflesso dal lucore del bianco scenario.
Si è così agglutinato intorno a queste pratiche spettrali e mortifere tutto un immaginario ad uso e consumo della fantasia letteraria e cinematografica. Come non pensare all’algido Jude Law nel film Era mio padre (Sam Mendes, 2002), per un personaggio bianchiccio e viscido, Maguire The Reporter, che Barthes avrebbe a buon diritto appellato “agente della morte”: un sicario della mafia di Chicago con l’orrida perversione di immortalare le proprie vittime appena colpite e spiranti, cioè nell’attimo in cui la morte si imprime sul loro volto.
Ora, la relazione tra teatro e fotografia è quantomeno paradossale in ragione delle qualità intrinseche alle due arti: se la fotografia congela il tempo, è uno “specchio del passato” (Proust) e uno strumento di conservazione della memoria, il teatro è il regno dell’effimero, della smaterializzazione, della dissipazione e dispersione dell’immagine e dei contenuti che mette in forma sulla scena. Come far convergere delle modalità così diverse di re-invenzione della realtà? Non si tratta di affrontare l’annoso dibattito sulla fotografia teatrale e le sue estetiche/pratiche. Si tratta di sciogliere nella scrittura scenica il paradosso dei due linguaggi. Una brillante proposta è la trilogia Motel del gruppo nanou, che ha lavorato, a partire dal 2008 fino al recente Anticamera, sulla fotografia figurativa atlantica e continentale calata nel filtro della spy story, del thriller-giallo-noir con assenza di trama (il soggetto è deposto in quanto non identificabile): qui la danza è motore di situazioni e atmosfere, e la drammaturgia, dal taglio cinematografico, è affidata alla sparizione di oggetti, corpi e pezzi di corpi celati da un fashion design.
Città di Ebla propone invece un’operazione diversamente complessa che, dopo un primo studio per Romaeuropa Festival, giunge ad una second edition di The Dead, liberamente ispirato a I morti di James Joyce, racconto conclusivo della raccolta Dubliners (1914), e in continuità col progetto scenico-letterario avviato dal collettivo con Metamorfosi (da Franz Kafka) nel 2009. Intertestualmente non mancano tra l’altro consonanze estetiche e strutturali di The Dead con l’allestimento del romanzo breve kafkiano, a partire dalla texture e qualità dell’immagine, con un taglio fortemente cinematografico (pensiamo al poliedrico bagno di Samsa collocato di sbieco, alla Tintoretto), esplorando un’inedita soluzione dei rapporti tra le due arti apparentemente in conflitto: cinema e teatro. La riflessione sulle forme della fabula e dell’intreccio affrontate liberamente da Ebla nelle scelte di cadrage, piano, obiettivo, taglio, aprono nuove modalità di enunciazione visiva per quello che ho altrove definito “teatro iconografico” o teatro della visione: “la visione è il darsi dell’immagine, il suo non ancora, la cui funzione di completamento e comprensione è rilanciata al fruitore” (cfr. catalogo della stagione La Soffitta 2011)

The Dead, nell’ideazione di Claudio Angelini, depensa la tranquilla storia familiare di Gabriel e Gretta la quale, di ritorno dall’annuale ballo natalizio in casa delle zie, vive l’irruzione imprevista e lacerante dei ricordi e dei fantasmi del passato che risignificano la “monotona” vita matrimoniale dei due congiunti: “Adesso non lo angustiava quasi più pensare quale misera parte aveva avuto lui, il marito, nella sua esistenza. La osservò mentre dormiva come se non avessero mai vissuto insieme, da marito e moglie”. Il progetto scenico non vuole, come anche è stato per l’adattamento kafkiano, una sterile illustrazione della vicenda perfettamente svolta da Joyce, tantomeno questi funge da mera ispirazione per la scena. Al contrario, il lavoro declina l’iconografia linguistica del testo, usato come uno spazio letterario, selezionando tracce e scarti di parole per la ricomposizione scenica: le lampade a gas, note per luce fredda che genera spettrali effetti sugli oggetti, le ombre che celano i volti e appaiono sotto i lampioni, l’ambientazione borghese di una middle class intellettuale e impegnata diventano nello stage curato dalla minuziosa Elisa Gandini - ideatrice anche del bagno in vitro di Metamorfosi, la scatola della trasformazione di Alessandro Bedosti/Gregorio Samsa - una camera da letto con dettagli neoromantici, compresa la specchiera a oscillazione di Gretta e un manichino belle époque. Ad abitarla è la performer Valentina Bravetti, un’ombra fra le ombre per la sua speciale silhouette, che come una figurina di Folon sfila abiti, fuma sigarette e beve un calice di vino su una selezione di songs da Janin Joplin. È una scena profonda e ampia filtrata da una quarta parete dove sembrano disegnarsi i contorni di un teatro delle ombre, quasi in negativo: di quel décor e della figura femminile che vi agisce vediamo un controluce, contorni neri, vuoti bianchi, trasparenze in gradazione di grigio sullo sfondo di un bagliore progressivamente iridale.
Poi, l’irruzione del passato: una foto trovata per caso sotto il letto e un fermo immagine, un congelamento in posa, su cui la musica diegetica della Joplin viene inghiottita da un sibilo metallico che si stempera nella grana sonora – un “cecchinaggio” melodico non esente da autocannibalismo - di Davide Fabbri/Elicheinfunzione. Inizia la seconda parte, oserei dire astratta, in paragone all’ipernaturalismo umbratile della premessa. Ora, quell’atelier così apertamente disposto, realisticamente visibile nel taglio frontale di prima, scompare, diventa o-sceno: allo sguardo voyeuristico del pubblico si sostituisce quello di un terzo incomodo - un fantasma, un morboso spione, un narratore senza volto dallo sguardo attrezzatissimo di Laura Arlotti, finissima e sensibile fotografa teatrale, che diventa il secondo agente in scena. Con la sua Nikon, dotata di silenziatore, inizia una doppia operazione di (s)montaggio e colorazione: alla visione intera della scena e dell’azione, si sostituiscono, proiettati sul velario-diaframma, gli scatti real time dell’Arlotti che scompone l’evoluzione scenica, nascosta al pubblico, nei dettagli e nelle messe a fuoco della partitura della performer, restituendo finalmente un colore alla realtà scenica. La fotografa, di cui si apprende la presenza solo agli applausi, è l’ocularità su cui scorre il dramma del ricordo della giovane donna e che marca il ritmo nella successione di indizi visivi: così come una scena del crimine è documentata dagli scatti del reporter.
In questa direzione, quella della scena criminale e della “realtà superstite” che essa deposita, si colloca il lavoro concettuale di Citta di Ebla, che espone la rappresentazione ad un superamento nella forma proposta dalla studiosa Francesca Gasparini (cfr. “Culture Teatrali”, n. 18, primavera 2008) di “iper-rappresentazione o rappresentazione metafisica”, ovvero “forme di rappresentazione potenziata o al contrario rarefatta che mettono in campo la realtà bruta […], come fatto spettacolare che non racconta il reale ma un’assenza”. Si domanda appunto Gasparini: “Che cosa diventano gli oggetti personali, i luoghi del vissuto nel momento in cui cade su di loro la maschera della morte, quando non possono più essere distinti dalle macchie e dai segni che la morte ha lasciato su di essi, quando, allo sguardo di uno spettatore esterno sono tutti pezzi di una realtà superstite?”.

Ed è con una morte, quella di J.F. Kennedy, che si apre uno degli scritti meno citati di Pier Paolo Pasolini, Osservazioni sul piano-sequenza (1967, ora in Empirismo eretico), che può funzionare da barra teorica e da cartina di tornasole per l’operazione di Città di Ebla. La visione di Pasolini è in certo qual modo antitetica alla soluzione disgregante di Gasparini, nella misura in cui per il critico e cineasta è solo la morte, redentrice, a restituire senso alla vita, un lungo infinito piano sequenza interpretato a posteriori dal montaggio. Partire dalla morte del presidente d’America - uno shock visivo per la diffusione live di una sorta di snuff movie – vale soprattutto per fare considerazioni politiche (più avanti il riferimento è a Lenin) calate in una metafisica del linguaggio e del tempo: la realtà accade nel presente, è sempre al tempo presente, così come il piano-sequenza è una soggettiva che riproduce la realtà vista e udita nel suo accadere (che in The Dead è la prima parte naturalistica, visivamente frontale e narrativamente lineare). I piani sequenza di una certa realtà sono tanti quante le soggettive, continua Pasolini, cioè i punti di vista che la registrano mentre si esprime (nello spettacolo in questione gli sguardi delle singolarità del pubblico diversamente collocato in sala). Ora, la coordinazione dei diversi punti di vista, il montaggio, trasforma il presente in passato (il montaggio dei diversi sguardi dell’Arlotti proiettati sul velario): “In seguito al lavoro di scelta e coordinazione, i vari angoli visuali si dissolverebbero, e la soggettività, esistenziale, cederebbe il posto all’oggettività: […] al loro posto ci sarebbe un narratore. Questo narratore trasforma il presente in passato”. Per arrivare a concludere: “Allora qui devo dire che cosa io penso della morte (e lascio liberi i lettori di chiedersi, scettici, che cosa c’entri questo col cinema). […] L’uomo si esprime soprattutto con la sua azione […] perché è con essa che modifica la realtà e incide nello spirito. Ma questa sua azione umana manca di unità, ossia di senso, finché essa non è compiuta. […] finché siamo vivi, manchiamo di senso, e il linguaggio della nostra vita […] è intraducibile: un caos di possibilità, una ricerca di relazioni e di significati senza soluzione di continuità. […] Solo grazie alla morte, la nostra vita ci serve ad esprimerci”.
Cos’è dunque The Dead: il caos della vita e la compiutezza data dalla morte; oppure è il lenzuolo bianco, una veronica, sui corpi assassinati, i contorni-simulacri di oggetti asportati da una scena del crimine dove la morte ha seminato scompiglio in un’esistenza ordinata e limpida?
Joyce ci risponde, a suo modo: “C’era neve dappertutto in Irlanda. Cadeva ovunque […]. E la sua anima gli svanì adagio adagio nel sonno mentre udiva la neve cadere lieve sull’universo, inesorabilmente lieve cadere, come la discesa della loro estrema fine, sui vivi e sui morti”.
|
|
 (La rivolta adolescente, Motus/Anagoor, Castelfranco Veneto 4, 5, 7 agosto 2011) (La rivolta adolescente, Motus/Anagoor, Castelfranco Veneto 4, 5, 7 agosto 2011)
[Monica Cristini] Parto dalla conclusione di questo spettacolo, che attraverso la documentazione della rivolta studentesca avvenuta in Grecia nel 2008, sottolinea l’attualità della tragedia e la presenza di un’Antigone in ogni giovane che sta lottando per riprendersi il futuro di cui è stato derubato.
‘Creonte non è mai uscito di scena’ e non esce di scena nemmeno oggi, perché i ragazzi in rivolta gli servono per avere un nemico e distogliere l’attenzione. E’ attuale questo Re-Stato che, accecato dal potere ma spaventato dalla presa di coscienza di tanti giovani, preferisce sempre e comunque continuare a mantenere uno stato di cose che per loro non prevede futuro. Chi è allora Antigone? Con il coraggio di affrontare un argomento così attuale e tanto delicato, Motus indaga sulle numerose Antigoni che oggi stanno lottando: lo è Alexandra Sarantopoulou, giovane artista greca che ha vissuto in prima persona quei giorni del 2008 ad Exarchia - il quartiere di Atene infiammato dalla protesta - e lo è Silvia Calderoni sul palcoscenico, insieme protagonista e narratore dello spettacolo.  Lo sono i molti giovani, studenti e lavoratori, che stanno protestando ancora in Grecia ma anche in Spagna e in Italia: giovani che non si fermano davanti alla censura della stampa e alle mancate risposte dei governi e testimoniano con la loro presenza la volontà di cambiamento e di fare qualcosa di concreto per riprendersi il futuro, attraverso la consapevolezza, la voglia e l’urgenza di cambiare il presente. E’ più che mai attuale il dialogo intavolato da Motus con Alexis. Una tragedia greca (ultimo lavoro nato all’interno del progetto Syrma Antigónes), spettacolo che nel suo sezionare la tragedia greca coglie l’occasione per documentare la rivolta che ha visto l’uccisione di Alexis (Alexandros-Andreas Griroropoulos), il giovane quindicenne ucciso da un poliziotto nel 2008, diventato simbolo e allo stesso tempo archetipo della lotta studentesca. Nel corso dello spettacolo, attraverso la testimonianza di Alexandra e le parole di Silvia-Antigone, si arriva però alla conclusione che il fulcro non è solo la morte di Alexis-Polinice, ma anche ciò che essa ha provocato. Gli attori non sono interpreti della lotta, ma la incarnano diventandone - come Alexis e come Antigone - traccia, segno tangibile e allo stesso tempo testimoni di un malessere ormai diffuso in questi anni di crisi. Lo sono i molti giovani, studenti e lavoratori, che stanno protestando ancora in Grecia ma anche in Spagna e in Italia: giovani che non si fermano davanti alla censura della stampa e alle mancate risposte dei governi e testimoniano con la loro presenza la volontà di cambiamento e di fare qualcosa di concreto per riprendersi il futuro, attraverso la consapevolezza, la voglia e l’urgenza di cambiare il presente. E’ più che mai attuale il dialogo intavolato da Motus con Alexis. Una tragedia greca (ultimo lavoro nato all’interno del progetto Syrma Antigónes), spettacolo che nel suo sezionare la tragedia greca coglie l’occasione per documentare la rivolta che ha visto l’uccisione di Alexis (Alexandros-Andreas Griroropoulos), il giovane quindicenne ucciso da un poliziotto nel 2008, diventato simbolo e allo stesso tempo archetipo della lotta studentesca. Nel corso dello spettacolo, attraverso la testimonianza di Alexandra e le parole di Silvia-Antigone, si arriva però alla conclusione che il fulcro non è solo la morte di Alexis-Polinice, ma anche ciò che essa ha provocato. Gli attori non sono interpreti della lotta, ma la incarnano diventandone - come Alexis e come Antigone - traccia, segno tangibile e allo stesso tempo testimoni di un malessere ormai diffuso in questi anni di crisi.
In uno spazio in continua metamorfosi, l’azione si sviluppa su diversi livelli che escono dalla diegesi della narrazione per coinvolgere il pubblico ed inglobare nello spazio drammaturgico i muri e le piazze di Exarchia.  La narrazione prosegue attraverso le immagini-soggettive proiettate da Silvia Calderoni, ma anche nella sala e in strada, naturali prolungamenti di un’azione che, nata in piazza, si allarga sul palcoscenico per espandersi poi tra il pubblico ed infine fuori del teatro. Quella di Alexis è un’azione che si dispiega su più livelli - in uno scambio dialettico tra attori e con lo spettatore, in ‘una ricerca in continua oscillazione fra memoria e presente’ – attraverso la composizione di un testo a più voci fatto di dialoghi, video-documenti, frammenti audio, ricordi, testimonianze, descrizioni di luoghi, atmosfere e situazioni. Quasi un canone, lo spettacolo si costruisce sul dispiegarsi ed evolversi delle prime tracce che si arricchiscono di sempre nuovi tasselli, in quella che diviene via via un’azione corale il cui ritmo è sottolineato da frammenti sonori. Un’opera che ben riesce ad imprimere nella mente dello spettatore quelle tracce di storia, passata e presente, raccolte e raccontate con pochi ma ben orchestrati mezzi, ‘una scelta di principio fortemente coerente con l’anima del percorso tutto: un viaggio con Antigone lontano dagli sprechi dei palazzi’. La narrazione prosegue attraverso le immagini-soggettive proiettate da Silvia Calderoni, ma anche nella sala e in strada, naturali prolungamenti di un’azione che, nata in piazza, si allarga sul palcoscenico per espandersi poi tra il pubblico ed infine fuori del teatro. Quella di Alexis è un’azione che si dispiega su più livelli - in uno scambio dialettico tra attori e con lo spettatore, in ‘una ricerca in continua oscillazione fra memoria e presente’ – attraverso la composizione di un testo a più voci fatto di dialoghi, video-documenti, frammenti audio, ricordi, testimonianze, descrizioni di luoghi, atmosfere e situazioni. Quasi un canone, lo spettacolo si costruisce sul dispiegarsi ed evolversi delle prime tracce che si arricchiscono di sempre nuovi tasselli, in quella che diviene via via un’azione corale il cui ritmo è sottolineato da frammenti sonori. Un’opera che ben riesce ad imprimere nella mente dello spettatore quelle tracce di storia, passata e presente, raccolte e raccontate con pochi ma ben orchestrati mezzi, ‘una scelta di principio fortemente coerente con l’anima del percorso tutto: un viaggio con Antigone lontano dagli sprechi dei palazzi’.
All’interno della rassegna, lo stesso venerdì 5 agosto, Anagoor ha presentato la prim a parte del progetto FORTUNY, Augurami Fortuna (le altre due parti del progetto, Con la virtù come guida e la fortuna per compagna e How much fortune can we make? sono state protagoniste del programma di domenica 7 agosto). ‘'FORTUNY non è un progetto teatrale attorno alla figura di Mariano Fortuny, ma di lui assume lo sguardo complesso sulla preziosa delicatezza di Venezia con l’intento di catturare il cuore del suo fervente lavoro sulla catalogazione della memoria e sulla trasmissione delle forme e osservarlo come metafora di un intervento attivo in difesa di qualcosa di altrettanto prezioso che avvertiamo minacciato’. Queste le prime righe della presentazione per lo spettacolo che prende le mosse dall’episodio storico che, in una notte del 1500, vide distrutte tutte le gondole in Canal Grande: un gesto fortemente simbolico attuato da un gruppo di giovani veneziani che, così si narra, ammutolì l’intera città. Lo spettacolo, allestito nel cortile di Villa Revedin Bolasco (Castelfranco Veneto), si articola in due parti nettamente separate per modalità e mezzi impiegati. Un primo tempo vede l’interpretazione di un antico canto evocativo, eseguito da due cantanti con la sola voce senza il supporto di altro strumento, nella suggestiva cornice architettonica sottolineata da un sapiente uso della luce che evidenzia il chiaro-scuro delle forme. L’installazione site-specific unisce al tessuto sonoro due video che si compenetrano, diventando uno il prolungamento drammaturgico-spaziale dell’altro, quindi commento e al contempo prosecuzione, i cui protagonisti sono un gruppo di a parte del progetto FORTUNY, Augurami Fortuna (le altre due parti del progetto, Con la virtù come guida e la fortuna per compagna e How much fortune can we make? sono state protagoniste del programma di domenica 7 agosto). ‘'FORTUNY non è un progetto teatrale attorno alla figura di Mariano Fortuny, ma di lui assume lo sguardo complesso sulla preziosa delicatezza di Venezia con l’intento di catturare il cuore del suo fervente lavoro sulla catalogazione della memoria e sulla trasmissione delle forme e osservarlo come metafora di un intervento attivo in difesa di qualcosa di altrettanto prezioso che avvertiamo minacciato’. Queste le prime righe della presentazione per lo spettacolo che prende le mosse dall’episodio storico che, in una notte del 1500, vide distrutte tutte le gondole in Canal Grande: un gesto fortemente simbolico attuato da un gruppo di giovani veneziani che, così si narra, ammutolì l’intera città. Lo spettacolo, allestito nel cortile di Villa Revedin Bolasco (Castelfranco Veneto), si articola in due parti nettamente separate per modalità e mezzi impiegati. Un primo tempo vede l’interpretazione di un antico canto evocativo, eseguito da due cantanti con la sola voce senza il supporto di altro strumento, nella suggestiva cornice architettonica sottolineata da un sapiente uso della luce che evidenzia il chiaro-scuro delle forme. L’installazione site-specific unisce al tessuto sonoro due video che si compenetrano, diventando uno il prolungamento drammaturgico-spaziale dell’altro, quindi commento e al contempo prosecuzione, i cui protagonisti sono un gruppo di  adolescenti armati di mazze da baseball che si confrontano con i simboli della città attraverso una ‘performance rituale danzata del lutto come uno strumento di opposizione, unico mezzo per esercitare una rivendicazione’. adolescenti armati di mazze da baseball che si confrontano con i simboli della città attraverso una ‘performance rituale danzata del lutto come uno strumento di opposizione, unico mezzo per esercitare una rivendicazione’.
Spettacolo, quello di Anagoor, che nonostante si avvalga di ‘una drammaturgia per immagini che sceglie la forma dell’enigma perché, per paradosso, il pensiero sia più chiaro a chi vorrà ascoltare e vedere’, credo acquisti una maggiore fruibilità nella completezza della sua realizzazione, data la ricchezza e complessità del progetto FORTUNY e dell’azione drammaturgica che lo delinea.
|
|
|


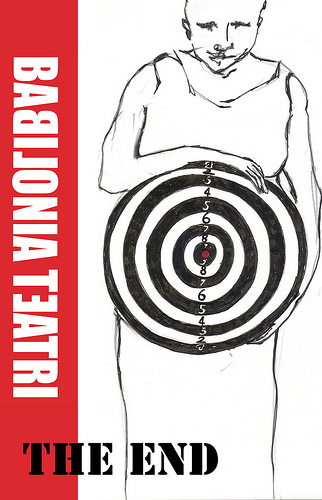 [
[
 e battute ma in realtà sono abili stilettate.
e battute ma in realtà sono abili stilettate.

 Santasangre, Teatropersona, Anagoor, Muta Imago, ricci/forte; e la sezione dei maestri che, dopo l’apertura di Ostermeier, vede un vero e proprio duello tra due temperature teatrali, quella latina di Bartís, Bieito, García e quella nordica di Fabre/Troubleyn, Lauwers/Needcompany, Kaegi, cui si accoda nell’estetica glaciale e cristallina Romeo Castellucci (
Santasangre, Teatropersona, Anagoor, Muta Imago, ricci/forte; e la sezione dei maestri che, dopo l’apertura di Ostermeier, vede un vero e proprio duello tra due temperature teatrali, quella latina di Bartís, Bieito, García e quella nordica di Fabre/Troubleyn, Lauwers/Needcompany, Kaegi, cui si accoda nell’estetica glaciale e cristallina Romeo Castellucci ( Tratti di poetica di Plumes dans la tête.
Tratti di poetica di Plumes dans la tête. il testo è dato tutto d’un fiato, in un monoblocco in cui non succede nient’altro fuorché questo darsi incessante del testo.
il testo è dato tutto d’un fiato, in un monoblocco in cui non succede nient’altro fuorché questo darsi incessante del testo. 


 (La rivolta adolescente, Motus/Anagoor, Castelfranco Veneto 4, 5, 7 agosto 2011)
(La rivolta adolescente, Motus/Anagoor, Castelfranco Veneto 4, 5, 7 agosto 2011) Lo sono i molti giovani, studenti e lavoratori, che stanno protestando ancora in Grecia ma anche in Spagna e in Italia: giovani che non si fermano davanti alla censura della stampa e alle mancate risposte dei governi e testimoniano con la loro presenza la volontà di cambiamento e di fare qualcosa di concreto per riprendersi il futuro, attraverso la consapevolezza, la voglia e l’urgenza di cambiare il presente. E’ più che mai attuale il dialogo intavolato da Motus con Alexis. Una tragedia greca (ultimo lavoro nato all’interno del progetto Syrma Antigónes), spettacolo che nel suo sezionare la tragedia greca coglie l’occasione per documentare la rivolta che ha visto l’uccisione di Alexis (Alexandros-Andreas Griroropoulos), il giovane quindicenne ucciso da un poliziotto nel 2008, diventato simbolo e allo stesso tempo archetipo della lotta studentesca. Nel corso dello spettacolo, attraverso la testimonianza di Alexandra e le parole di Silvia-Antigone, si arriva però alla conclusione che il fulcro non è solo la morte di Alexis-Polinice, ma anche ciò che essa ha provocato. Gli attori non sono interpreti della lotta, ma la incarnano diventandone - come Alexis e come Antigone - traccia, segno tangibile e allo stesso tempo testimoni di un malessere ormai diffuso in questi anni di crisi.
Lo sono i molti giovani, studenti e lavoratori, che stanno protestando ancora in Grecia ma anche in Spagna e in Italia: giovani che non si fermano davanti alla censura della stampa e alle mancate risposte dei governi e testimoniano con la loro presenza la volontà di cambiamento e di fare qualcosa di concreto per riprendersi il futuro, attraverso la consapevolezza, la voglia e l’urgenza di cambiare il presente. E’ più che mai attuale il dialogo intavolato da Motus con Alexis. Una tragedia greca (ultimo lavoro nato all’interno del progetto Syrma Antigónes), spettacolo che nel suo sezionare la tragedia greca coglie l’occasione per documentare la rivolta che ha visto l’uccisione di Alexis (Alexandros-Andreas Griroropoulos), il giovane quindicenne ucciso da un poliziotto nel 2008, diventato simbolo e allo stesso tempo archetipo della lotta studentesca. Nel corso dello spettacolo, attraverso la testimonianza di Alexandra e le parole di Silvia-Antigone, si arriva però alla conclusione che il fulcro non è solo la morte di Alexis-Polinice, ma anche ciò che essa ha provocato. Gli attori non sono interpreti della lotta, ma la incarnano diventandone - come Alexis e come Antigone - traccia, segno tangibile e allo stesso tempo testimoni di un malessere ormai diffuso in questi anni di crisi. La narrazione prosegue attraverso le immagini-soggettive proiettate da Silvia Calderoni, ma anche nella sala e in strada, naturali prolungamenti di un’azione che, nata in piazza, si allarga sul palcoscenico per espandersi poi tra il pubblico ed infine fuori del teatro. Quella di Alexis è un’azione che si dispiega su più livelli - in uno scambio dialettico tra attori e con lo spettatore, in ‘una ricerca in continua oscillazione fra memoria e presente’ – attraverso la composizione di un testo a più voci fatto di dialoghi, video-documenti, frammenti audio, ricordi, testimonianze, descrizioni di luoghi, atmosfere e situazioni. Quasi un canone, lo spettacolo si costruisce sul dispiegarsi ed evolversi delle prime tracce che si arricchiscono di sempre nuovi tasselli, in quella che diviene via via un’azione corale il cui ritmo è sottolineato da frammenti sonori. Un’opera che ben riesce ad imprimere nella mente dello spettatore quelle tracce di storia, passata e presente, raccolte e raccontate con pochi ma ben orchestrati mezzi, ‘una scelta di principio fortemente coerente con l’anima del percorso tutto: un viaggio con Antigone lontano dagli sprechi dei palazzi’.
La narrazione prosegue attraverso le immagini-soggettive proiettate da Silvia Calderoni, ma anche nella sala e in strada, naturali prolungamenti di un’azione che, nata in piazza, si allarga sul palcoscenico per espandersi poi tra il pubblico ed infine fuori del teatro. Quella di Alexis è un’azione che si dispiega su più livelli - in uno scambio dialettico tra attori e con lo spettatore, in ‘una ricerca in continua oscillazione fra memoria e presente’ – attraverso la composizione di un testo a più voci fatto di dialoghi, video-documenti, frammenti audio, ricordi, testimonianze, descrizioni di luoghi, atmosfere e situazioni. Quasi un canone, lo spettacolo si costruisce sul dispiegarsi ed evolversi delle prime tracce che si arricchiscono di sempre nuovi tasselli, in quella che diviene via via un’azione corale il cui ritmo è sottolineato da frammenti sonori. Un’opera che ben riesce ad imprimere nella mente dello spettatore quelle tracce di storia, passata e presente, raccolte e raccontate con pochi ma ben orchestrati mezzi, ‘una scelta di principio fortemente coerente con l’anima del percorso tutto: un viaggio con Antigone lontano dagli sprechi dei palazzi’. a parte del progetto FORTUNY, Augurami Fortuna (le altre due parti del progetto, Con la virtù come guida e la fortuna per compagna e How much fortune can we make? sono state protagoniste del programma di domenica 7 agosto). ‘'FORTUNY non è un progetto teatrale attorno alla figura di Mariano Fortuny, ma di lui assume lo sguardo complesso sulla preziosa delicatezza di Venezia con l’intento di catturare il cuore del suo fervente lavoro sulla catalogazione della memoria e sulla trasmissione delle forme e osservarlo come metafora di un intervento attivo in difesa di qualcosa di altrettanto prezioso che avvertiamo minacciato’. Queste le prime righe della presentazione per lo spettacolo che prende le mosse dall’episodio storico che, in una notte del 1500, vide distrutte tutte le gondole in Canal Grande: un gesto fortemente simbolico attuato da un gruppo di giovani veneziani che, così si narra, ammutolì l’intera città. Lo spettacolo, allestito nel cortile di Villa Revedin Bolasco (Castelfranco Veneto), si articola in due parti nettamente separate per modalità e mezzi impiegati. Un primo tempo vede l’interpretazione di un antico canto evocativo, eseguito da due cantanti con la sola voce senza il supporto di altro strumento, nella suggestiva cornice architettonica sottolineata da un sapiente uso della luce che evidenzia il chiaro-scuro delle forme. L’installazione site-specific unisce al tessuto sonoro due video che si compenetrano, diventando uno il prolungamento drammaturgico-spaziale dell’altro, quindi commento e al contempo prosecuzione, i cui protagonisti sono un gruppo di
a parte del progetto FORTUNY, Augurami Fortuna (le altre due parti del progetto, Con la virtù come guida e la fortuna per compagna e How much fortune can we make? sono state protagoniste del programma di domenica 7 agosto). ‘'FORTUNY non è un progetto teatrale attorno alla figura di Mariano Fortuny, ma di lui assume lo sguardo complesso sulla preziosa delicatezza di Venezia con l’intento di catturare il cuore del suo fervente lavoro sulla catalogazione della memoria e sulla trasmissione delle forme e osservarlo come metafora di un intervento attivo in difesa di qualcosa di altrettanto prezioso che avvertiamo minacciato’. Queste le prime righe della presentazione per lo spettacolo che prende le mosse dall’episodio storico che, in una notte del 1500, vide distrutte tutte le gondole in Canal Grande: un gesto fortemente simbolico attuato da un gruppo di giovani veneziani che, così si narra, ammutolì l’intera città. Lo spettacolo, allestito nel cortile di Villa Revedin Bolasco (Castelfranco Veneto), si articola in due parti nettamente separate per modalità e mezzi impiegati. Un primo tempo vede l’interpretazione di un antico canto evocativo, eseguito da due cantanti con la sola voce senza il supporto di altro strumento, nella suggestiva cornice architettonica sottolineata da un sapiente uso della luce che evidenzia il chiaro-scuro delle forme. L’installazione site-specific unisce al tessuto sonoro due video che si compenetrano, diventando uno il prolungamento drammaturgico-spaziale dell’altro, quindi commento e al contempo prosecuzione, i cui protagonisti sono un gruppo di  adolescenti armati di mazze da baseball che si confrontano con i simboli della città attraverso una ‘performance rituale danzata del lutto come uno strumento di opposizione, unico mezzo per esercitare una rivendicazione’.
adolescenti armati di mazze da baseball che si confrontano con i simboli della città attraverso una ‘performance rituale danzata del lutto come uno strumento di opposizione, unico mezzo per esercitare una rivendicazione’.