|
 Viaggio ai confini della visione Viaggio ai confini della visione
[Silvia Mei] Il Veneto è stato, nelle nostre ultime cronache, la scenografia di una vita teatrale, produttiva e organizzativa, molto feconda e partecipata. Procediamo in questo travelogue nostrano con l’ultima tratta, finale pirotecnico per la chiusura delle principali rassegne di teatro e danza.
Zaches Teatro è una rivelazione passata da ‘Anticorpi Explo’ (Giovane Danza d’Autore 09/10), vincitore della prima edizione del premio Prospettiva Danza Teatro - titolo del festival di respiro internazionale, orientato ai nuovi linguaggi coreutici, diretto da Laura Pulin a Padova dal 1998, all’interno del circuito Arteven (www.prospettivadanzateatro.it). In aderenza ai principi della rassegna, che esprime una visione globale dei fenomeni della scena oltre gli steccati disciplinari, ormai anacronistici per la nouvelle vague della scena italiana, Zaches Teatro (www.zachesteatro.it) porta avanti una ricerca capace di adeguarsi di volta in volta a nuovi soggetti. La compagnia, fondata tra le colline fiorentine nel 2006, nasce per l’appunto da una miscela di componenti linguistiche difformi (la danza contemporanea, il teatro di figura, sia d’ombre che di maschera, l’elaborazione di musica elettronica live) nelle figure di Luana Gramigna (responsabile  dell’impianto registico, sonoro e della composizione coreografica) e Francesco Givone (artifex dei dispositivi scenici e degli accessori). I due spettacoli in programma (15 e 16 aprile) procedevano proprio lungo la sottile linea d’ombra che demarca uno stacco, una cesura tra più territori: non si tratta di opere patinate o semplicemente ben fatte, Zaches è un gruppo giovanissimo altamente promettente, capace di governare e istruire la scena con sicurezza e talento. Il fascino dell’idiozia e Mal bianco costruiscono le prime due tappe del progetto “Trilogia della visione”, che trova un perfetto manifesto nella prima creazione, ispirata alle pinturas negras di Goya. Il sottotesto è appunto costituito dalla serie pittorica del pittore della modernità, il quale dipinge come in negativo, cioè sull’impressione della luce, che qui, nella trasposizione scenica, diventa un taglio inciso dal corpo dei performer in dialogo tra loro. Gli arti umani si riducono a pezzi componibili, snodabili, autosignificanti nell’immaginario ossario che si sviluppa in crescendo fino allo zoomorfismo di una figura taurina, un’ombra su fondo bianco che intreccia movenze flamenche. Mal bianco è invece il corrispettivo positivo della prima parte, un’allucinazione del non colore dagli abbacinanti effetti. In una scena che profuma di talco, dalla grana polverosa, dall’aspetto sulfureo, si muovono figure imbiaccate, vagamente butoh, in un corpo a corpo di guerrieri incorniciati e filtrati dalla retina del dispositivo fisso della trilogia, approntato secondo una metafora filmica nel velario che fa da diaframma e da protezione, da barriera e filtro per i nostri sguardi, come una palpebra sui nostri occhi. dell’impianto registico, sonoro e della composizione coreografica) e Francesco Givone (artifex dei dispositivi scenici e degli accessori). I due spettacoli in programma (15 e 16 aprile) procedevano proprio lungo la sottile linea d’ombra che demarca uno stacco, una cesura tra più territori: non si tratta di opere patinate o semplicemente ben fatte, Zaches è un gruppo giovanissimo altamente promettente, capace di governare e istruire la scena con sicurezza e talento. Il fascino dell’idiozia e Mal bianco costruiscono le prime due tappe del progetto “Trilogia della visione”, che trova un perfetto manifesto nella prima creazione, ispirata alle pinturas negras di Goya. Il sottotesto è appunto costituito dalla serie pittorica del pittore della modernità, il quale dipinge come in negativo, cioè sull’impressione della luce, che qui, nella trasposizione scenica, diventa un taglio inciso dal corpo dei performer in dialogo tra loro. Gli arti umani si riducono a pezzi componibili, snodabili, autosignificanti nell’immaginario ossario che si sviluppa in crescendo fino allo zoomorfismo di una figura taurina, un’ombra su fondo bianco che intreccia movenze flamenche. Mal bianco è invece il corrispettivo positivo della prima parte, un’allucinazione del non colore dagli abbacinanti effetti. In una scena che profuma di talco, dalla grana polverosa, dall’aspetto sulfureo, si muovono figure imbiaccate, vagamente butoh, in un corpo a corpo di guerrieri incorniciati e filtrati dalla retina del dispositivo fisso della trilogia, approntato secondo una metafora filmica nel velario che fa da diaframma e da protezione, da barriera e filtro per i nostri sguardi, come una palpebra sui nostri occhi.
Sono invece gli occhiali, il collante drammaturgico che lega i tempi di un’altra trilogia costruita sul difetto visivo, indice di una diversità e insieme di un surplus umano. Si tratta della Trilogia degli occhiali di Emma Dante (regista e autrice) - composta da Acquasanta, Il castello della Zisa, Ballarini - passata a Venezia lo scorso 18 aprile col solo Acquasanta, in chiusura della stagione del Teatro Universitario di Santa Marta (www.emmadante.it/trilogiaocchiali.html).
 Il trittico si muove su diverse unità di misura scenica, dal monologo al trio impiegando per ciascuna lingue e inflessioni differenti, profondamente legate alla cultura e vita artistica della regista palermitana: il napoletano, il “siciliano” e il francese (e così anche le co-produzioni sono riferibili ai tre contesti linguistici: Sud Costa Occidentale, Teatro Stabile di Napoli, Théâtre du Rond Point-Paris). Il trittico si muove su diverse unità di misura scenica, dal monologo al trio impiegando per ciascuna lingue e inflessioni differenti, profondamente legate alla cultura e vita artistica della regista palermitana: il napoletano, il “siciliano” e il francese (e così anche le co-produzioni sono riferibili ai tre contesti linguistici: Sud Costa Occidentale, Teatro Stabile di Napoli, Théâtre du Rond Point-Paris).
Acquasanta è un monologo – e qui la lingua è il napoletano di Carmine Maringola - che alterna una pluralità di voci e caratteri nell’isteria corporea di ‘o Spicchiato, figlio del mare, che con un bizzarro prodigio sputa schiuma salata. Il suo elemento primario è l’acqua, spruzzata a fontanella sulla platea, con non celato divertimento infantile, un liquido amniotico che rende fluido il suo agitarsi burattinesco (vagamente baracconesco) tra i caratteri marinari azionati da una istintualità e fisiologia meccanica contro-umana, non avara alla fine di sentimenti. Quelli appunto che uniscono in un sol corpo il mozzo - invecchiato sotto coperta, nelle violenze e soprusi dei compagni, o sognante sulla prua, ammorbato nell’immaginario romantico di un Titanic musicato in formato midi - alla sua nave, dalla quale teme un ingeneroso distacco. Ricorrono tutti gli stilemi della direzione attorica della Dante, che intreccia complessivamente una drammaturgia alquanto sfilacciata nei nodi che dovrebbero invece tenere saldi i tre “atti”, a partire dall’oggetto comune che li sottende, gli occhiali: l’organicità ributtante di corpi animati da nevrosi marionettistica giungono in Acquasanta ad un’iperbole scomposta e affettata che rende poco efficace l’azione di Maringola, potente e straordinariamente energico, che sembra quasi annaspare in quell’acqua da cui dovrebbe lasciarsi trasportare, quando non rincorre le battute sotto la spinta di quella costellazione di timer che lo sovrastano, letteralmente, e che come una bomba ad orologeria scattano quasi all’unisono.
Il tempo è scaduto e alla fine il nostro attore ringrazia, esce dalla sua barchetta-giocattolo e chiede un’offerta, nel cestino posto a prua. Lo spettacolo, malgrado gli applausi, poco convinti, non è ancora finito e chi non ha capito che era tutto finto, alla seconda potenza, passa a versare il proprio obolo, persuaso da un bravo napoletano che ci ha fatti fessi a tutti quanti.
 Riposa interamente sul corpo dello spettatore e sulle sue reazioni Edipo. Una Tragedia dei Sensi (per uno spettatore), del Teatro del Lemming, storico gruppo guidato dal regista e compositore Massimo Munaro con sede a Rovigo dal 1987 (www.teatrodellemming.com), che si è da sempre occupato di teatro a partecipazione, ovvero di una relazione teatrale dove il compito assegnato allo spettatore, quello di costruire lo spettacolo nel filtro della sua memoria emotiva, non è senza rischio e tantomeno passivo. Lo spettatore diventa partecipante, non semplice testimone (per quanto l’esercizio della testimonianza non sia meno impegnativo dell’esperienza fisica diretta) e vive col Lemming una stimolazione, di proustiana memoria, non meramente cerebrale: legata tanto all’elaborazione visiva dell’immagine scenica quanto alla sensorializzazione sinestetica del suo corpo. In genere, certe esperienze si sviluppano e si articolano lungo percorsi che riposano su sofisticate drammaturgie dove lo spettatore viene guidato da novelli Virgilio in un al di là che mette in crisi le normali coordinate di giudizio. Riposa interamente sul corpo dello spettatore e sulle sue reazioni Edipo. Una Tragedia dei Sensi (per uno spettatore), del Teatro del Lemming, storico gruppo guidato dal regista e compositore Massimo Munaro con sede a Rovigo dal 1987 (www.teatrodellemming.com), che si è da sempre occupato di teatro a partecipazione, ovvero di una relazione teatrale dove il compito assegnato allo spettatore, quello di costruire lo spettacolo nel filtro della sua memoria emotiva, non è senza rischio e tantomeno passivo. Lo spettatore diventa partecipante, non semplice testimone (per quanto l’esercizio della testimonianza non sia meno impegnativo dell’esperienza fisica diretta) e vive col Lemming una stimolazione, di proustiana memoria, non meramente cerebrale: legata tanto all’elaborazione visiva dell’immagine scenica quanto alla sensorializzazione sinestetica del suo corpo. In genere, certe esperienze si sviluppano e si articolano lungo percorsi che riposano su sofisticate drammaturgie dove lo spettatore viene guidato da novelli Virgilio in un al di là che mette in crisi le normali coordinate di giudizio.
Non è possibile comunicare convenzionalmente questa azione perché essa riposa sull’esperienza privata e soggettiva di ogni singolo spettatore che si è fatto fagocitare, letteralmente, dal buio di un caldo ventre materno. Edipo del Lemming non può essere raccontato, almeno non con pretese di oggettività e di verità, ma va piuttosto vissuto, cosa che auguriamo ai suoi mille (e più) spettatori per questa ripresa in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia, a 15 anni dalla prima realizzazione, attraverso il progetto pedagogico-spettacolare denominato L’Edipo dei Mille (a Venezia dal 27 aprile all’8 maggio in diverse location della città). Possiamo però entrare nel merito del trattamento del mito e della versione che di questa rappresentazione collettiva ci viene offerta.
Si tratta di far convergere nell’abusato mito del re di Tebe, un immaginario e un grappolo di storie che la struttura del mito calamita: il peccato originario nella fragranza odorosa della mela, transfert erotico di pulsioni inconsce; l’omicidio (del padre, del fratello, dei figli), nel pugnale che incide le mani dell’assassino con ferite indelebili; il desiderio di unioni promiscue e la relazione incestuosa con la madre; la derisione (cristica) e il rispecchiamento come (ri)scoperta di sé…Diverse tradizioni vanno a confluire nella storia greca, a partire dalla filiera giudaico-cristiana, per un percorso filogenetico e ontogenetico dell’uomo che il mito di Edipo, al centro di tanta risaputa psicoanalisi, raccoglie e conguaglia. Del resto, lo spettatore è il protagonista perchè diventa Edipo: bendato verrà trascinato dall’ineluttabile fato attraverso dolorose stazioni, le quali dall’esperienza della morte lo porteranno a ll’Enigma dello specchio, oggetto quantomeno polisemico, che potrebbe benissimo riportare l’epigrafe del tempio di Delfi : “Conosci te stesso”. Ancora più forza acquista il monito dell’oracolo quando il principale senso di orientamento e conoscenza del mondo viene meno: l’accecamento diventa allora un atto simbolico non solo rispetto ai contenuti specifici della vicenda di Edipo, ma un’operazione necessaria per l’attivazione di canali sensoriali del corpo, ottusi o addormentati. ll’Enigma dello specchio, oggetto quantomeno polisemico, che potrebbe benissimo riportare l’epigrafe del tempio di Delfi : “Conosci te stesso”. Ancora più forza acquista il monito dell’oracolo quando il principale senso di orientamento e conoscenza del mondo viene meno: l’accecamento diventa allora un atto simbolico non solo rispetto ai contenuti specifici della vicenda di Edipo, ma un’operazione necessaria per l’attivazione di canali sensoriali del corpo, ottusi o addormentati.
Forse che nella società dell’edonizzazione e della maniacale cura di sé, nel tempo dell’immagine e dello spettacolo, etimologicamente parlando, non siamo più in grado di vedere, non siamo più in grado di sentire?
|
|
 Il paese lontano è qui Il paese lontano è qui
[Silvia Mei] Ne abbiamo riferito non molto tempo fa in queste stesse pagine a proposito di un suo “solo”, Conferenza, narrazione performativa senza racconto, artatamente concettuale, di nobile ispirazione beniana. Si tratta di Roberto Corradino, per Reggimento Carri, una bellicosa formazione fondata nel 2000 occhieggiando al rovesciamento numerico di sala-scena, con sede a Bari, città che dà gli avi al nostro attore-autore (classe 1975) oggi anche regista. O meglio, orchestratore di cori di attori e giovani in formazione (pensiamo a Cuore_come un tamburo nella notte, dal romanzo omonimo di Edmondo de Amicis, per una coorte di venti presenze), cui attraverso Il censimento dell’attore del Polo Sud garantisce una preparazione professionale, non già una scuola - che per l’attore contemporaneo è essenzialmente autoformazione permanente.
Lo scorso 15 aprile abbiamo avuto l’occasione e il piacere di calare nelle Puglie per il suo Making of “Il Paese lontano” all’interno del progetto Face à face, rassegna alla sua quinta edizione che promuove un gemellaggio tra le drammaturgie d’Italia e di Francia. Un progetto che ha imposto, in Italia quanto meno, una rinnovata attenzione alla dimensione testuale (non letteraria), che nelle ultime generazioni si era andata sfilacciando fino a diventare una trama minoritaria. Roberto Corradino si è confrontato con un autore, Jean-Luc Lagarce, che nel nostro paese ha conosciuto, proprio in virtù di questa iniziativa promossa dall’Ambasciata di Francia, un notevole successo, sulla scia degli allori tributatigli in patria fin dalla sua morte, avvenuta nel 1995 per Aids. Per chi non ne sapesse niente, Lagarce è stato un vero e proprio esploratore teatrale, prolifico autore, attore e regista e anche editore (ha fondato Les Solitaires Intempestifs, nota sigla editoriale rivolta alla pubblicazione di testi per la scena e orientata ai fenomeni teatrali d’innovazione). 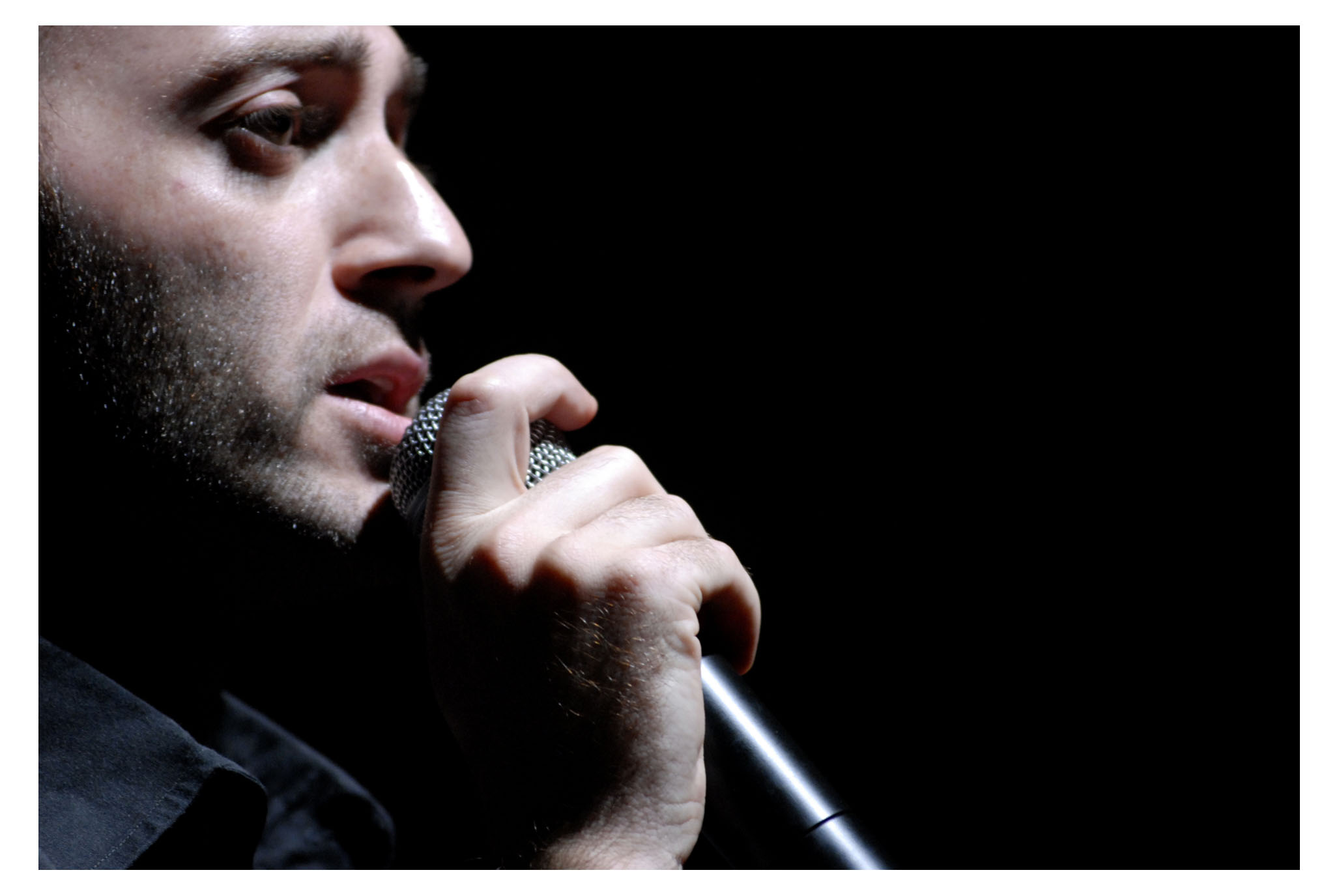 In traduzione italiana è apparso nella collana I testi, di Ubulibri, il primo volume Teatro (2008), a cura di Franco Quadri, mentre nei quaderni di Intercity Play (4/2000) sono uscite due traduzioni di Barbara Nativi e Francesca Moccagatta. In questi ultimi anni si è poi assistito a diverse proposte sceniche di registi da sempre sensibili alla drammaturgia, strictu senso, trattandosi di un autore particolarmente verboso: ricordiamo appunto il Progetto Lagarce promosso e diretto da Luca Ronconi, che nel 2010 ha allestito Giusto la fine del mondo, lasciando al suo assistente Carmelo Rifici la regia de I pretendenti (2009); quindi l’allestimento di Marinella Manicardi, al Teatro delle Moline di Bologna, di Le regole del saper vivere nella società moderna; è passata invece in lingua originale dal Festival di Napoli nel 2009 la pièce Music-hall, nella visione di Lambert Wilson con una ex diva, Fanny Ardant, come nessun' altra in parte per la protagonista. In traduzione italiana è apparso nella collana I testi, di Ubulibri, il primo volume Teatro (2008), a cura di Franco Quadri, mentre nei quaderni di Intercity Play (4/2000) sono uscite due traduzioni di Barbara Nativi e Francesca Moccagatta. In questi ultimi anni si è poi assistito a diverse proposte sceniche di registi da sempre sensibili alla drammaturgia, strictu senso, trattandosi di un autore particolarmente verboso: ricordiamo appunto il Progetto Lagarce promosso e diretto da Luca Ronconi, che nel 2010 ha allestito Giusto la fine del mondo, lasciando al suo assistente Carmelo Rifici la regia de I pretendenti (2009); quindi l’allestimento di Marinella Manicardi, al Teatro delle Moline di Bologna, di Le regole del saper vivere nella società moderna; è passata invece in lingua originale dal Festival di Napoli nel 2009 la pièce Music-hall, nella visione di Lambert Wilson con una ex diva, Fanny Ardant, come nessun' altra in parte per la protagonista.
Roberto Corradino ha scelto quello che è considerato lo chef-d’oeuvre di Jean-Luc Lagarce, in un certo senso il suo testamento teatrale, Il paese lontano, che tratta del ritorno, dopo lunghi anni di silenzio, di un quarantenne vicino alla morte presso la sua famiglia, ma tutto è molto vago, perché secondario (ricorda molto, almeno apparentemente, certe atmosfere di Annibale Ruccello). Louis è un omosessuale, molto sbarazzino, leggero, scanzonato e disinvolto, si potrebbe azzardare anaffettivo, che alla notizia della sua imminente fine, imprecisata ma intuibile (evidente il rispecchiamento dell’autore in questa sagoma), fa i conti col passato e le persone care che ha fatto soffrire. O meglio, sono i suoi cari a fare i conti con lui, vivi e morti, fantasmi e umani, che gli riversano addosso le loro frustrazioni, le loro ansie, il loro dolore ma anche, felicemente, la loro gioia. Dall’amante (morto) al migliore amico Lunga Data, dall’innamorata non corrisposta, Hélène, fino al fratello Antoine, che diventa il deuteragonista con le sue tirate e le sfide che lancia al figliol prodigo Louis.
Corradino propone per Il Paese lontano molto più della dichiarata mise en espace: si tratta infatti di un quasi spettacolo con circa una ventina di attori tra professionisti e aspiranti, che, nello spazio del Kismet O.per.A Bari, agiscono, in senso letterale, il testo, trattato in chiave metateatrale. Lo spettatore assiste a dei lavori in corso - la maschera in tuta catarifrangente che all'inizio ci guida danzante dal foyer alla sala lo lascia presagire. Qui il maestro di cerimonie Corradino dà inizio a una sorta di prova aperta: gli attori, disposti in un complesso tableau vivant, “entrano nel personaggio”, dopo essere stati presentati nel loro ruolo. Le parti di ciascuna dramatis persona sono distribuite su più attori che si alternano nella finzione. In questo modo, il nostro regista può giocare a fare i Sei personaggi di Pirandello in modo del tutto inedito. Durante l’intera rappresentazione egli interviene, figura peripatetica, direttore di scena, maschera, - un po' alla Kantor, se vogliamo - suggerendo battute, correggendo dizioni, movimenti (ma c’è un copione anche in questi fuori scena che diventano scena); dirige l’organico come un direttore d’orchestra che accenna le modulazioni delle voci, le pause, il ritmo, l’intonazione; quindi mostra, con parsimonia, “come fare”; domanda agli attuanti il loro personaggio, lasciando intuire che gli attori giocano a girarsi le battute, quasi assistessimo ad un provino in cui ancora debbono essere assegnate le parti. Personaggi e attori convivono in scena senza sdoppiamenti improbabili ed è evidente come Corradino, tenendo sempre d’occhio la barra pirandellaina del metateatro, proceda però in senso inverso alle dinamiche dei Sei personaggi: nella direzione, appunto, del venire fuori del personaggio, del suo avvenire, senza polverosi psicologismi, nella carne dell’attore. L’arrivo, il suo manifestarsi è un’epifania che passa attraverso la voce, nell’enunciazione significante delle battute, piuttosto che nel loro significato, nella loro dirompenza lacerante e struggente. La voce diventa l’ossatura del personaggio cui appunto si dà un respiro, un corpo. Si aggiunge inoltre, sempre molto forte anche in altri precedenti allestimenti, la liquidità teatro-sala, resa agibile dal movimento dei performer e supportata da una non banale drammaturgia musicale, livello performativo che significa la scena e attiva la memoria privata e l’immaginario collettivo degli spettatori. in tuta catarifrangente che all'inizio ci guida danzante dal foyer alla sala lo lascia presagire. Qui il maestro di cerimonie Corradino dà inizio a una sorta di prova aperta: gli attori, disposti in un complesso tableau vivant, “entrano nel personaggio”, dopo essere stati presentati nel loro ruolo. Le parti di ciascuna dramatis persona sono distribuite su più attori che si alternano nella finzione. In questo modo, il nostro regista può giocare a fare i Sei personaggi di Pirandello in modo del tutto inedito. Durante l’intera rappresentazione egli interviene, figura peripatetica, direttore di scena, maschera, - un po' alla Kantor, se vogliamo - suggerendo battute, correggendo dizioni, movimenti (ma c’è un copione anche in questi fuori scena che diventano scena); dirige l’organico come un direttore d’orchestra che accenna le modulazioni delle voci, le pause, il ritmo, l’intonazione; quindi mostra, con parsimonia, “come fare”; domanda agli attuanti il loro personaggio, lasciando intuire che gli attori giocano a girarsi le battute, quasi assistessimo ad un provino in cui ancora debbono essere assegnate le parti. Personaggi e attori convivono in scena senza sdoppiamenti improbabili ed è evidente come Corradino, tenendo sempre d’occhio la barra pirandellaina del metateatro, proceda però in senso inverso alle dinamiche dei Sei personaggi: nella direzione, appunto, del venire fuori del personaggio, del suo avvenire, senza polverosi psicologismi, nella carne dell’attore. L’arrivo, il suo manifestarsi è un’epifania che passa attraverso la voce, nell’enunciazione significante delle battute, piuttosto che nel loro significato, nella loro dirompenza lacerante e struggente. La voce diventa l’ossatura del personaggio cui appunto si dà un respiro, un corpo. Si aggiunge inoltre, sempre molto forte anche in altri precedenti allestimenti, la liquidità teatro-sala, resa agibile dal movimento dei performer e supportata da una non banale drammaturgia musicale, livello performativo che significa la scena e attiva la memoria privata e l’immaginario collettivo degli spettatori.
Alla fine non ci dispiace Corradino nei panni del Dottor Hinkfuss che transita tra il pubblico o ruba le battute (deformazione professionale!) ai colleghi. Tuttavia è evidente che Louis è fatto su misura per lui e auspicheremmo di vederlo, in futuro, in scena col suo Lagarce (in tutti i sensi).
|
|
 ‘dignità’, ‘coraggio’, ‘generosità’, ‘ironia’ ‘dignità’, ‘coraggio’, ‘generosità’, ‘ironia’
tratti distintivi del suo profilo umano e professionale
[di Vito Minoia] E’ scomparso senza clamore a Milano il 22 aprile 2010 all’età di 83 anni Emilio Pozzi, “attento interprete del ruolo insostituibile del teatro pubblico”. Così lo hanno ricordato al Piccolo Teatro di Milano, quella istituzione alla quale aveva dedicato particolare attenzione “per scelta professionale e civile”. Sono parole, pubblicate nella sua opera I Teatri di Milano (con Domenico Manzella, Mursia 1985). Giorgio Strehler che volle scrivere l’introduzione ai due volumi disse “E’ un libro di noi teatranti”, con larga accezione. In quelle pagine, infatti, oltre alla ricostruzione erudita di duemila anni di storia dello spettacolo meneghino, riecheggiano le vicende di drammaturghi, musicisti, commediografi, ballerini, coreografi, attori, cantanti, registi, scenografi, costumisti, direttori d’orchestra e altri ‘addetti ai lavori’.
Una passione, quella dello storico del teatro, che Emilio ha iniziato a coltivare in modo più organico quando Paolo Grassi gli chiese di comporre insieme ed accanto a lui il volume sui suoi 40 anni di palcoscenico. Grassi impose all’Editore Ugo Mursia quel giornalista “di cui stimo da almeno trent’anni la probità professionale e la disponibilità umana, e di cui coltivo da sempre una sincera, affettuosa amicizia”. Eravamo nel 1977 e per la prima volta, il fondatore del Piccolo Teatro, insieme a Strehler e Nina Vinchi, dopo essere stato sovrintendente della Scala dal 1972, eletto Presidente della RAI, rifletteva con coerenza sull’idea centrale di un teatro d’arte a gestione pubblica, scelta frutto di ricerche e studi e naturale traguardo di una posizione ideologica socialista. Emilio lavorava in RAI già dal 1945, occupandosi particolarmente dei problemi dello spettacolo e - in intense pause di concentrazione nelle domeniche dell’autunno milanese - utilizzò un registratore per raccogliere dialoghi e monologhi non soltanto di Grassi, ma anche di chi aveva contributi di memoria da offrire ed opinioni da esprimere. Riuscì dunque a comporre un mosaico di episodi, di riflessioni e di spunti, adatti a cogliere il profilo di una personalità e di una vicenda umana, individuale e pubblica. E da conoscitore delle tecniche di recitazione, al termine di ogni capitolo, ha fatto parlare il protagonista come negli “a parte” del teatro tradizionale, attraverso quei corsivi su se stesso e gli altri che aprono un dialogo estremamente confidenziale con la platea dei lettori. Il libro fu tradotto in diverse lingue (fino in Unione Sovietica).
Alla RAI ha dedicato una buona parte della propria attività giornalistica cominciando al Giornale radio come radiocronista a Milano, poi a Roma, anche con la direzione della Ricerca e sperimentazione programmi, e infine a Torino dove ha diretto la sede regionale piemontese per dieci anni dal 1980. Ha realizzato molti documentari radiofonici. Memorabili le sue interviste ai personaggi più noti dello spettacolo degli ultimi 60 anni, tra le quali ricordiamo quelle a Maria Callas o a Renata Tebaldi (notoriamente molto riservata) o quella ai tre De Filippo (Eduardo, Peppino e Titina) riuniti in uno studio radiofonico nel momento in cui si erano divise le loro strade professionali.
|
|
Leggi tutto...
|
|
Regionalismi teatrali 2 (la riscossa del Sud)
[ Silvia Mei ] In queste stesse pagine abbiamo poco tempo fa riferito della varietà e del fervore della scena veneta, produttivamente e organizzativamente. Il 9 marzo scorso si è aperto un progetto con spettacoli e momenti di approfondimento sotto gli auspici della Fondazione Venezia, organo di riferimento per il teatro nella laguna, con Giovani a teatro-Esperienze, organizzazione Euterpe Venezia, per la stagione 2010-11 (www.esperienze-giovaniateatro.it/il-teatro-delle-lingue). La rassegna ha un titolo che, per chi mastica di teatro, è particolarmente evocativo e gravido del senso della presente scena italiana: Il teatro delle lingue. Ovvero una solitudine molto rumorosa, a cura di Paolo Puppa, docente all’Università Ca’ Foscari, di cui sul tema ricordiamo il bel libro-censimento La voce solitaria (Bulzoni, Roma 2010). marzo scorso si è aperto un progetto con spettacoli e momenti di approfondimento sotto gli auspici della Fondazione Venezia, organo di riferimento per il teatro nella laguna, con Giovani a teatro-Esperienze, organizzazione Euterpe Venezia, per la stagione 2010-11 (www.esperienze-giovaniateatro.it/il-teatro-delle-lingue). La rassegna ha un titolo che, per chi mastica di teatro, è particolarmente evocativo e gravido del senso della presente scena italiana: Il teatro delle lingue. Ovvero una solitudine molto rumorosa, a cura di Paolo Puppa, docente all’Università Ca’ Foscari, di cui sul tema ricordiamo il bel libro-censimento La voce solitaria (Bulzoni, Roma 2010).
È la tematica del solo di cogente attualità nello studio e nel pensiero delle arti performative, presso La Soffitta infatti, cartellone dell’Università di Bologna-Dipartimento di Musica e Spettacolo, nella direzione scientifica di Marco De Marinis, sono stati ospitati diversi progetti sull’oggetto storico-teorico del solo, a partire dalla danza, dove il fenomeno si fa significativamente eclatante. Del resto è un caso italiano, con radici storiche profonde (si pensi al fenomeno del Grande Attore), quello della solitudine scenica, dalla creazione alla performance vera e propria, incentivato da un sistema economico e da formule di circuitazione degli spettacoli lungo lo stivale, che richiedono agilità e freschezza (ma, soprattutto, bassi compensi). Oltralpe la situazione è molto diversa e il protagonismo del “mattatore” italiano è contrappuntato da un afflato corale (Chortheater), coltivato in secoli di tradizioni nazionali unitarie.
|
|
Leggi tutto...
|
|
|


 geniale nel saper comporre da uno spettacolo all'altro un “dramma continuato” attingendo ai diversi linguaggi e supporti a sua disposizione: fuori, prima e dentro la scena. Dai suoi esordi cinematografici (un’attività, quella del cinema, che scorre oggi parallela a quella teatrale, sempre più presente nel suo universo espressivo), fino alla scrittura d’occasione - viepiù praticata, per riviste e testate engagées (pensiamo a “L’Humanité” o a “L’Unità”) -, Delbono ha costruito un suo spazio drammatico o un teatro dilatato: una scena cioè in esubero che ributta altrove il germe fecondato dalla materialità del teatro stesso.
geniale nel saper comporre da uno spettacolo all'altro un “dramma continuato” attingendo ai diversi linguaggi e supporti a sua disposizione: fuori, prima e dentro la scena. Dai suoi esordi cinematografici (un’attività, quella del cinema, che scorre oggi parallela a quella teatrale, sempre più presente nel suo universo espressivo), fino alla scrittura d’occasione - viepiù praticata, per riviste e testate engagées (pensiamo a “L’Humanité” o a “L’Unità”) -, Delbono ha costruito un suo spazio drammatico o un teatro dilatato: una scena cioè in esubero che ributta altrove il germe fecondato dalla materialità del teatro stesso. Viaggio ai confini della visione
Viaggio ai confini della visione dell’impianto registico, sonoro e della composizione coreografica) e Francesco Givone (artifex dei dispositivi scenici e degli accessori). I due spettacoli in programma (15 e 16 aprile) procedevano proprio lungo la sottile linea d’ombra che demarca uno stacco, una cesura tra più territori: non si tratta di opere patinate o semplicemente ben fatte, Zaches è un gruppo giovanissimo altamente promettente, capace di governare e istruire la scena con sicurezza e talento. Il fascino dell’idiozia e Mal bianco costruiscono le prime due tappe del progetto “Trilogia della visione”, che trova un perfetto manifesto nella prima creazione, ispirata alle pinturas negras di Goya. Il sottotesto è appunto costituito dalla serie pittorica del pittore della modernità, il quale dipinge come in negativo, cioè sull’impressione della luce, che qui, nella trasposizione scenica, diventa un taglio inciso dal corpo dei performer in dialogo tra loro. Gli arti umani si riducono a pezzi componibili, snodabili, autosignificanti nell’immaginario ossario che si sviluppa in crescendo fino allo zoomorfismo di una figura taurina, un’ombra su fondo bianco che intreccia movenze flamenche. Mal bianco è invece il corrispettivo positivo della prima parte, un’allucinazione del non colore dagli abbacinanti effetti. In una scena che profuma di talco, dalla grana polverosa, dall’aspetto sulfureo, si muovono figure imbiaccate, vagamente butoh, in un corpo a corpo di guerrieri incorniciati e filtrati dalla retina del dispositivo fisso della trilogia, approntato secondo una metafora filmica nel velario che fa da diaframma e da protezione, da barriera e filtro per i nostri sguardi, come una palpebra sui nostri occhi.
dell’impianto registico, sonoro e della composizione coreografica) e Francesco Givone (artifex dei dispositivi scenici e degli accessori). I due spettacoli in programma (15 e 16 aprile) procedevano proprio lungo la sottile linea d’ombra che demarca uno stacco, una cesura tra più territori: non si tratta di opere patinate o semplicemente ben fatte, Zaches è un gruppo giovanissimo altamente promettente, capace di governare e istruire la scena con sicurezza e talento. Il fascino dell’idiozia e Mal bianco costruiscono le prime due tappe del progetto “Trilogia della visione”, che trova un perfetto manifesto nella prima creazione, ispirata alle pinturas negras di Goya. Il sottotesto è appunto costituito dalla serie pittorica del pittore della modernità, il quale dipinge come in negativo, cioè sull’impressione della luce, che qui, nella trasposizione scenica, diventa un taglio inciso dal corpo dei performer in dialogo tra loro. Gli arti umani si riducono a pezzi componibili, snodabili, autosignificanti nell’immaginario ossario che si sviluppa in crescendo fino allo zoomorfismo di una figura taurina, un’ombra su fondo bianco che intreccia movenze flamenche. Mal bianco è invece il corrispettivo positivo della prima parte, un’allucinazione del non colore dagli abbacinanti effetti. In una scena che profuma di talco, dalla grana polverosa, dall’aspetto sulfureo, si muovono figure imbiaccate, vagamente butoh, in un corpo a corpo di guerrieri incorniciati e filtrati dalla retina del dispositivo fisso della trilogia, approntato secondo una metafora filmica nel velario che fa da diaframma e da protezione, da barriera e filtro per i nostri sguardi, come una palpebra sui nostri occhi. Il trittico si muove su diverse unità di misura scenica, dal monologo al trio impiegando per ciascuna lingue e inflessioni differenti, profondamente legate alla cultura e vita artistica della regista palermitana: il napoletano, il “siciliano” e il francese (e così anche le co-produzioni sono riferibili ai tre contesti linguistici: Sud Costa Occidentale, Teatro Stabile di Napoli, Théâtre du Rond Point-Paris).
Il trittico si muove su diverse unità di misura scenica, dal monologo al trio impiegando per ciascuna lingue e inflessioni differenti, profondamente legate alla cultura e vita artistica della regista palermitana: il napoletano, il “siciliano” e il francese (e così anche le co-produzioni sono riferibili ai tre contesti linguistici: Sud Costa Occidentale, Teatro Stabile di Napoli, Théâtre du Rond Point-Paris). Riposa interamente sul corpo dello spettatore e sulle sue reazioni Edipo. Una Tragedia dei Sensi (per uno spettatore), del Teatro del Lemming, storico gruppo guidato dal regista e compositore Massimo Munaro con sede a Rovigo dal 1987 (
Riposa interamente sul corpo dello spettatore e sulle sue reazioni Edipo. Una Tragedia dei Sensi (per uno spettatore), del Teatro del Lemming, storico gruppo guidato dal regista e compositore Massimo Munaro con sede a Rovigo dal 1987 ( ll’Enigma dello specchio, oggetto quantomeno polisemico, che potrebbe benissimo riportare l’epigrafe del tempio di Delfi : “Conosci te stesso”. Ancora più forza acquista il monito dell’oracolo quando il principale senso di orientamento e conoscenza del mondo viene meno: l’accecamento diventa allora un atto simbolico non solo rispetto ai contenuti specifici della vicenda di Edipo, ma un’operazione necessaria per l’attivazione di canali sensoriali del corpo, ottusi o addormentati.
ll’Enigma dello specchio, oggetto quantomeno polisemico, che potrebbe benissimo riportare l’epigrafe del tempio di Delfi : “Conosci te stesso”. Ancora più forza acquista il monito dell’oracolo quando il principale senso di orientamento e conoscenza del mondo viene meno: l’accecamento diventa allora un atto simbolico non solo rispetto ai contenuti specifici della vicenda di Edipo, ma un’operazione necessaria per l’attivazione di canali sensoriali del corpo, ottusi o addormentati. Il paese lontano è qui
Il paese lontano è qui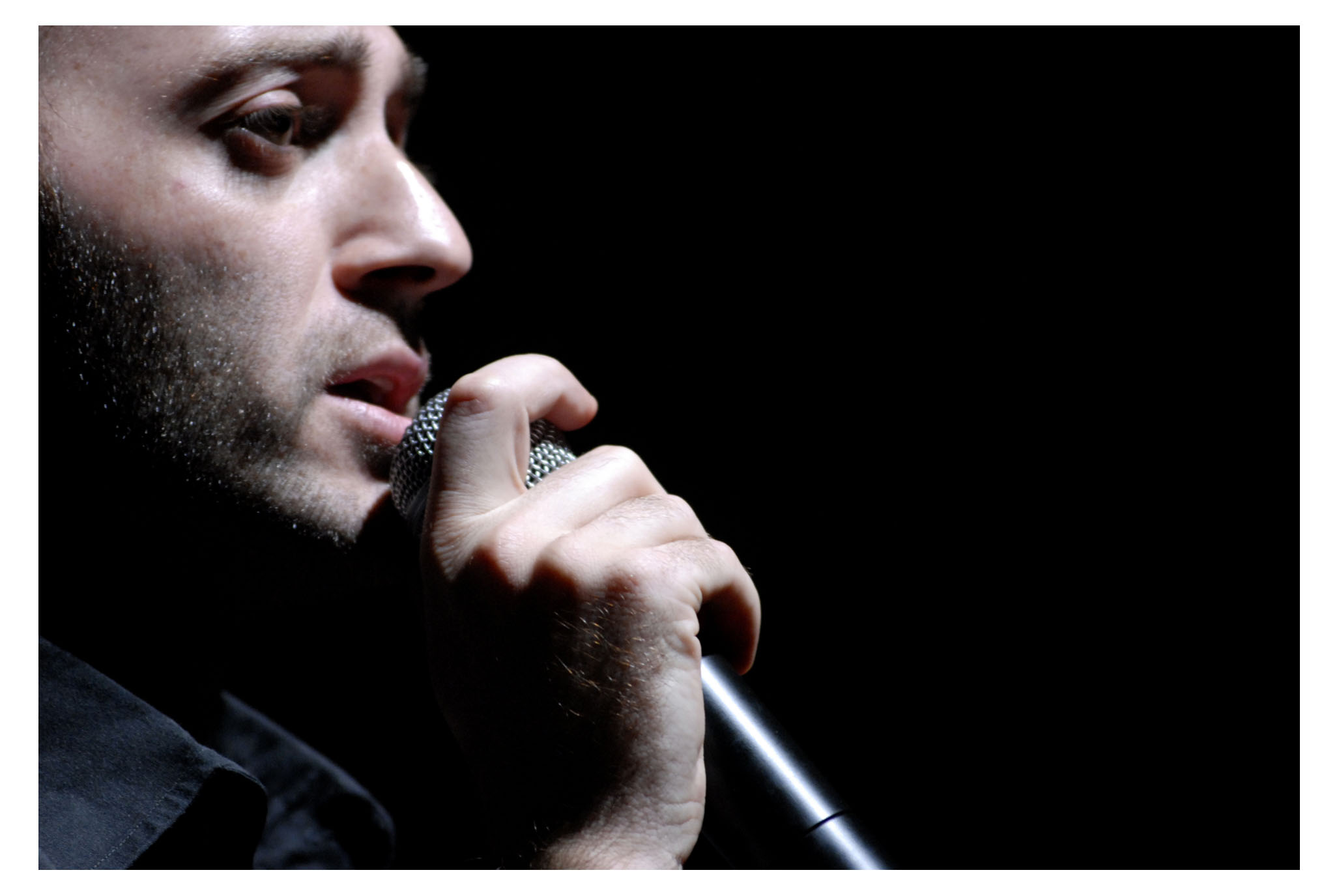 In traduzione italiana è apparso nella collana I testi, di Ubulibri, il primo volume Teatro (2008), a cura di Franco Quadri, mentre nei quaderni di Intercity Play (4/2000) sono uscite due traduzioni di Barbara Nativi e Francesca Moccagatta. In questi ultimi anni si è poi assistito a diverse proposte sceniche di registi da sempre sensibili alla drammaturgia, strictu senso, trattandosi di un autore particolarmente verboso: ricordiamo appunto il Progetto Lagarce promosso e diretto da Luca Ronconi, che nel 2010 ha allestito Giusto la fine del mondo, lasciando al suo assistente Carmelo Rifici la regia de I pretendenti (2009); quindi l’allestimento di Marinella Manicardi, al Teatro delle Moline di Bologna, di Le regole del saper vivere nella società moderna; è passata invece in lingua originale dal Festival di Napoli nel 2009 la pièce Music-hall, nella visione di Lambert Wilson con una ex diva, Fanny Ardant, come nessun' altra in parte per la protagonista.
In traduzione italiana è apparso nella collana I testi, di Ubulibri, il primo volume Teatro (2008), a cura di Franco Quadri, mentre nei quaderni di Intercity Play (4/2000) sono uscite due traduzioni di Barbara Nativi e Francesca Moccagatta. In questi ultimi anni si è poi assistito a diverse proposte sceniche di registi da sempre sensibili alla drammaturgia, strictu senso, trattandosi di un autore particolarmente verboso: ricordiamo appunto il Progetto Lagarce promosso e diretto da Luca Ronconi, che nel 2010 ha allestito Giusto la fine del mondo, lasciando al suo assistente Carmelo Rifici la regia de I pretendenti (2009); quindi l’allestimento di Marinella Manicardi, al Teatro delle Moline di Bologna, di Le regole del saper vivere nella società moderna; è passata invece in lingua originale dal Festival di Napoli nel 2009 la pièce Music-hall, nella visione di Lambert Wilson con una ex diva, Fanny Ardant, come nessun' altra in parte per la protagonista. in tuta catarifrangente che all'inizio ci guida danzante dal foyer alla sala lo lascia presagire. Qui il maestro di cerimonie Corradino dà inizio a una sorta di prova aperta: gli attori, disposti in un complesso tableau vivant, “entrano nel personaggio”, dopo essere stati presentati nel loro ruolo. Le parti di ciascuna dramatis persona sono distribuite su più attori che si alternano nella finzione. In questo modo, il nostro regista può giocare a fare i Sei personaggi di Pirandello in modo del tutto inedito. Durante l’intera rappresentazione egli interviene, figura peripatetica, direttore di scena, maschera, - un po' alla Kantor, se vogliamo - suggerendo battute, correggendo dizioni, movimenti (ma c’è un copione anche in questi fuori scena che diventano scena); dirige l’organico come un direttore d’orchestra che accenna le modulazioni delle voci, le pause, il ritmo, l’intonazione; quindi mostra, con parsimonia, “come fare”; domanda agli attuanti il loro personaggio, lasciando intuire che gli attori giocano a girarsi le battute, quasi assistessimo ad un provino in cui ancora debbono essere assegnate le parti. Personaggi e attori convivono in scena senza sdoppiamenti improbabili ed è evidente come Corradino, tenendo sempre d’occhio la barra pirandellaina del metateatro, proceda però in senso inverso alle dinamiche dei Sei personaggi: nella direzione, appunto, del venire fuori del personaggio, del suo avvenire, senza polverosi psicologismi, nella carne dell’attore. L’arrivo, il suo manifestarsi è un’epifania che passa attraverso la voce, nell’enunciazione significante delle battute, piuttosto che nel loro significato, nella loro dirompenza lacerante e struggente. La voce diventa l’ossatura del personaggio cui appunto si dà un respiro, un corpo. Si aggiunge inoltre, sempre molto forte anche in altri precedenti allestimenti, la liquidità teatro-sala, resa agibile dal movimento dei performer e supportata da una non banale drammaturgia musicale, livello performativo che significa la scena e attiva la memoria privata e l’immaginario collettivo degli spettatori.
in tuta catarifrangente che all'inizio ci guida danzante dal foyer alla sala lo lascia presagire. Qui il maestro di cerimonie Corradino dà inizio a una sorta di prova aperta: gli attori, disposti in un complesso tableau vivant, “entrano nel personaggio”, dopo essere stati presentati nel loro ruolo. Le parti di ciascuna dramatis persona sono distribuite su più attori che si alternano nella finzione. In questo modo, il nostro regista può giocare a fare i Sei personaggi di Pirandello in modo del tutto inedito. Durante l’intera rappresentazione egli interviene, figura peripatetica, direttore di scena, maschera, - un po' alla Kantor, se vogliamo - suggerendo battute, correggendo dizioni, movimenti (ma c’è un copione anche in questi fuori scena che diventano scena); dirige l’organico come un direttore d’orchestra che accenna le modulazioni delle voci, le pause, il ritmo, l’intonazione; quindi mostra, con parsimonia, “come fare”; domanda agli attuanti il loro personaggio, lasciando intuire che gli attori giocano a girarsi le battute, quasi assistessimo ad un provino in cui ancora debbono essere assegnate le parti. Personaggi e attori convivono in scena senza sdoppiamenti improbabili ed è evidente come Corradino, tenendo sempre d’occhio la barra pirandellaina del metateatro, proceda però in senso inverso alle dinamiche dei Sei personaggi: nella direzione, appunto, del venire fuori del personaggio, del suo avvenire, senza polverosi psicologismi, nella carne dell’attore. L’arrivo, il suo manifestarsi è un’epifania che passa attraverso la voce, nell’enunciazione significante delle battute, piuttosto che nel loro significato, nella loro dirompenza lacerante e struggente. La voce diventa l’ossatura del personaggio cui appunto si dà un respiro, un corpo. Si aggiunge inoltre, sempre molto forte anche in altri precedenti allestimenti, la liquidità teatro-sala, resa agibile dal movimento dei performer e supportata da una non banale drammaturgia musicale, livello performativo che significa la scena e attiva la memoria privata e l’immaginario collettivo degli spettatori. ‘dignità’, ‘coraggio’, ‘generosità’, ‘ironia’
‘dignità’, ‘coraggio’, ‘generosità’, ‘ironia’ marzo scorso si è aperto un progetto con spettacoli e momenti di approfondimento sotto gli auspici della Fondazione Venezia, organo di riferimento per il teatro nella laguna, con Giovani a teatro-Esperienze, organizzazione Euterpe Venezia, per la stagione 2010-11 (
marzo scorso si è aperto un progetto con spettacoli e momenti di approfondimento sotto gli auspici della Fondazione Venezia, organo di riferimento per il teatro nella laguna, con Giovani a teatro-Esperienze, organizzazione Euterpe Venezia, per la stagione 2010-11 (