|
[ Silvia Mei ] In tempi di ritorno all’ordine, ta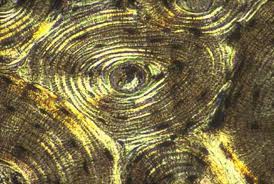 gli alla cultura (spettacolo e affini in primis) e recupero della territorialità (linguistica, economica, etc.), il Veneto potrebbe giustamente apparire come il rigurgito più acido del provincialismo italiano sulla scorta del Carroccio e del suo villaggio, di cui tutti ricordano l’esilarante presa nel 1997 del campanile di San Marco, con il cosiddetto tanco dei prodi padani che girava a vuoto nella piazza del Sansovino in attesa di una sommossa civile collettiva. Sappiamo tutti com’è finita, a disonor della storia (d’Italia). gli alla cultura (spettacolo e affini in primis) e recupero della territorialità (linguistica, economica, etc.), il Veneto potrebbe giustamente apparire come il rigurgito più acido del provincialismo italiano sulla scorta del Carroccio e del suo villaggio, di cui tutti ricordano l’esilarante presa nel 1997 del campanile di San Marco, con il cosiddetto tanco dei prodi padani che girava a vuoto nella piazza del Sansovino in attesa di una sommossa civile collettiva. Sappiamo tutti com’è finita, a disonor della storia (d’Italia).
Del resto Venezia e il Carnevale condividono un medesimo e triste destino, maschere e dialetto, che di questi tempi – tempi di pensieri deboli e poteri (troppo) forti – dettano il giorno e la notte. Il teatro in Veneto è però un teatro nazionale che tracima il regionalismo vivendo di un profondo radicamento nel territorio. Non è un vezzo tantomeno un paradosso: è la resistenza del teatro dell’ultima generazione, di nuovi gruppi e di spazi teatrali alternativi che affiancano e sostengono l’attività dei due tra i più importanti appuntamenti festivalieri e produttori teatrali italiani come Bassano del Grappa e Drodesera Fies.
A Venezia (e nel Veneto) non è l’ufficialità degli Stabili a promuovere il nuovo teatro, ovvero la ricerca scenica teatrale, ma piccole realtà ricavate in vissuti spazi della città, spazi non teatrali approntati in sale da spettacolo. Qui passano anteprime, studi, nuove produzioni, site specific, prime visioni, progetti scenici, rassegne tematiche che raccolgono un bacino teatrale davvero vasto, nazionale, con spazio alle compagnie e gruppi locali.
 Al Teatro Aurora di Porto Marghera (www.questanave.com), la temperatura del pubblico, rigorosamente studentesco, under 30, è davvero febbrile. Grande partecipazione per Lev dei Muta Imago (www.mutaimago.com), compagnia romana che si è subito imposta dai suoi primi passi nel 2006 col cammeo (a+b)3, apertura della “trilogia della memoria” che ha visto in Madeleine, nome gustoso ed evocativo, il suo climax. Lev ne è appunto lo snodo centrale e redige visivamente il diario di un sopravvissuto di guerra, Lev Zasetsky, paziente del neuropsichiatra russo Alexandr Lurija, noto per aver ridefinito la nozione di sintomo e aver legato alla perdita del linguaggio e all’assenza di relazioni sociali le disfunzioni della memoria. Zasetsky tenta disperatamente tra il 1943 e il 1958, nella densa e poetica scrittura del suo journal, di riparare le schegge disconnesse della sua identità individuale nel vissuto frammentato che riaffiora penosamente. E drammaticamente impotente diventa l’esistenza di un uomo la cui drammaturgia è un tessuto sfibrato, un pavimento sconnesso nelle cui slabbrature è obbligato a inciampare. Questi scarti e strappi diventano nella lingua dei Muta Imago (la regia è di Claudia Sorace, la drammaturgia e il suono di Riccardo Fazi) shock sonori e controcampi luminosi nell’operosità fabbrile di un attore, Glen Backhall – performer destinato a divenire un’icona del teatro di ultimissima generazione – che danza articolando il suo stage, un’arena rettangolare sovrastata da tre pannelli fluttuanti e mobili multifunzionali (di Massimo Troncanetti): ora lavagne, muri, paraventi, poi deflagrati soffitti, schermi pellucidi, supporti scrittorii. Qui il performer rimane schiacciato da una macchina scenica di cui dispone come un Mangiafuoco ma che patisce come un burattino. La lezione della rifondazione meccanica di un Gordon Carig si fonde, provvida, alla lezione della scena ritmica e geometrica di Adolphe Appia, filtrati nella sapienza tecnologica postmoderna ma altamente artigianale del magicien della scena canadese Robert Lepage, la cui filiazione nei Muta Imago si fa sempre più esplicita. Al Teatro Aurora di Porto Marghera (www.questanave.com), la temperatura del pubblico, rigorosamente studentesco, under 30, è davvero febbrile. Grande partecipazione per Lev dei Muta Imago (www.mutaimago.com), compagnia romana che si è subito imposta dai suoi primi passi nel 2006 col cammeo (a+b)3, apertura della “trilogia della memoria” che ha visto in Madeleine, nome gustoso ed evocativo, il suo climax. Lev ne è appunto lo snodo centrale e redige visivamente il diario di un sopravvissuto di guerra, Lev Zasetsky, paziente del neuropsichiatra russo Alexandr Lurija, noto per aver ridefinito la nozione di sintomo e aver legato alla perdita del linguaggio e all’assenza di relazioni sociali le disfunzioni della memoria. Zasetsky tenta disperatamente tra il 1943 e il 1958, nella densa e poetica scrittura del suo journal, di riparare le schegge disconnesse della sua identità individuale nel vissuto frammentato che riaffiora penosamente. E drammaticamente impotente diventa l’esistenza di un uomo la cui drammaturgia è un tessuto sfibrato, un pavimento sconnesso nelle cui slabbrature è obbligato a inciampare. Questi scarti e strappi diventano nella lingua dei Muta Imago (la regia è di Claudia Sorace, la drammaturgia e il suono di Riccardo Fazi) shock sonori e controcampi luminosi nell’operosità fabbrile di un attore, Glen Backhall – performer destinato a divenire un’icona del teatro di ultimissima generazione – che danza articolando il suo stage, un’arena rettangolare sovrastata da tre pannelli fluttuanti e mobili multifunzionali (di Massimo Troncanetti): ora lavagne, muri, paraventi, poi deflagrati soffitti, schermi pellucidi, supporti scrittorii. Qui il performer rimane schiacciato da una macchina scenica di cui dispone come un Mangiafuoco ma che patisce come un burattino. La lezione della rifondazione meccanica di un Gordon Carig si fonde, provvida, alla lezione della scena ritmica e geometrica di Adolphe Appia, filtrati nella sapienza tecnologica postmoderna ma altamente artigianale del magicien della scena canadese Robert Lepage, la cui filiazione nei Muta Imago si fa sempre più esplicita.
 D’area Veneta – ha sede a Castelfranco Veneto (Tv), dove si raccoglie nel 2000 intorno a Simone Derai e Paola Dallan – è la compagnia Anagoor che per Fondamenta Nuove (www.teatrofondamentanuove.it) propone l’ultimo dei quattro episodi della nuova produzione, Fortuny, di prossimo debutto in forma di spettacolo. Si tratta di un site specific, Ballo a Venezia, evento esclusivo portato nel grembo dell’officina e del laboratorio dell’artista catalano, Mariano Fortuny y Madrazo, figlio d’arte, inventore di moda, stilista ante litteram, artista applicato e anche pittore, fotografo, illuminotecnico, scenografo. La sua produzione, dagli oggetti d’arte e moda alle creazioni e progetti scenici, è stata copiosa e considerevole, patrimonio della città di Venezia e di un’Italia che da sempre saluta e ospita illustri pensatori e artisti (è da ricordare che proprio dirimpetto alle Fondamenta Nuove, nell’Isola di San Michele, riposano tra gli altri, nel cimitero monumentale, Serge de Diaghilev e Igor Stravinskij). D’area Veneta – ha sede a Castelfranco Veneto (Tv), dove si raccoglie nel 2000 intorno a Simone Derai e Paola Dallan – è la compagnia Anagoor che per Fondamenta Nuove (www.teatrofondamentanuove.it) propone l’ultimo dei quattro episodi della nuova produzione, Fortuny, di prossimo debutto in forma di spettacolo. Si tratta di un site specific, Ballo a Venezia, evento esclusivo portato nel grembo dell’officina e del laboratorio dell’artista catalano, Mariano Fortuny y Madrazo, figlio d’arte, inventore di moda, stilista ante litteram, artista applicato e anche pittore, fotografo, illuminotecnico, scenografo. La sua produzione, dagli oggetti d’arte e moda alle creazioni e progetti scenici, è stata copiosa e considerevole, patrimonio della città di Venezia e di un’Italia che da sempre saluta e ospita illustri pensatori e artisti (è da ricordare che proprio dirimpetto alle Fondamenta Nuove, nell’Isola di San Michele, riposano tra gli altri, nel cimitero monumentale, Serge de Diaghilev e Igor Stravinskij).
Anagoor (www.anagoor.com) lavora qui lungo due assi convergenti che affondano nella quieta gaiezza del revival neoclassico, capace di intercettare il contemporaneo negli accessori pop di sneakers e felpe di coreuti, fanciulle e ragazzi, separati da drappeggi che ritmano lo spazio museale di palazzo Fortuny, come in un bassorilievo fidiano. Ballo a Venezia riecheggia, seppur diversamente, Voci/Versi allestito nel Museo Canova di Possagno (Tv), dove algide e pensose ninfe in lutto, vagabonde villi senz’anima nel freddo riflesso del marmo della Gipsoteca, raggelano le fanciulle di Frank Wedekind e la loro educazione fisica, tragicamente tradotta in film da John Irvin (L’educazione fisica delle fanciulle, 2005). I giovani sono appunto il rio lungo il quale scivola l’attenzione di Anagoor nel cortocircuito tra la sommossa della compagnia dei giovani nel 1507 a Venezia, con la distruzione di tutte le gondole in Canal Grande, e la pericolosa fragilità dei nostri adolescenti. Ribolle di violenza una delle installazioni che precedono l’episodio Ballo a Venezia: le serafiche calli veneziane, come in una tela metafisica, trattengono terribili, ma invisibili, accessi di violenza da tragedia greca. Sono appunto korai e kouroi sbrecciati, in dialogo su due schermi ruotanti, cornici e display che aggiornano la tecnica dei cartoni fin de siècle, a trasmigrare negli orrori medici del furore eugenetico nazista, mentre una banda di efebi si dispone in scena riecheggiando la texture apollinea degli scatti di Wilhelm von Plüschow e Wilhelm von Gloeden.
 Un inno all’eutanasia, piuttosto che alla morte, quello dei Babilonia Teatri, gruppo di Verona che ha conosciuto una rapida e incalzante ascesa a partire da Made in Italy, vincitore del Premio Scenario 2007. Teatro politico, scevro di orpelli e di retoriche ideologiche, lavora con semplici oggetti quotidiani dalla forte carica simbolica. I Babilonia Teatri sono decadentisti d’inizio terzo millennio, per la rarefazione simbolica, catto-cristiano-massmediatica (a rimarcare come, soprattutto oggi, miti, icone e fede scorrano su medesimi binari), dei temi crepuscolari da fine di un’epoca, l’andamento da melologo in chiave rap ma che stilizza piuttosto la cadenza mnemonica e non partecipata delle messe di paese. The end – all’interno di Giovani a teatro 10/11-Esperienze, ideazione e cura della Fondazione Venezia-Euterpe Venezia (www.giovaniateatro.it) – è la contrazione ed elaborazione della prima tappa corale passata a Santarcangelo41, This is the end my only friend the end, brucianti versi di Jim Morrison per i Doors (1967), asciugati nella voce monologante della solista Valeria Raimondi: una preghiera senza Dio, una lettura senza responsorio, che detta il testamento biologico, libero e laico, di chi celebra la vita, contempla la vecchiaia e gioca a scacchi con la morte. “Non voglio una morte lenta/ voglio un colpo di pistola […] non mi vedrete con le mutande piene di merda/ nuotare nel me stesso pisso/ non mi farò lavare da una troia che non sa la mia lingua/ non passerò gli ultimi anni col pannolone”. Nello sparo che chiude un Morricone da spaghetti western mentre viene issato un crocifisso che guarda il pubblico, in quello sparo ci sta la cronaca dell’Italietta anni (duemila)Dieci: l’ultimo respiro di Eluana e lo schianto di Mario Monicelli gettatosi dal quinto piano dell’ospedale di Roma. Una morte alla Gran Torino per il patriota marine di Clint Eastwood. Ma c’è anche la spettacolarità, altro tema che ritorna nei Babilonia Teatri, della morte stessa, lo snuff movie e la postproduzione di funerali con filmini e blog, tutto compreso. Un inno all’eutanasia, piuttosto che alla morte, quello dei Babilonia Teatri, gruppo di Verona che ha conosciuto una rapida e incalzante ascesa a partire da Made in Italy, vincitore del Premio Scenario 2007. Teatro politico, scevro di orpelli e di retoriche ideologiche, lavora con semplici oggetti quotidiani dalla forte carica simbolica. I Babilonia Teatri sono decadentisti d’inizio terzo millennio, per la rarefazione simbolica, catto-cristiano-massmediatica (a rimarcare come, soprattutto oggi, miti, icone e fede scorrano su medesimi binari), dei temi crepuscolari da fine di un’epoca, l’andamento da melologo in chiave rap ma che stilizza piuttosto la cadenza mnemonica e non partecipata delle messe di paese. The end – all’interno di Giovani a teatro 10/11-Esperienze, ideazione e cura della Fondazione Venezia-Euterpe Venezia (www.giovaniateatro.it) – è la contrazione ed elaborazione della prima tappa corale passata a Santarcangelo41, This is the end my only friend the end, brucianti versi di Jim Morrison per i Doors (1967), asciugati nella voce monologante della solista Valeria Raimondi: una preghiera senza Dio, una lettura senza responsorio, che detta il testamento biologico, libero e laico, di chi celebra la vita, contempla la vecchiaia e gioca a scacchi con la morte. “Non voglio una morte lenta/ voglio un colpo di pistola […] non mi vedrete con le mutande piene di merda/ nuotare nel me stesso pisso/ non mi farò lavare da una troia che non sa la mia lingua/ non passerò gli ultimi anni col pannolone”. Nello sparo che chiude un Morricone da spaghetti western mentre viene issato un crocifisso che guarda il pubblico, in quello sparo ci sta la cronaca dell’Italietta anni (duemila)Dieci: l’ultimo respiro di Eluana e lo schianto di Mario Monicelli gettatosi dal quinto piano dell’ospedale di Roma. Una morte alla Gran Torino per il patriota marine di Clint Eastwood. Ma c’è anche la spettacolarità, altro tema che ritorna nei Babilonia Teatri, della morte stessa, lo snuff movie e la postproduzione di funerali con filmini e blog, tutto compreso.
Non si tratta di eroismo né di vanità con quel teschio che ha accompagnato secoli di arte e che è fido compagno di ogni artista (pensiamo agli autoritratti di Andy Warhol e a Balcan Baroque di Marina Abramovic). Quel teschio è diventato lo sguardo dell’agnello di Dio, morto martire e suicida, sotto cui si celebra il pietismo cristiano che un altro insopportabile spettacolo, per lo spietato naturalismo e la cruda verità, Sul concetto di volto nel Figlio di Dio di Romeo Castellucci commenta olfattivamente. Quel volto va forse sfigurato, oppure gli si può voltare le spalle come fa la Raimondi che celebra il suo presepe, con bue e asinello decapitati ai lati della croce e il suo neonato tra le braccia. Sfida al perituro che la vita e l’arte sanno ancora lanciare?
Variegato ed estraneo ai circuiti indipendenti più à la page (per questo anche più interessante), è il cartellone Contrappunti, a Padova, programmato nella chiesa sconsacrata delle Maddalene da Tam Teatromusica, che ha festeggiato lo scorso anno – ne abbiamo riferito, voci solitarie, in queste stesse pagine – i suoi 30 anni di attività con 3 generazioni di giovani artisti usciti dalla bottega di Allegro-Sambin (www.tamteatromusica.it/contrappunti11/rassegna_11.htm). Riferiamo dell’ultimo appuntamento, spassosissimo e di fine drammaturgia, con I Sacchi di Sabbia/Compagnia Sandro Lombardi per SANDOKAN, o la fine dell’avventura, teatro di verzura, che riduce la scena al retrocucina di un ristorante vegano o nel set di un cartoon alla Ratatouille. Liberissima l’interpretazione della saga di Emilio Salgari per Le Tigri di Mompracen, versione “cotta a fuoco lento in mezzo a verdure e utensili da cucina”, spiega la compagnia pisana fondata nel 1995, premio speciale Ubu nel 2008 per la “vivacità di una scrittura condotta con freschezza creativa e irridente” (www.sacchidisabbia.com). Immaginazione plastica, bricolage alimentare, fantasmagoria comica sono le cifre dello spettacolo che raccontano il romanzo straniandolo nella metafora ortofrutticola di quattro amici impegnati in una bizzarra lezione di cucina. I dialoghi sono il testo del prolifico romanziere (veneto), la partitura, antiemotiva e controimmedesimativa, quella di un cuoco apprendista, mentre la scrittura scenica e il montaggio riposano nelle fibre vegetali degli ortaggi sminuzzati, spolpati, grattugiati, affettati, rosicchiati, infilzati, degustati che come in un dipinto di Arcimboldo compongono le orografie fisiche di una figura, per subito diventare, in una rapida messa a fuoco, quello che sono veramente: mera agricoltura. “Ma se può una semplice cifra su un foglio rappresentare un milione […] sopperite alla nostra insufficienza con la vostra immaginazione. Fate d’un uomo mille uomini; createvi di fantasia un poderoso esercito”. Shakespeare docet, I Sacchi di Sabbia facent.
|