|
 Intervista a Roberta Nicolai, direttore artistico della rassegna Intervista a Roberta Nicolai, direttore artistico della rassegna
a cura di Anna Maria Bruni
Mentre fervevano i preparativi per la gran serata di chiusura di una ricchissima otto giorni dedicata alla scena contemporanea, per il quinto anno consecutivo nel quartiere Garbatella a Roma, abbiamo incontrato Roberta Nicolai, la ‘mente’ di Teatri di Vetro, per provare ad indagare a fondo il senso di questa kermesse. Una vera rassegna di creazioni artistiche fra teatro, danza, videoart, installazioni sonore, laboratori e quant’altro, che ha messo a confronto la scena più classica con la creazione più introspettiva.
Su cosa si basa la scelta dei lavori che decidi di far partecipare alla rassegna?
Su un punto sostanziale: cercare dentro un lavoro, a prescindere se sia un lavoro compiuto, le tracce di un autore di teatro. Non tanto originalità, quanto autenticità, qualcosa che si differenzia e che va verso la definizione di un linguaggio personale. Escluso quindi tutto quello che scaturisce da un trend o da una moda piuttosto che da una necessità. Chiaramente accanto a questo contano elementi che riguardano la preparazione tecnica: la capacità di strutturare il lavoro, dalla composizione, al linguaggio, all’estetica che lo esprime. Il compito è quello di individuarne la natura, nel rispetto del lavoro e di chi lo ha proposto, capendo di che vive. A volte è più semplice perché si appoggia a codici condivisi; uno spettacolo come quello della compagnia MusellaMazzarelli (Milano, in scena con Figli di un brutto dio, ndr) che ha portato una drammaturgia ben scritta, ben interpretata, con una narrazione lineare, è immediatamente decodificabile. A volte invece la decodifica è più complessa, succede di guardare dei lavori in cui io stessa fatico a capire che cosa sta succedendo e quali sono gli elementi messi in campo, quali gli obiettivi, quale la convenzione che l’autore vuole creare rispetto allo spettatore. Per la danza ho una consulente, Anna Lea Antolini, che vede tutti i lavori e poi ne discutiamo assieme, e così anche per il teatro, insomma cerco di affiancare il mio sguardo a quello di qualcun’altro proprio perché la difficoltà di leggere i lavori lo rende necessario. L’atteggiamento però è quello, per evitare di ospitare solo percorsi che già si conoscono, ma al contrario attraverso quel lavoro cominciare a conoscere nuovi percorsi. Penso che sia importantissimo dare a tutti la possibilità di essere visti, e quindi con me c’è una sorta di corresponsabilità, e anche se ancora a livello embrionale un pensiero rispetto al teatro e a che tipo di rapporto si intende instaurare con lo spettatore. Questo è il primo tassello del festival, essere costantemente un campo di indagine di ciò che viene creato sul territorio nazionale.
In diversi casi in effetti il teatro che abbiamo visto non è comprensibile ai più, e non sembra molto preoccuparsi di farsi comprendere, ma poiché è l’arte a dover andare dalla gente e non il contrario, e non basta collocare un teatro in un quartiere popolare ti domando, quando parli di spettatore a chi pensi?
Per la varietà di proposte il festival vuole coprire un arco di possibili spettatori abbastanza ampio. In questo arco sta la differenziazione, che è anche l’arco della scena contemporanea. Al suo interno ci sono delle linee di ricerca che prevedono la comunicazione, altre che invece la mettono in discussione - di certo quella che passa attraverso codici noti, mentre al contrario sperimentano una capacità di comunicazione attraverso invenzioni, astrazioni, e chiedono allo spettatore di mettersi in un'altra posizione. Penso al lavoro di Alessandra Cristiani (Roma, in scena con Opheleia, ndr), che obbliga lo spettatore ad una posizione diversa da quella con cui è entrato in sala, cominciando dal suo ritmo vitale, che deve mettere da parte perché obbliga a un rallentamento dovuto alla rarefazione del tempo provocata dalla rielaborazione del butoh, base del suo lavoro. Ma la trasformazione del segno attraverso il movimento provoca una così forte empatia emozionale con lo spettatore, che pur sfuggendo al meccanismo noto di interpretazione del livello comunicativo, so che comunica in maniera molto potente e con una presenza assoluta, attinge a qualcosa di assolutamente intimo, personale, a paesaggi interiori che sono solo suoi, e che lei veicola in una narrazione, danzata o meno, in maniera così forte che è raro che lo spettatore si senta escluso.
In altri casi invece vi sono lavori che non intendono pensare nella maniera più assoluta alla comunicazione, ma mettono in campo un’azione, in una logica di reciprocità in cui lo spettatore non è lì come destinatario, ma come un altro attore. Lo spettacolo di questa ultima sera invece è molto più immediato, più convenzionale dal punto di vista della ricerca, e quindi sicuramente di fruizione più semplice (Punta Corsara, compagnia dei ragazzi di Scampia, Il signor de Pourceaugnac, riduzione da Moliere, ndr). In sostanza quando io penso alla scena contemporanea non penso a uno spettatore, penso a molti cittadini, ed ognuno con la sua sensibilità può trovare al suo interno qualche cosa che gli corrisponde.
In questo senso il teatro nei lotti è stato un’occasione di maggiore comunicazione, come dicevi tu, attraverso codici più consueti, con gli abitanti di Garbatella, ed ha sedimentato qualcosa attraverso le cinque edizioni?
In realtà l’offerta ha fatto un’evoluzione negli anni, perché nelle prime due edizioni sono stati semplicemente portati nei lotti spettacoli nati per il teatro, mentre successivamente si è pensato sempre di più alla specificità di quegli spazi, i cortili, i panni stesi, e quindi si è lavorato a dei progetti che potessero avere un dialogo più specifico con il luogo stesso. L’attenzione e la curiosità degli abitanti c’è sempre stata, ed hanno potuto vedere negli anni lavori via via più raffinati, dagli spettacoli di narrazione, con un linguaggio molto diretto, semplice, a laboratori che pure hanno saputo mettersi in relazione, coinvolgendo gli abitanti. Penso a Garten (in scena al Lotto 32 con Time for talk is over, ndr) che con i materiali di riciclo ha costruito una piccola città all’aperto; questo è piaciuto tantissimo agli abitanti, i bambini sono stati tantissimi, e sono rimasti incantati di fronte a questa specie di plastico della città che veniva ricostruito in mezzo ai palazzi veri della città. E’ chiaro che se io avessi proposto nei lotti spettacoli facili, immediati, sarebbero stati contenti, ma non sarebbe stato per loro niente di diverso dalla festa della cultura, o da una festa di paese; e invece il fatto che con qualcuno tu possa parlare durante il festival e lo vedi assumere un suo criterio di distinzione, è molto più interessante per me, vuol dire che evidentemente questo tipo di scena nella sua pluralità offre anche la possibilità di reagire attivamente di fronte a ciò che incontra la sua sensibilità o meno. Questo è enorme, perché di fronte all’offerta televisiva, nessuno dice neanche più mi piace o non mi piace, il giudizio è sospeso, non ci si ragiona neanche troppo, si subisce quel che viene propinato. Il teatro deve essere questo, non è soltanto qualcosa che si replica identico a se stesso, è qualcosa che si offre nel suo accadere, a qualcuno che è lì, vivo, e lascia che gli accada qualcosa, e permette che chi guarda faccia accadere qualcosa. con un linguaggio molto diretto, semplice, a laboratori che pure hanno saputo mettersi in relazione, coinvolgendo gli abitanti. Penso a Garten (in scena al Lotto 32 con Time for talk is over, ndr) che con i materiali di riciclo ha costruito una piccola città all’aperto; questo è piaciuto tantissimo agli abitanti, i bambini sono stati tantissimi, e sono rimasti incantati di fronte a questa specie di plastico della città che veniva ricostruito in mezzo ai palazzi veri della città. E’ chiaro che se io avessi proposto nei lotti spettacoli facili, immediati, sarebbero stati contenti, ma non sarebbe stato per loro niente di diverso dalla festa della cultura, o da una festa di paese; e invece il fatto che con qualcuno tu possa parlare durante il festival e lo vedi assumere un suo criterio di distinzione, è molto più interessante per me, vuol dire che evidentemente questo tipo di scena nella sua pluralità offre anche la possibilità di reagire attivamente di fronte a ciò che incontra la sua sensibilità o meno. Questo è enorme, perché di fronte all’offerta televisiva, nessuno dice neanche più mi piace o non mi piace, il giudizio è sospeso, non ci si ragiona neanche troppo, si subisce quel che viene propinato. Il teatro deve essere questo, non è soltanto qualcosa che si replica identico a se stesso, è qualcosa che si offre nel suo accadere, a qualcuno che è lì, vivo, e lascia che gli accada qualcosa, e permette che chi guarda faccia accadere qualcosa.
Altri due elementi relativi alla scena contemporanea in questa fase sono molta “navigazione in solitaria”, e soprattutto da parte di donne. E’ la mancanza di una grammatica della relazione che si riflette in scena?
 Il lavoro individuale direi anzi che si è ridotto rispetto agli anni passati, quest’anno ci sono state compagnie molto numerose, per esempio il Teatro del Lemming (da Rovigo, andato in scena con Amleto, ndr), Punta Corsara, il laboratorio di Reggimento Carri di Roberto Corradino (Bari, Cuore_come un tamburo nella notte, ndr) , quindi è vero che ci sono navigazioni solitarie, ma rispetto agli anni passati è stato ripreso un teatro più corale, infatti tutti i problemi produttivi sono purtroppo quelli di ospitare compagnie numerose, quest’anno per prima volta. E’ vero che nella performance di danza c’è questo carattere dell’esposizione personale, e senz’altro ci sono moltissimi percorsi singoli, in Italia in questo momento, sì, solitari proprio come dici tu, che magari intrecciano altre competenze nella creazione, perché comunque l’artista ha intorno a sé altre figure che collaborano alla creazione - pensa alle videoinstallazioni per esempio - ma poi la scena è concepita come l’esposizione di uno. Il lavoro individuale direi anzi che si è ridotto rispetto agli anni passati, quest’anno ci sono state compagnie molto numerose, per esempio il Teatro del Lemming (da Rovigo, andato in scena con Amleto, ndr), Punta Corsara, il laboratorio di Reggimento Carri di Roberto Corradino (Bari, Cuore_come un tamburo nella notte, ndr) , quindi è vero che ci sono navigazioni solitarie, ma rispetto agli anni passati è stato ripreso un teatro più corale, infatti tutti i problemi produttivi sono purtroppo quelli di ospitare compagnie numerose, quest’anno per prima volta. E’ vero che nella performance di danza c’è questo carattere dell’esposizione personale, e senz’altro ci sono moltissimi percorsi singoli, in Italia in questo momento, sì, solitari proprio come dici tu, che magari intrecciano altre competenze nella creazione, perché comunque l’artista ha intorno a sé altre figure che collaborano alla creazione - pensa alle videoinstallazioni per esempio - ma poi la scena è concepita come l’esposizione di uno.
Per esempio il lavoro di Teatro Rebis (Macerata), sulla ridefinizione della propria identità, concepito come un percorso che si fa da soli...
Parli dello spettacolo Di una specie cattiva, sì, proprio loro, per esempio, sono un gruppo che lavora alla composizione scenica, ma in scena c’è l’individuo, direi prima ancora che il performer. Oppure il lavoro di Simona Bertozzi (Bologna, in scena con Bird’s eye view, ndr); nella performance, soprattutto nella danza, c’è un’indagine sull’identità individuale, e soprattutto del femminile. C’è una ricerca di ridefinizione della propria identità, e nella danza forse le donne sono la stragrande maggioranza, e senz’altro nella ricerca sono molto presenti, perché è chiaro che l’identità femminile è sotto indagine, così anche l’autonomia, che sembra tanto acquisita, ma in realtà è una cosa che ancora stiamo costruendo. Quindi spesso sono donne le danzatrici e coreografe che gestiscono l’interezza del loro lavoro.
Possiamo definire, quello di Teatri di Vetro, un teatro “dal basso”?
Il teatro nasce sempre dal basso. L’altro giorno sentivo parlare Antonio Tarantino (autore di Cara Medea, portato in scena da Francesca Ballico di Teatri di Vita, Bologna, ndr) che raccontava di come è diventato autore, di come ha visto che il suo primo testo ha vinto Riccione, e poi ha scritto il secondo, il terzo, e il quarto… E’ in questa quasi casualità che nasce, non voglio dire che le accademie non sono incubatori di teatro, quando funzionano sono necessarie a garantire gli strumenti per costruire la propria ricerca, però c’è qualcosa di autogerminante che è molto prezioso e va fatto germogliare. L’ambiente protetto può aiutarti nel confronto, nella crescita, nel definire meglio le tue linee di ricerca, nell’essere più efficace rispetto agli obiettivi che ti poni, quello che nel teatro fino all’ottocento era trasmesso di famiglia in famiglia, di padre in figlio. Ma poi il primo grande momento di rinno vamento per il teatro, già dalle prime avanguardie, già da Stanislavskij, è arrivato da altri ambiti sociali, non è nato sul palcoscenico, si è verificato quando sono arrivati i barbari. vamento per il teatro, già dalle prime avanguardie, già da Stanislavskij, è arrivato da altri ambiti sociali, non è nato sul palcoscenico, si è verificato quando sono arrivati i barbari.
Senz’altro molti di questi artisti nascono o si formano nelle accademie, poi però quando arriva il momento di scegliere se continuare a fare la professione da attore scritturato, o se essere tu l’autore di ciò che porterai in scena, questo dipende solo dal desiderio di rispondere ad un’urgenza personale che chiede di essere espressa.
Sempre a proposito della scena contemporanea, con il superamento del teatro di parola tradizionalmente inteso, in moti casi è venuta a mancare la parola stessa, o spesso, quando c’è, “accompagna” l’azione, ma è fuori scena. Come nella realtà, c’è bisogno di un teatro la cui parola sia di nuovo azione?
Esempi in questo senso sono il lavoro del laboratorio di Scampia, che forma ragazzi che forse non avrebbero neanche fatto gli attori nella loro vita, o anche il lavoro di Corradino, con cento ragazzi della Puglia attraverso il sostegno del teatro pubblico pugliese. Sono eventi importanti per Teatri di Vetro perché sono esempi di azione teatrale all’interno di un contesto, e in questa dinamica tutto si mette a posto da solo. Però non è l’unica strada possibile, ci sono anche esigenze fortemente intellettuali, forti domande anche rispetto alla parola, anche quando, o perché, è assente, e al linguaggio, soggetto a troppi condizionamenti che ce lo hanno sottratto e ce lo hanno limitato. Questo è un tema fondamentale, perché il teatro è parola incarnata, è parola viva, e quindi si deve porre la questione di come rianimare una parola che sentiamo talmente tanto devastata da non riuscire più ad essere veramente il nostro modo privilegiato di comunicare.
L’immagine che mi viene in mente è Teatri di vetro come una testa con mille pensieri random, apparentemente ognuno ad inseguire una propria idea, eppure ognuno come una scintilla. E’ semplicemente ricerca personale di ciascuno, o gestazione di qualcosa che potrebbe esplodere da un momento all’altro ricomponendo i pezzi di un puzzle?
Questo è quel che mi auguro tantissimo, non dedicherei così tanto tempo a tutto questo, spostando anche l’attenzione dalla creazione personale, se non pensassi che questa pentola va fatta bollire a temperatura più alta possibile perché possa “portare a cottura”, a maturazione tutto questo, perché è chiaro che è una scena che cammina sottopelle, e neanche più troppo marginale, perché ormai i festival che se ne occupano, o le sezioni di festival che si occupano di scena contemporanea sono moltissimi in Italia. C’è una densità creativa, e una necessità di costruire il proprio pensiero sulla scena che ormai riguarda più di una generazione, e anzi è andato ad accumularsi per generazioni, nonostante gli scarsi mezzi. In Italia è difficile la formazione, è difficile il passaggio di competenze da generazione a generazione, è difficile ottenere gli spazi, non c’è una distribuzione. Quindi è veramente una situazione carica, che io mi auguro trovi il modo di esplodere e anche trovare forme più definite. Il tentativo di Teatri di Vetro è questo, trovare la connessione tra questa scena e i cittadini, in un’evoluzione sostenuta anche da meccanismi di auto-organizzazione, che aiuti gli artisti a conoscersi, e qui anche il C.re.s.co (Coordinamento delle Realtà della Scena Contemporanea, www.progettocresco.it, ndr) intende fare la sua parte, cercando di riunificare il paese sul piano culturale, per fare in modo che questo processo sviluppi al massimo le sue potenzialità.
A proposito del progetto C.re.s.co, nell’incontro in cui lo avete presentato è emerso chiaramente che intendete mettere in moto un processo inverso a quello che siamo abituati a vedere, ovvero quello di una comunità resa solida dall’autonomia personale di ciascuno, è esatto?
Sì, è proprio questo il punto. Non si 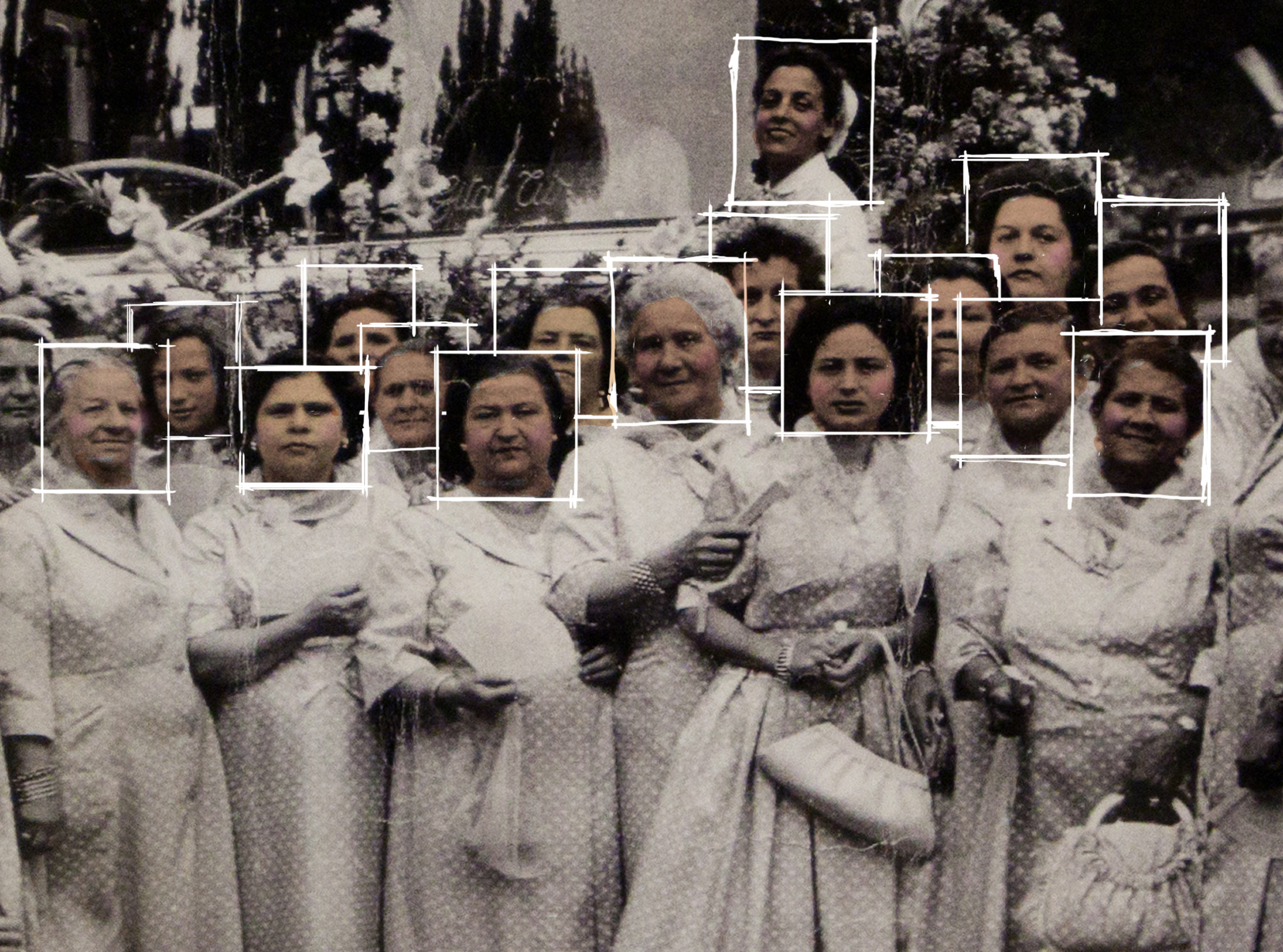 può avere una comunità oggi senza che ci siano delle identità definite e autonome, che viaggiano anche su percorsi diversi. Il tentativo, sia del C.re.s.co che del festival è proprio questo, creare uno spazio per una comunità che unisce differenze, mettendo a confronto identità diverse. Il C.re.s.co diventa uno spazio per l’incontro di comunità che si creano in diversi luoghi dell’Italia e tenta un altro livello di dialogo, importante perché altrimenti perdiamo anche il percorso fatto in tutti questi anni. Non si può pensare in questo momento di cambiare le cose da soli, bisogna essere insieme, senza che questo significhi dover essere uguali, perdere la propria autonomia o sottostare a regole che possono essere valide a Firenze e insensate a Palermo. Ritrovare però un senso del collettivo, essere individuale plurale. Perché ciascuno di noi è attraversato da tutto il resto, nel senso che il nostro viaggio individuale non deve essere messo da parte, ma non possiamo altrettanto esimerci dal pensarci in una comunità. può avere una comunità oggi senza che ci siano delle identità definite e autonome, che viaggiano anche su percorsi diversi. Il tentativo, sia del C.re.s.co che del festival è proprio questo, creare uno spazio per una comunità che unisce differenze, mettendo a confronto identità diverse. Il C.re.s.co diventa uno spazio per l’incontro di comunità che si creano in diversi luoghi dell’Italia e tenta un altro livello di dialogo, importante perché altrimenti perdiamo anche il percorso fatto in tutti questi anni. Non si può pensare in questo momento di cambiare le cose da soli, bisogna essere insieme, senza che questo significhi dover essere uguali, perdere la propria autonomia o sottostare a regole che possono essere valide a Firenze e insensate a Palermo. Ritrovare però un senso del collettivo, essere individuale plurale. Perché ciascuno di noi è attraversato da tutto il resto, nel senso che il nostro viaggio individuale non deve essere messo da parte, ma non possiamo altrettanto esimerci dal pensarci in una comunità.
Visto che siamo all’ultima giornata del festival, vuoi tentare un bilancio di questa quinta edizione, anche rispetto alle precedenti, e considerando la fase di crisi e i finanziamenti più esigui?
È difficile ancora fare un bilancio, bisogna che le bocce siano ferme, però penso che sia stata una edizione importante, sia per la qualità della programmazione, sempre più alta, anche perché nel panorama generale in un anno è stato fatto un cammino, e sia per l’attenzione generale che è stata più forte. Anche da parte della stampa c’è stato un desiderio di capire che pensiero ci fosse dietro al festival, e quindi per la prima volta i giornalisti sono andati oltre la notizia. Posso dire che ha confermato l’evoluzione fatta in cinque anni, da vetrina locale a possibilità di creazione stessa. Ora mi aspetta un nuovo incontro fra i promotori del C.re.s.co, e poi il premio Ubu per migliore “giovane curatore”, che devo degnamente ritirare a fine luglio! Nel frattempo studierò per la prossima creazione con Triangolo Scaleno, che parte da un testo di Agamben, ma assorbe anche tutto ciò che ha incrociato il mio cammino con questa rassegna. Per questa ragione sto ragionando su come espandere il tempo del festival, per dargli continuità e arrivare al prossimo anno, se ci sarà una nuova edizione di Teatri di Vetro, senza interrompere il dialogo innescato. Non so ancora come, ma voglio “arrivarci camminando”.
|