|
La qualità muscolare del teatro ESAGERA. Per Varlam Šalamon
di Erica Faccioli
Nella tajga avevo un magnifico sentiero, tutto mio.
V. Šalamov, La resurrezione del larice
 Varlam Šalamov riemerge sulla scena fisico-onirica di LAMINARIE, nel progetto MONOPOLIO - “Rassegna teatrale monografica, 4 vite di un'altra fibra” - dedicato, oltre che allo scrittore russo, a Bobby Fischer, Simone Weil, Jackson Pollock. Varlam Šalamov (Vologda, 1907- Mosca,1982), poeta e scrittore in una vita costellata dall'impiego del corpo: operaio in conceria e impegnato nel campo di lavoro correzionale nel lager di Višera, assunto in seguito nei cantieri del complesso chimico di Bereniki, manovale nella cava del giacimento aurifero Partizan (Magadan), poi ancora operaio di scavo e impegnato in una miniera di carbone. Varlam Šalamov riemerge sulla scena fisico-onirica di LAMINARIE, nel progetto MONOPOLIO - “Rassegna teatrale monografica, 4 vite di un'altra fibra” - dedicato, oltre che allo scrittore russo, a Bobby Fischer, Simone Weil, Jackson Pollock. Varlam Šalamov (Vologda, 1907- Mosca,1982), poeta e scrittore in una vita costellata dall'impiego del corpo: operaio in conceria e impegnato nel campo di lavoro correzionale nel lager di Višera, assunto in seguito nei cantieri del complesso chimico di Bereniki, manovale nella cava del giacimento aurifero Partizan (Magadan), poi ancora operaio di scavo e impegnato in una miniera di carbone.
Il 13 ottobre del 1951, liberato dal lager, lavora presso uno stabilimento torbiero a Resetnikovo (regione di Kalinin): solo in seguito alla riabilitazione (1956) “per non aver commesso il fatto”, incorpora il suo essere poeta e scrittore, nell'ultimo quarto di secolo della sua vita disgregata dal male. Šalamov oppositore, diffusore del “Testamento di Lenin”, controrivoluzionario e tockista, agitatore antisovietico che definisce Bunin “un classico della letteratura russa”.
Kolyma è solo l'ultima tappa della mappa delle prigionie subite, da cui si origina l'epopea dei Racconti di Kolyma, consegnati dall'autore in forma di manoscritto all'Archivio Centrale di Stato per l'Arte e la Letteratura di Mosca (ora RGALI), e pubblicati in Russia nel 1989, posteriormente alle versioni francese del 1980 e newyorkese del 1981. Capace di una prosa lucida, distanziata e straziata insieme, lo scrittore trova nel racconto un punto di equilibrio al suo carattere passionale e irrisolto, egocentrico e contraddittorio. La memoria è un flusso sottostante, stemperato nel lavoro di un vero e proprio cesellatore e tessitore della scrittura, compositore di quadri sospesi nel tempo, in uno spazio dove s'insinuano, incidendosi, violenza, lacerazione, morte. I Racconti di Kolyma evocano, in un soffio lirico, la qualità massacrante del lavoro del corpo, il dispendio di energia dentro il gelo siberiano, la resistenza estrema ed estenuata al dio politico che torchia e piega l'essere umano alle aberrazioni dell'esistenza.
Nella DOM del Pilastro scende un buio siderale e aurorale, s'intravedono due tecnici che manovrano oggetti sulla scena attraverso corde e tiranti: la dedica di LAMINARIE a Šalamov è declina all'energia muscolare, all'operosità del corpo, mentre il montaggio sonoro evoca sbattiti d'ali e stridori meccanici.
La voce fuori campo ripropone immagini di Varlam Šalamov che si materializza sulla scena nel suo isolamento (Febo Del Zozzo), inverando la testimonianza di Irina Sirotinskaja, archivista che dedicò molti anni della sua vita allo scrittore. La scena dunque come memoria e testimonianza, come immagine e performatività che diviene metafora dell'energia muscolare.
 Un conversazione con Bruna Gambarelli Un conversazione con Bruna Gambarelli
a cura di Erica Faccioli
Innanzitutto, la scrittura di Šalamov, da cui si origina ESAGERA: cosa intendi quando citi una “qualità teatrale” della scrittura di Šalamov?
Appena ci siamo avvicinati alle parole scritte da Šalamov , ci siamo immediatamente accorti che si trattava di una scrittura profondamente differente da quella che avevamo incontrato in precedenza. Subito, fin dalle prime righe è stato evidente che ci trovavamo di fronte non solo un grande scrittore, ma ad uno scrittore “diverso”: i suoi racconti scelgono una strada precisa, quella dell’aderenza alla realtà, senza minimamente preoccuparsi di trasmettere indicazioni morali.
Questa attenzione che lui dedica alla descrizione minuta di ciò che avviene porta il lettore dentro agli accadimenti, senza “paraurti”: in qualche modo il corpo viene chiamato in causa. La materia diventa protagonista. Il ritmo della scrittura assorbe il lettore esattamente per il tempo necessario affinché egli entri nell’accadimento di cui si parla. Nei Racconti della Kolyma ci troviamo di fronte a un testo di 700 pagine in cui non c’è mai una parola di troppo. La mole del volume, la compattezza dell'epopea che presenta, richiama un'opera di scultura. Per “dire la verita” occorre ricordare esattamente gli avvenimenti. Il passaggio attraverso il corpo e il ritmo della scrittura sono due elementi che determinano per noi la qualità teatrale di un testo.
Mettendo a confronto la scrittura di Šalamov con quella emersa dall'esperienza concentrazionaria di altre personalità russe, come nel caso di Pavel Florenskij, emerge una differenza abissale. Florenskij, sacerdote, storico dell'arte, matematico, scrive dal lager una serie di lettere quasi tutte declinate all'affetto, alla memoria, alla mancanza famigliare; in questo Florenskij dimostra di essere completamente dentro la propria situazione, di declinare il suo molteplice ruolo nella smisurata dilatazione del lato umano (cfr. P. Florenskij, Non dimenticatemi, Mondadori, 2010). Tutt'altra la modalità di Šalamov, che sembra frapporre tra il sé, prigioniero di Kolyma, un altro sé stesso scrittore: dall'esperienza del lager nascono appunto i Racconti, che affermano la natura dello scrittore, quella natura spezzata dalla prigionia, tuttavia in grado di trovare il modo per affermarsi. Hai avvertito questa distanza straniante nella scrittura? Si può dire che essa sia un atto artistico entro cui risiedono memoria e testimonianza?
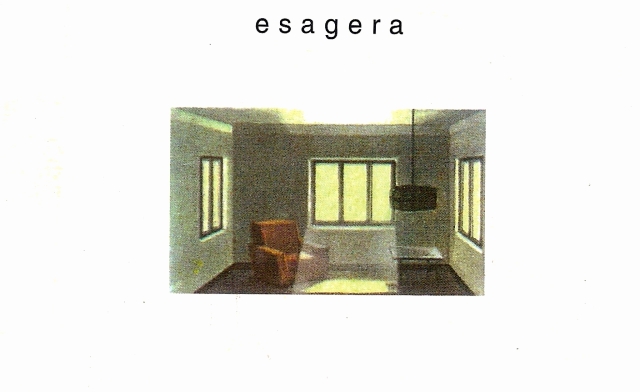 Šalamov dichiara spesso che deve la sua vita alla letteratura e alla poesia: solo il ricordo di alcuni versi poetici gli dava la forza di resistere durante la lunghissima prigionia. In questo senso possiamo certamente indicare Šalamov tra gli scrittori che pensano alla “bellezza che ci salva”: questa bellezza coincide anche con ciò che Šalamov ritiene un dovere, ossia il racconto della verità. Per il lettore significa addentrarsi nei dettagli asciutti di una vita terribile. A volte leggendo vorresti che questi dettagli venissero infranti, vorresti che si passasse all’esagerazione, che ti fossero date parole eclatanti, ma Šalamov non cede mai alla tentazione allontanarsi dalla realtà e dal dirci come sono accaduti gli avvenimenti, sapendo scegliere esattamente solo le parole che servono. Dalla prima all’ultima parola egli ci pone di fronte al lager senza darci scappatoie, senza fornire spiegazioni eticamente accettabili. Non ci sono mai racconti enfatizzati, esagerati, non ci sono sensi di colpa (per essere sopravvissuto in mezzo a tanti cadaveri), né indicazioni morali: “Il lager è una scuola negativa per chiunque, dal primo all’ultimo giorno. L’uomo non deve vederlo: ma se lo vede, deve dire la verità, per quanto terribile sia. Per parte mia ho deciso che dedicherò tutto il resto della mia vita proprio a questa verità”. Šalamov dichiara spesso che deve la sua vita alla letteratura e alla poesia: solo il ricordo di alcuni versi poetici gli dava la forza di resistere durante la lunghissima prigionia. In questo senso possiamo certamente indicare Šalamov tra gli scrittori che pensano alla “bellezza che ci salva”: questa bellezza coincide anche con ciò che Šalamov ritiene un dovere, ossia il racconto della verità. Per il lettore significa addentrarsi nei dettagli asciutti di una vita terribile. A volte leggendo vorresti che questi dettagli venissero infranti, vorresti che si passasse all’esagerazione, che ti fossero date parole eclatanti, ma Šalamov non cede mai alla tentazione allontanarsi dalla realtà e dal dirci come sono accaduti gli avvenimenti, sapendo scegliere esattamente solo le parole che servono. Dalla prima all’ultima parola egli ci pone di fronte al lager senza darci scappatoie, senza fornire spiegazioni eticamente accettabili. Non ci sono mai racconti enfatizzati, esagerati, non ci sono sensi di colpa (per essere sopravvissuto in mezzo a tanti cadaveri), né indicazioni morali: “Il lager è una scuola negativa per chiunque, dal primo all’ultimo giorno. L’uomo non deve vederlo: ma se lo vede, deve dire la verità, per quanto terribile sia. Per parte mia ho deciso che dedicherò tutto il resto della mia vita proprio a questa verità”.
La costruzione drammaturgica dello spettacolo affronta questo distanziamento riproponendolo attraverso i ricordi di Irina Sirotinskaja. Ciò equivale nuovamente ad affermare il valore della testimonianza, pur nel distacco che opera la sovrapposizione dei soggetti?
Le parole di Irina ci riportano ad un momento importante e significativo della vita di Šalamov, ossia nel periodo in cui lo scrittore si riappropria della scrittura. Irina ci parla di libri che Šalamov vede come strumento di verità e di libertà. La delicatezza con cui vengono descritti, la consapevolezza di poter di nuovo toccare oggetti che erano totalmente esclusi nel lager e considerati corpi estranei (“I libri avevano cessato di essere miei amici”). La lettura che finalmente cessa di essere un vizio segreto e ritorna molto lentamente a far parte della vita di uno scrittore che quasi aveva dimenticato di saper leggere. Questi momenti sono fondamentali per avvicinarsi all’opera di Šalamov che è una straordinaria ricostruzione degli eventi attraverso la memoria, sempre attuando quella distanza/presenza necessaria alla verità: solo con questo rispetto per il libro, per la parola, per la poesia, si può pensare di scrivere un’opera come I racconti della Kolyma.
Infine, il lavoro muscolare. Due macchinisti azionano un sistema di corde che muovono gli oggetti in scena: la qualità muscolare del lavoro, sfinente nei campi di Kolyma, viene restituita sulla scena, richiamando peraltro una definizione di Šalamov per la propria poetica: “Ogni mio racconto è come uno schiaffo e, come ogni schiaffo, ha leggi di carattere puramente muscolare...”. Esiste nello spettacolo un filo rosso che idealmente sostiene questa preminenza dell'energia muscolare?
Sì. Durante lo spettacolo si assiste ad una sorta di “cambio scena” che da una parte rimanda alla durezza di chi può “smontarti la vita” e dall’altra trasforma l’oggetto da componente della scena a protagonista assoluto della scena. Come dice Šalamov il lager non era un inferno ma un’industria, una fabbrica che serviva al paese: una gigantesca impresa in cui gli schiavi, che componevano la forza lavoro, valevano assai meno di qualsiasi oggetto. “ Una vanga costava di più”. Per noi quindi raccontare la Kolyma significava raccontare la materia, gli oggetti o, meglio, il gesto degli oggetti. È stato subito chiaro che la forza delle parole di Šalamov non poteva entrare direttamente nello spettacolo: il dettaglio, la macchina, lo strumento di lavoro, potevano rimandarci per evocazione ai campi concentrazionari. Abbiamo trattenuto del testo solo una frase, esemplare per la scelta essenziale delle parole, per il richiamo alla bellezza, all’arte, per il ritmo: “Le vedevamo raramente le donne. Soprattutto in una stanza. Soprattutto da vicino, faccia a faccia. Mi sembrò bellissima. Feci un inchino. Salutai.”
ESAGERA
Da I racconti di Kolyma
di Varlam Šalamov
§con Febo Del Zozzo
Regia e scene Febo DelZozzo
Drammaturgia Bruna Gambarelli
Macchinisti in scena Carlo Colucci, Matteo Chesini,
Filippo Deambrogio
Suoni Febo Del Zozzo, Luca Ravaioli
Voci Irina Sorotinskaja Annunciata e Sara Gambarelli
Produzione Laminarie |


 Varlam Šalamov riemerge sulla scena fisico-onirica di LAMINARIE, nel progetto MONOPOLIO - “Rassegna teatrale monografica, 4 vite di un'altra fibra” - dedicato, oltre che allo scrittore russo, a Bobby Fischer, Simone Weil, Jackson Pollock. Varlam Šalamov (Vologda, 1907- Mosca,1982), poeta e scrittore in una vita costellata dall'impiego del corpo: operaio in conceria e impegnato nel campo di lavoro correzionale nel lager di Višera, assunto in seguito nei cantieri del complesso chimico di Bereniki, manovale nella cava del giacimento aurifero Partizan (Magadan), poi ancora operaio di scavo e impegnato in una miniera di carbone.
Varlam Šalamov riemerge sulla scena fisico-onirica di LAMINARIE, nel progetto MONOPOLIO - “Rassegna teatrale monografica, 4 vite di un'altra fibra” - dedicato, oltre che allo scrittore russo, a Bobby Fischer, Simone Weil, Jackson Pollock. Varlam Šalamov (Vologda, 1907- Mosca,1982), poeta e scrittore in una vita costellata dall'impiego del corpo: operaio in conceria e impegnato nel campo di lavoro correzionale nel lager di Višera, assunto in seguito nei cantieri del complesso chimico di Bereniki, manovale nella cava del giacimento aurifero Partizan (Magadan), poi ancora operaio di scavo e impegnato in una miniera di carbone.
 Un conversazione con Bruna Gambarelli
Un conversazione con Bruna Gambarelli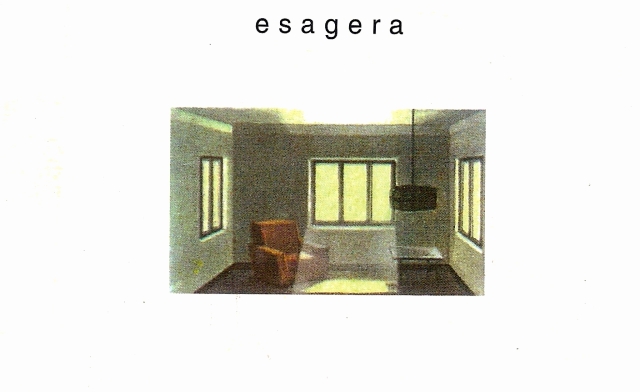 Šalamov dichiara spesso che deve la sua vita alla letteratura e alla poesia: solo il ricordo di alcuni versi poetici gli dava la forza di resistere durante la lunghissima prigionia. In questo senso possiamo certamente indicare Šalamov tra gli scrittori che pensano alla “bellezza che ci salva”: questa bellezza coincide anche con ciò che Šalamov ritiene un dovere, ossia il racconto della verità. Per il lettore significa addentrarsi nei dettagli asciutti di una vita terribile. A volte leggendo vorresti che questi dettagli venissero infranti, vorresti che si passasse all’esagerazione, che ti fossero date parole eclatanti, ma Šalamov non cede mai alla tentazione allontanarsi dalla realtà e dal dirci come sono accaduti gli avvenimenti, sapendo scegliere esattamente solo le parole che servono. Dalla prima all’ultima parola egli ci pone di fronte al lager senza darci scappatoie, senza fornire spiegazioni eticamente accettabili. Non ci sono mai racconti enfatizzati, esagerati, non ci sono sensi di colpa (per essere sopravvissuto in mezzo a tanti cadaveri), né indicazioni morali: “Il lager è una scuola negativa per chiunque, dal primo all’ultimo giorno. L’uomo non deve vederlo: ma se lo vede, deve dire la verità, per quanto terribile sia. Per parte mia ho deciso che dedicherò tutto il resto della mia vita proprio a questa verità”.
Šalamov dichiara spesso che deve la sua vita alla letteratura e alla poesia: solo il ricordo di alcuni versi poetici gli dava la forza di resistere durante la lunghissima prigionia. In questo senso possiamo certamente indicare Šalamov tra gli scrittori che pensano alla “bellezza che ci salva”: questa bellezza coincide anche con ciò che Šalamov ritiene un dovere, ossia il racconto della verità. Per il lettore significa addentrarsi nei dettagli asciutti di una vita terribile. A volte leggendo vorresti che questi dettagli venissero infranti, vorresti che si passasse all’esagerazione, che ti fossero date parole eclatanti, ma Šalamov non cede mai alla tentazione allontanarsi dalla realtà e dal dirci come sono accaduti gli avvenimenti, sapendo scegliere esattamente solo le parole che servono. Dalla prima all’ultima parola egli ci pone di fronte al lager senza darci scappatoie, senza fornire spiegazioni eticamente accettabili. Non ci sono mai racconti enfatizzati, esagerati, non ci sono sensi di colpa (per essere sopravvissuto in mezzo a tanti cadaveri), né indicazioni morali: “Il lager è una scuola negativa per chiunque, dal primo all’ultimo giorno. L’uomo non deve vederlo: ma se lo vede, deve dire la verità, per quanto terribile sia. Per parte mia ho deciso che dedicherò tutto il resto della mia vita proprio a questa verità”.