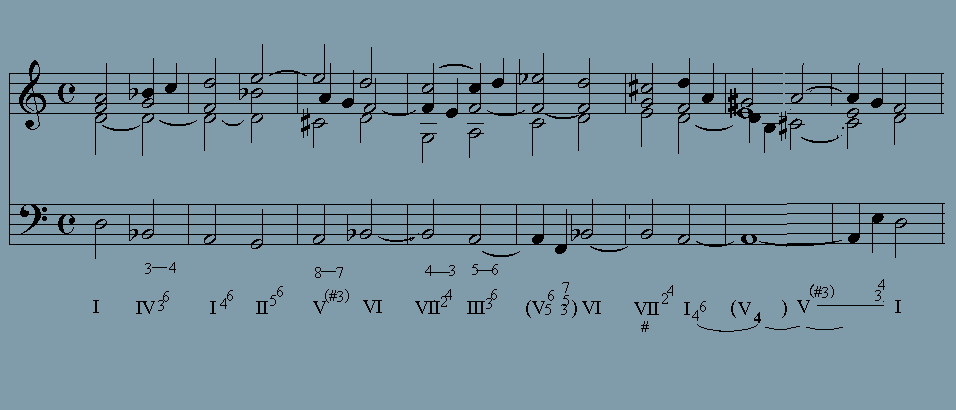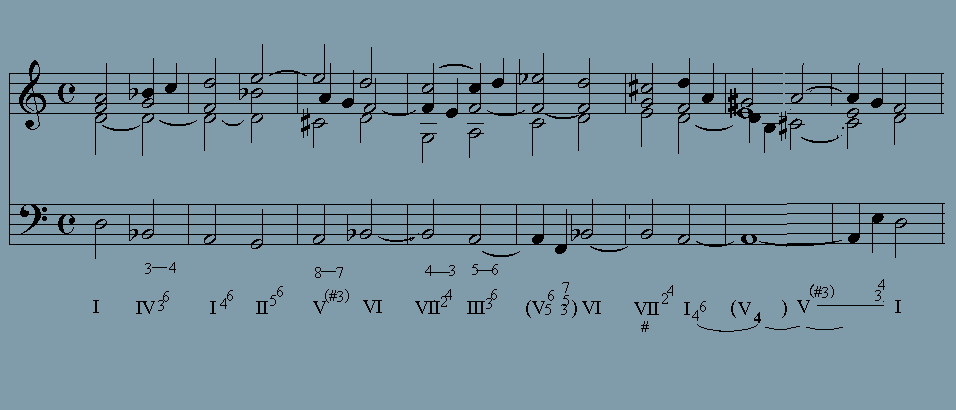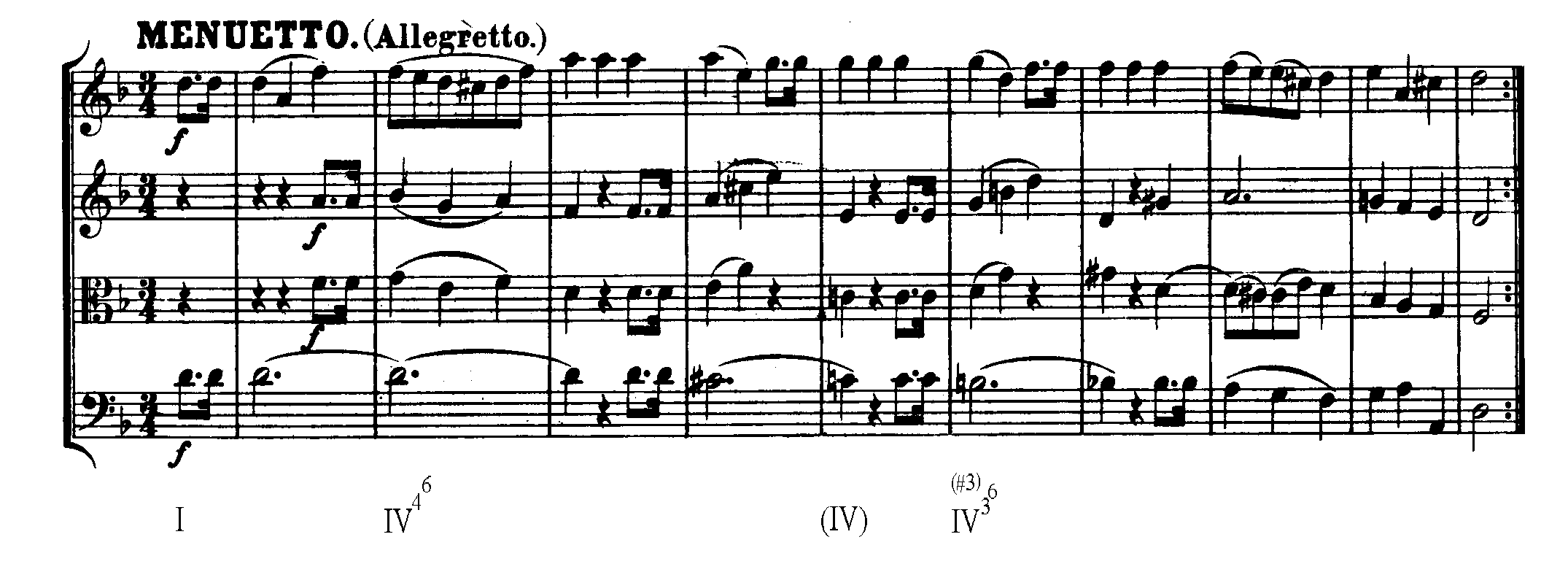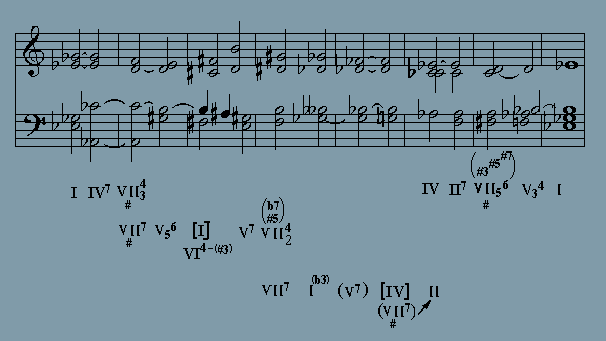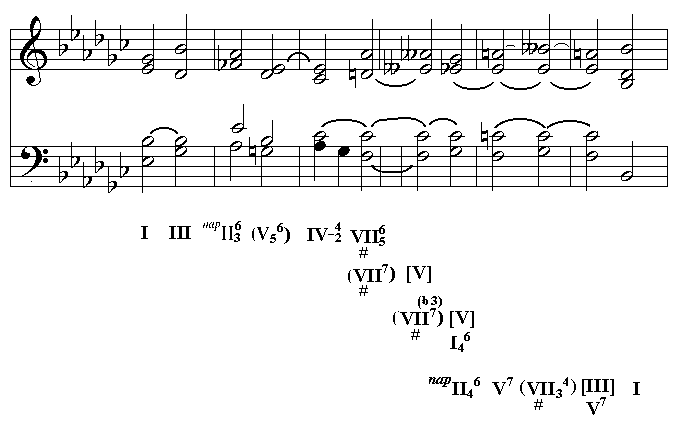Archivio Storico:- ex Dipartimento di Musica e Spettacolo - Universita' di Bologna
Esercizio 1
Facoltà di Lettere
e Filosofia
Corso di laurea in Discipline dell'Arte, della Musica e dello
Spettacolo / Indirizzo Musica
a. a. 1999/2000
STORIA DELLE TEORIE
MUSICALI – Dott. MAURO MASTROPASQUA
|
Esercizio
1
Realizzazione a
quattro parti di una successione armonica a partire dai simboli
della teoria dei gradi: cfr. il programma d’esame dell’a.
a. 2000/2001
Si utilizzano i
simboli dei gradi armonici nel modo in cui sono presupposti dalla
teoria dell’armonia contenuta nel Manuale di armonia
di A. Schönberg. La teoria dei gradi proposta in questo volume
viene qui integrata da alcuni espedienti di cifratura, orientati
ad una visione funzionalista dell’armonia (per alcuni
aspetti già contenuta in nuce nella prassi analitica di Schönberg)
e la cui presentazione e il cui approfondimento sono normalmente
oggetto dei corsi della cattedra di Elementi di Armonia e
Contrappunto tenuti dal prof. Loris Azzaroni. Per
esemplificare i simboli di questa teoria integrata dei gradi, impiegata
nella prova d’esame, prendiamo in considerazione un
esercizio di media difficoltà svolto durante le lezioni dell’a.
a. 2000/2001:
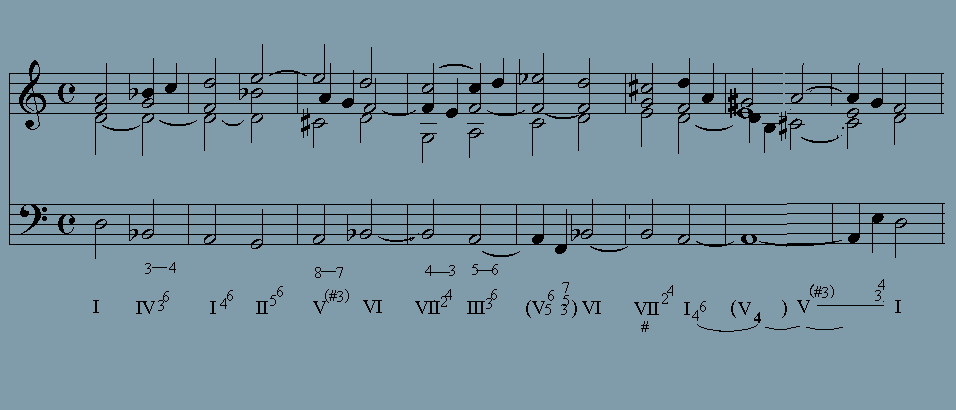
(click
sull'immagine per ingrandirla)
- Suoni
estranei all’armonia. Sono indicati con numeri
arabi. Esempi: 1) La nota di passaggio al sop. (b.
1: do) è una quarta rispetto alla fondamentale.
Si indica quindi con la cifra "4" . In questo
caso la numerica specifica da quale nota dell’accordo
si vuole far procedere questa dissonanza di passaggio: la
quarta proviene dalla terza dell’accordo (da cui la
numerica 3–4). Queste indicazioni servono anche per
ogni altro tipo di "suono estraneo all’armonia".
Da notare, ad esempio, il ritardo (4–3) a b.
4 (cont.).

- Specificazione
della qualità degli intervalli. Un segno come "(#3)"
- vedi b. 3 - specifica che la terza dell’accordo
deve essere maggiore. Questa specificazione è necessaria
nel modo minore perché la sola indicazione "V"
si riferirebbe ad un accordo di la minore (V grado della
scala naturale di re minore). In questo caso il do#
non può essere considerato un’"alterazione",
perché fa parte del sistema sonoro "re minore",
che implica sia la regione "naturale" (quindi
con le note sib e do) che quella "melodica"
(quindi con si naturale e do#). In altri
casi, un’indicazione simile alla precedente potrebbe
invece significare un’alterazione di una delle note
proprie ad un certo accordo riferito ad una determinata
scala. Ad esempio, l’indicazione "(b5)"
si riferisce all’abbassamento della quinta di un
accordo. Perciò nella tonalità, poniamo, di Do
maggiore, un simbolo come III7(b5), dovrà essere
interpretato scrivendo l’accordo mi-sol-sib-re.

- Dominanti
secondarie (e altri accordi secondari). Compaiono sempre
tra parentesi. Ogni grado armonico che si trova tra
parentesi deve essere interpretato come grado
appartenente non alla tonalità nella quale ci si trova,
ma a quella implicita nel grado armonico successivo -
come se il grado successivo a quello scritto tra
parentesi fosse una tonica. Caso classico: "(V) V".
Qui la cifratura significa: "il primo accordo è un
V grado del V grado" (dominante della dominante). Se
siamo in Do maggiore, l’accordo tra parentesi è
costituito dalle note re-fa#-la, poiché questo è
il V grado di Sol maggiore, a sua volta V grado della
tonalità in cui ci troviamo. Quando ad essere tra
parentesi è un V grado – e non compaiono ulteriori
specificazioni di genere degli intervalli - lo si intende
sempre come accordo maggiore (non c’è bisogno della
specificazione "(#3)"). In sostanza, si
tratta di una modificazione della cifratura della teoria
dei gradi ispirata ad una visione funzionalista dell’armonia.
L’alternativa "classica", proposta da
alcuni manuali, di indicare quell’accordo di Re
maggiore come II grado alterato (ad esempio con il
simbolo
II), non è altrettanto
perspicua nell’indicare il senso del processo
armonico in corso - cioè l’enfasi conferita al V
grado grazie all’introduzione della sua dominante (e
a voler tacere del fatto che un II grado alterato
potrebbe essere anche un accordo diverso da una dominante
vera e propria). Una simbologia di questo tipo permette
certe sottigliezze di cifratura a volte necessarie per
rendere conto del senso di un passaggio. Se ad esempio,
si ascolta attentamente l’esempio successivo, e si
confrontano i due segmenti armonici di b. 1-2 (primo
quarto) e, rispettivamente, 5-6, ci si renderà
facilmente conto che in queste ultime è un’indicazione
come (IV) IV, e non VII-IV, ad essere aderente al dettato
compositivo e a ciò che si sente (il senso del passaggio
è quello di un procedere per sottodominanti: si toccanp
quella della tonica e poi quella della stessa
sottodominante):
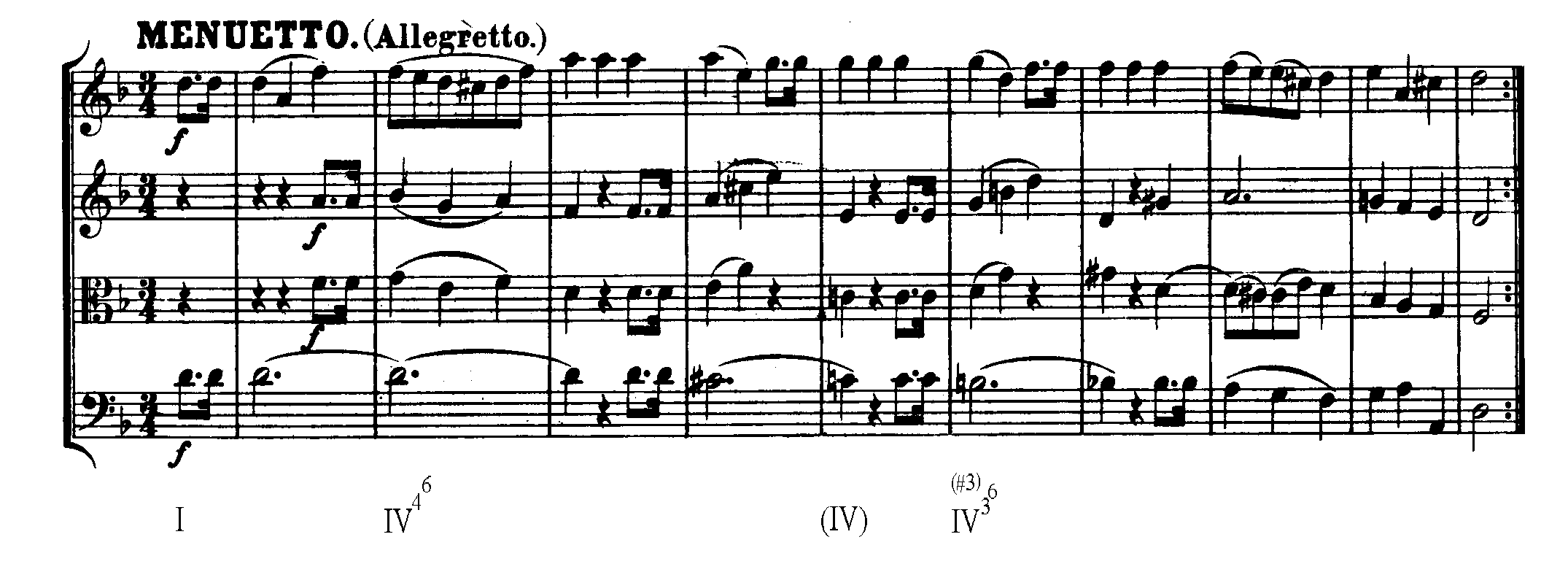
(W.A. Mozart, Quartetto KV 421) (click
sull'immagine per ingrandirla)
Nella
successione armonica del primo esempio, il primo caso di
dominante secondaria è a b. 5: una settima di dominante,
in quinta e sesta, del VI grado di re minore. Da notare
che qui la qualità di dominante secondaria dell’accordo
tra parentesi - che è già un accordo maggiore - gli è
conferito dalla settima minore mib. Quindi ad
esempio, nel simbolo "(V7) VI",
poiché per definizione un V grado racchiuso tra
parentesi deve essere una dominante, è implicito che la
settima sia minore. Altri tipi di accordi secondari sono
rappresentati seguendo gli stessi criteri fin qui
delineati. Ad esempio, in la minore il simbolo (II)IV
indica un accordo diminuito (mi-sol-sib) che
risolve su re-fa-la. (infatti la regione di re
minore, come tutte le regioni minori - e a meno che la
cifratura non indichi altrimenti - ha sul II grado un
accordo diminuito). Per ulteriori specificazioni di
questo tipo, si vedano i due esempi successivi.

- Accordi di
settima diminuita: Sempre indicati con il simbolo #VII7
(vedi b. 6 del primo esempio).

- Accordi
aumentati (seste tedesche): #VII7(b3)
(ad es.: fa#-lab-do-mib in Do maggiore = (#VII7(b3))
V

- Accordo di
sesta napoletana = nap
II

- Elisione
armonica (ad es.: cadenze d’inganno) = V
[I] VI
(l’accordò di risoluzione implicato
dal precedente non si presenta: viene indicato tra
parentesi quadre. Al suo posto compare l’accordo
posto sotto quello racchiuso tra parentesi).
Di seguito, due
esercizi (grado di difficoltà elevato), tratti da prove d’esame
dell’a. a. 1999/2000. In entrambi sono state assegnate la
cifratura e la tonalità di partenza, mentre delle regioni
armoniche verso le quali ci si sposta si conosceva solo la
modalità (nel primo esercizio ci sono due regioni centrali in
modo maggiore; nel secondo quella centrale è maggiore e quella
conclusiva, cui si modula, è minore). Gli accordi sovrapposti
verticalmente sono (secondo la terminologia di Schönberg) "neutri"
tra due regioni armoniche, così che la regione verso la quale ci
si muove possa essere determinata.
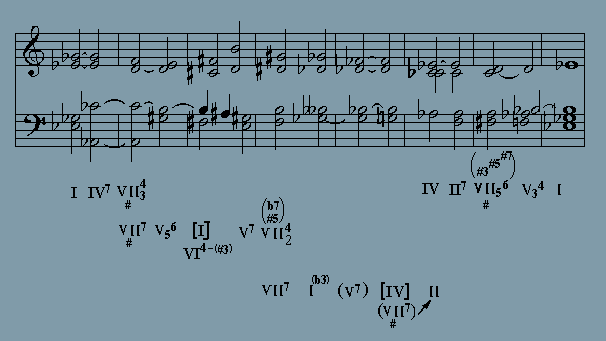
Il primo esempio
è un caso di modulazione con ritorno al punto di partenza (mib
minore). Il passaggio dalla prime alla seconda battuta chiarisce
il principio generale della neutralità accordale su cui si
basano questi esercizi. La settima diminuita di mib (re-fa-lab-dob)
deve essere interpretata enarmonicamente: come si desume dalla
doppia cifratura dell’accordo, esso, inteso come sol#-si-re-fa,
conduce alla regione di La maggiore.
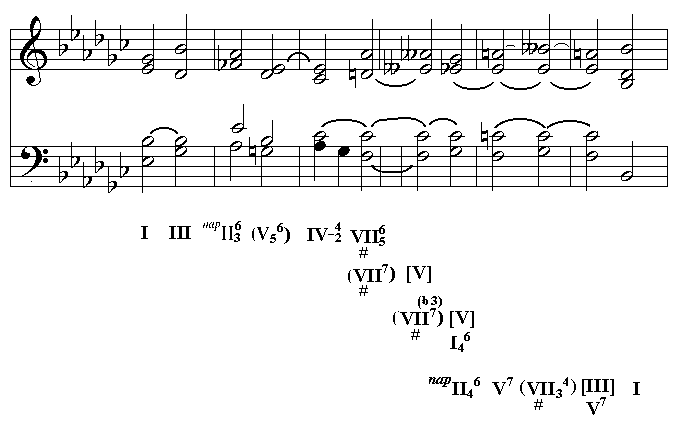
Anche la chiave di
volta del secondo esercizio è l’interpretazione enarmonica
di una settima diminuita (a b. 3: che sia necessaria un’interpretazione
enarmonica è implicito nella doppia cifratura della stessa
armonia, che nella tonalità di provenienza è in terzo rivolto,
ma in quella di arrivo è in stato fondamentale). La complessità
della cifratura potrebbe essere notevolmente ridotta. Ad es., è
chiaro che la settima diminuita del III grado di sib minore (tra
le ultime due battute) è la stessa della tonalità medesima,
sicché l’accordo solb-do-mib-sibb (cioè do-mib-solb-sibb)
e il simbolo (#VII34)
[III] potrebbero essere sostituiti, rispettivamente,
dall’accordo solb-do-mib-la (= la-do-mib-solb)
e dal simbolo (#VII24).
Ma è chiaro che complicazioni di questo tipo sono volute in
questi esercizi. Essi servono anche ad acquisire dimestichezza
con quegli aspetti "enigmistici" della questione che,
per dirla con Schönberg, una volta acquisiti potranno assolvere
ad "un fine più alto".
Esercizi utili:
- riscrivere le
successioni precedenti in altre tonalità;
- desumere da
segmenti modulanti di brani tonali una successione di
gradi e realizzarla poi come esercizio a quattro parti.
Ritorno alla pagina iniziale
Archivio Storico:- ex Dipartimento di Musica e Spettacolo - Universita' di Bologna