
La mano e l'occhio
di François Jost
Se sul piano teorico gli anni ottanta sono stati caratterizzati dallo studio dell'enunciazione cinematografica, lo sono stati anche, da un altro punto di vista, dal ritorno di una corrente preoccupata delle opere, della loro genesi come della loro estetica. Mentre gli uni - semiologi, narratologi, poco importa come li si voglia chiamare - continuavano sotto l'impulso degli anni sessanta a rifiutare ogni istanza antropomorfizzante, lasciando l'autore fuori dalla porta delle loro costruzioni teoriche, gli altri favorivano il suo rientro dalla finestra concentrandosi su una pluralità di opere riunite sotto un unico nome.
Paradosso: è proprio il regista che aveva lottato con più forza contro quanto l'idea d'autore nascondeva di autoritario e di gerarchico, fino a dissolversi nel Gruppo Dziga Vertov, che in un certo senso ha rilanciato il movimento. Da un decennio gli articoli e le monografie su Godard si sono moltiplicati, non senza un certo imbarazzo iniziale, riconoscibile in questa prefazione della Revue belge du cinéma: "L'obbiettivo del numero non è mai stato, come in molte riviste e pubblicazioni recenti, di riproporre le eterne questioni giornalistiche sul nome proprio, sull'individuo Godard, sui suoi atteggiamenti e comportamenti, sulle sue dichiarazioni e provocazioni, sulla sua griffe e sui suoi rapporti con i media [...] Questa pubblicazione ha infatti per solo oggetto l'insieme dei film e dei video di JLG così come sono, nella loro realtà tanto interna quanto esterna..." (1)
Il prefattore è manifestamente consapevole della sua operazione, anche se la nega: certo, cancella il nome proprio e l'individuo sostituendoli con delle iniziali (che sono esattamente la sua griffe, perché danno il nome alla società di produzione di Godard), ma non arriva fino a rimettere in discussione il fatto che la molteplicità dei suoi film e dei suoi video (malgrado la distanza temporale che li separa, l'eterogeneità delle condizioni della loro produzione e dei loro supporti) formino un insieme.
In seguito questa esitazione a raccogliere dei film sotto un nome d'autore è del tutto scomparsa in coloro che per un attimo l'avevano manifestata: le collane didattiche e i convegni (Lumière, Lang, Renoir...) si sono susseguiti per un decennio senza che nessuno provasse il minimo imbarazzo.
Ma lasciamo da parte questa evoluzione e soffermiamoci per un istante sul momento attuale, in cui l'estetica del cinema o la critica esprimono dei bisogni che non coincidono più con gli sviluppi semio-narratologici recenti, per ricordare che il problema non è nuovo, poiché è centrale anche per colui che ha contribuito ad uccidere l'autore. Infatti nel 1969 Michel Foucault riconosceva di essere incorso in una contraddizione: sebbene in Les Mots et les choses egli mirasse ad analizzare "vari tipi di strati discorsivi che non erano ritmati dalle solite unità fra libro, opera e autore", (2) non aveva cessato di ricorrere a nomi d'autore (Buffon, Cuvier, ecc.). Individuato questo paradosso, il problema non è più di eliminare il nome con un sotterfugio - iniziali o altro - ma di comprendere ciò che sta dietro ad esso. E' con questo spirito che il filosofo pone brutalmente la domanda "Che cos'è un autore?", focalizzando l'attenzione principalmente sugli scrittori - cosa che, detto per inciso, non fa che riaffermare il primato del letterario nella costituzione del campo delle produzioni umane (in francese, precisa il Dictionnaire Historique de la Langue Française, autore significa rigorosamente scrittore).
 |
L'autore, risponde per prima cosa Foucault, appare nella nostra cultura a partire dal momento in cui si incomincia ad attribuire dei testi a un'individualità. Questo procedimento di attribuzione è correlativo a una concezione dell'opera che seleziona, sceglie nelle tracce lasciate da qualcuno ciò che costituisce appunto la sua opera. Una simile operazione appare particolarmente rischiosa nel cinema per ragioni che riguardano la natura stessa dell'opera cinematografica. Sotto questo aspetto, le origini del cinema sono un terreno favorevole per osservare il processo sul nascere. |
In che modo il film acquisisce lo statuto di artefatto? In quale tradizione artistica si situa? Con quale tipo di opere è imparentato? L'ipotesi che svilupperò nelle pagine che seguono è che la difficoltà di circoscrivere e definire la figura del suo autore dipenda dalla natura ibrida delle opere che produce. Ma procediamo con ordine e osserviamo la nascita dell'autore cinematografico...
E' opinione diffusa, almeno in campo artistico, che un autore si definisca per il fatto di produrre un oggetto con una data intenzione. Per esempio, secondo Arthur Danto, la differenza fra un barattolo di zuppa Campbell o di cera Brillo e un'opera di Wahrol non risiede nelle proprietà visive degli oggetti - che sono le stesse - ma nel fatto che la seconda è "a proposito di qualche cosa": possiede una aboutness che le conferisce la sua intenzionalità artistica e la allontana, qualunque sia la sua natura, dall'oggetto reale a cui rassomiglierebbe in tutto e per tutto. Genette va più in là, affermando che ciò che conta in un ready-made non è "né l'oggetto proposto in se stesso, né l'atto di proporlo in se stesso, ma l'idea di questo atto". (3) Il fatto che le discussioni sulla natura dell'arte, che continuano ad alimentare tanti lavori, si siano focalizzate sullo scandalo rappresentato dagli oggetti esposti da Duchamp o da Wahrol avrebbe dovuto suscitare un'eco maggiore presso l'estetica del cinema. Perché, se l'arte moderna segna un punto di rottura proponendo la banalità delle cose a un mondo dell'arte che le trasfigura, il cinema nasce in questa banalità e il suo prima sforzo è quello di trovare la strada per la sua trasfigurazione. Dovrà passare più di un ventennio perché Aragon, due anni dopo l'esposizione da parte di Duchamp della sua ruota di bicicletta, osservi che sullo schermo gli oggetti "si trasformano a tal punto da rivestire dei significati minacciosi o enigmatici quando, appena prima, erano solo dei mobili o dei blocchetti per assegni". (4) Delluc, da parte sua, si meraviglia davanti alla "bellezza dell'automobile, del treno, del piroscafo, dell'aereo [che] legittima finalmente [...] i poeti". (5)
Prima di allora il cinema non apparteneva al mondo dello spirito o del pensiero, se si preferisce, che è l'orizzonte presupposto da Danto quando definisce l'opera per l'intenzione e da Genette quando rinvia all'idea. Mentre il gesto di Duchamp interviene nel contesto di una pittura e di una scultura che hanno raggiunto da circa due secoli le arti liberali, il cinema per almeno due decenni si colloca tra le arti meccaniche. Doppiamente, si potrebbe dire. Apparso nell'epoca della riproduzione, esso è soprattutto, e prima di tutto, un'arte della meccanica in senso proprio, priva quindi in partenza di quella umanità che conferirebbe al film un pieno valore di artefatto e faciliterebbe la sua trasfigurazione in un'opera.
Il mito fondatore del cinema, con i suoi spettatori che si scostano per non farsi travolgere da locomotive o tram scagliati su di loro, non pone l'enfasi che sul primo aspetto, e in maniera talora ingannevole. L'effetto di realtà agisce meno per comparazione o per analogia col modello che per il fatto di produrre il sentimento di una continuità fra lo schermo e la sala. L'assenza di un'istanza in grado di mediare la relazione fra l'immagine e colui che la osserva induce il pubblico a dubitare del proprio statuto: attori o spettatori? "Non vi è più separazione, né vuoto, né assenza: si entra nello schermo, nell'immagine virtuale senza ostacoli. [...] Soltanto nella rigida separazione della scena e della sala lo spettatore è attore a pieno titolo. Ora, tutto oggi concorre all'abolizione di questa cesura". (6) Questa osservazione di Baudrillard sulla nostra situazione attuale potrebbe applicarsi altrettanto bene a coloro che scoprono il cinema alla fine del XIX secolo. Un oggi di vecchia data...
Tuttavia l'impressione fisica - da prendere evidentemente con le molle - è meno importante di questa continuità semantica che ci fa riconoscere nella vue (nel doppio senso della parola) la banalità del nostro mondo, mostrata tale e quale, senza che nessuno si interponga fa essa e noi, come dice in sostanza Bazin. Nulla è più estraneo allo spettatore del 1900 che accostare le vedute Lumière a Poussin, Velasquez o Chardin - come fa Aumont. (7) Come potrebbero rinviare a dei pittori,
quando non sono neppure autorializzate? Lungi dall'ancorarsi a degli esseri che ci rassomigliano, queste tracce non sono che la pellicola del mondo in tutta la sua banalità, e se vi è bellezza, la devono soltanto ad esso, come è attestato da numerose pubblicità dell'epoca che vantano la bellezza dei film evocando quella dei luoghi filmati.
Sotto questo aspetto la ricezione del film si avvicina molto a quella della pittura, a condizione di precisare che non si tratta né di una storia della pittura ridotta arbitrariamente alla storia dei grandi pittori, né di uno sguardo colto sui quadri. Bisogna ricordare che lo stesso Poussin, citato sopra come modello di pittore, giudicava ancora la qualità dell'opera col metro del soggetto: (8) con questo non faceva che testimoniare, certo un po' tardivamente, un modo di ricezione che fu maggioritario fino all'insediamento di ciò che Nathalie Heinrich chiama "l'intellettualizzazione dello sguardo", e di cui il cinema è l'erede.
Un modo di ricezione che dimentica l'autore a beneficio di quanto ha rappresentato. La bellezza naturale raggiunge lo spettatore in modo tale che le immagini assumono l'aspetto di una traccia, di un'impronta, e non di un artefatto. Ora, a guardare più da vicino, questa impressione non scaturisce unicamente dalla natura del cinema; la pittura la provoca già, quasi negli stessi termini: "Scegliete un luogo - dice Diderot a proposito di Vernet -, disponete in questo luogo gli oggetti secondo le mie istruzioni e siate sicuri che avrete visto i suoi quadri". (9) Qui, come altrove, il cinema intrattiene legami profondi con la pittura, e ciò non tanto per la corrispondenza dei suoi effetti - quadro, colori, luce - e per l'affinità del suo dispositivo, ovvero per la sua relazione con l'occhio, con la vista e con la visione, quanto per la sua relazione con la mano, nella quale si deve cercare lo statuto dell'autore cinematografico.
Nell'arco di una ventina d'anni, il cinema vivrà l'intera evoluzione della pittura dal Medio Evo al XVII secolo. Infatti nei suoi due primi decenni si colgono molto bene i tre momenti che conducono dal pittore all'artista: "il polo del mestiere, che vincola la retribuzione al criterio materiale e stabilizzato del prodotto, il polo della 'professione' o dell''ufficio', che la vincola al criterio relativamente prevedibile della persona, e il polo dell''arte', che la vincola al criterio fluttuante, immateriale e personalizzato della fama acquisita dal creatore". (10)
Al "polo del mestiere" corrisponde quel momento - alcuni secoli per il pittore, un po' più di un decennio per il cineasta - in cui l'esecutore è pagato al metro, di superficie dipinta o di pellicola impressionata, in funzione del soggetto rappresentato. All'inizio del XVII secolo una storia profana vale 85.000 franchi e una storia sacra 150.000. Una scena di genere costa 50.000 franchi, mentre una natura morta ne vale solo 5.000. Il cinema delle origini conosce ugualmente una quotazione dei film secondo i generi, come attesta questo annuncio trovato su Ciné-Journal, che si affida a un'aritmetica elementare: "Noleggiamo per 5 franchi ogni 300 metri di pellicola contenenti sia un grande Dramma, sia un bel dramma e una commedia". (11) La classificazione delle immagini secondo Méliès, con le images naturelles al gradino più basso della gerarchia e le images composées al vertice, echeggia del resto il valore decuplicato della "scena di genere" in rapporto alla natura morta. In entrambi i casi domina il soggetto.
A questo stadio colui che realizza l'immagine è a malapena un autore, poiché l'autorità del cliente prevale sulla sua: il committente ordina al pittore di correggere questo o quel dettaglio del quadro, (12) il chirurgo non considera un autore colui che filma la sua operazione. (13)
| Con il polo della professione sorge la rivendicazione del talento. "I pittori pretendono, a torto o a ragione, che la loro arte non sia pagata solo in base alla quantità di lavoro necessario, ma anche secondo il grado del loro impegno e della loro esperienza". (14) Non si coglie in questa rivendicazione, della quale l'arcivescovo di Firenze si fa portavoce nella prima metà del XV secolo, quella degli sceneggiatori che chiedevano che le "opere rappresentate cinematograficamente non fossero più pagate dagli editori forfettariamente, al metro di positivo, bensì dagli esercenti per ogni passaggio dei film sullo schermo"? (15) Il discorso vale anche per gli autori di teatro. |  |
E' del resto ciò che osserva M. Ducrot, che Ciné-Journal definisce "uno dei nostri più illustri registi". Opponendo gli autori "direttamente interessati" (Zecca e gli altri) agli "autori drammatici", egli esclama: "Dovete aspettarvi questa resistenza, non potete pensare che tutti gli autori e registi cinematografici, non essendo sindacalizzati né associati, cedano il posto spontaneamente ai vostri autori, che nel nostro mestiere fino a questo momento non hanno ancora dimostrato nulla". (16)
Non si potrebbe dir meglio: l'autorialità spetta a colui che "dimostra" qualcosa attraverso il suo talento, identificato qui con chi mette in immagini. Come il pittore, che a questo stadio dell'evoluzione della sua attività sostituisce la remunerazione al pezzo con un trattamento annuale, una pensione, il regista cinematografico viene scritturato dall'"editore". In questa fase l'autore è esattamente, secondo la sua definizione etimologica, colui che aumenta la fiducia, cioè colui che vende, il venditore, il mediatore, e come tale - nonostante stia lottando per il diritto al proprio riconoscimento - si cancella dietro colui che lo paga e che assicura la commercializzazione della sua opera.
Solo il terzo polo mette in primo piano la singolarità di un nome, attestata dalla firma, e l'unicità di un uomo conosciuto attraverso la sua biografia e le sue interviste. Esso corrisponde precisamente a quella funzione-autore che, nel cinema come in letteratura, permette a un individuo di appropriarsi di un'opera, periodo che coincide, in entrambi i casi, col momento in cui sorge la questione dei diritti d'autore. E' solo quando l'artista comincia a emergere come figura unificante e identificata che la copia diventa una pratica condannabile: notiamo che la parola "plagio" appare solo verso il 1760, all'alba della figura romantica dell'autore, e che nel cinema ha senso soltanto per colui che precede i suoi confratelli nella costituzione di un'identità autoriale: Méliès.
Ma torniamo a quel primato della mano che, secondo la mia ipotesi, condiziona lo statuto del cinema delle origini molto più del mimetismo quasi obbligato e automatico della fotografia (del resto è lo stesso Méliès a confermarlo, affermando: "Sono al tempo stesso un lavoratore intellettuale e manuale. Il cinema è interessante perché è prima di tutto un mestiere manuale"). Traccia della realtà come la fotografia, questo cinema, per l'organizzazione e la gerarchia dei suoi mestieri, evoca infatti assai più l'incisione, nata anch'essa da un'impronta: lo studio dei primi cineasti ricorda del resto l'atelier dell'incisore del Rinascimento. Si giudichi il seguente passaggio: "In fondo alle antiche incisioni si poteva leggere: X pinxit, invenit, delineavit, componit o figuravit, Y fecit, indicit o sculpsit, Z excudit o impressit. Una simile gerarchia delle firme tradisce chiaramente la divisione che presiedeva all'organizzazione dell'atelier classico: al centro il maestro, produttore di idee, circondato di aiutanti, spesso ridotti al ruolo subalterno di esecutori". (17) Le vues composées obbediscono esattamente a queste tre funzioni: in cima colui che ha l'idea, l'autore drammatico o lo sceneggiatore, nel mezzo coloro che fanno, cioè nel nostro caso gli interpreti, gli attori, e coloro che fissano ciò che vedono, che girano la manovella, al gradino più basso della scala.
Del resto tutti gli sforzi di chi lottava per il riconoscimento del proprio lavoro - gli "autori e registi cinematografici" - miravano a ricondurre all'interno dello studio colui che inventa (invenit), ma non a modificare realmente questa gerarchizzazione che concedeva, per il film come per l'incisione, lo statuto autoriale all'inventore dell'idea, negando invece ogni autorialità al responsabile dell'impressione dell'immagine (sulla carta o sulla pellicola).
Se, dunque, all'origine il cinema prende a prestito dalla pittura, non si tratta dell'attività liberale, liberata e intellettualizzata che diverrà tardivamente, ma da quella "officina delle immagini" che era l'atelier sottomesso alla maledizione della mano, condannata alla mancanza, semplice esecutrice dello spirito di un altro e asservita all'autorità del donatore o del committente. Perché il cinema, contemporaneo all'impressionismo, ritorna a un'idea del pittore e della pittura anteriore al romanticismo? In realtà questa domanda si pone soltanto se si riduce la storia a semplici sezioni temporali in cui la sincronia detta legge, deducendo dalla concomitanza tutta una serie di influenze e di connivenze: il cinema e la psicanalisi, il cinema e l'impressionismo, ecc. Come ho mostrato altrove, (18) il cinema è più vicino a un modello popolare del cervello, del sogno e dell'allucinazione che alla moderna teoria dell'inconscio. Esso ugualmente rivive, con qualche secolo di ritardo, la condizione delle arti meccaniche, e ciò per il semplice fatto che all'inizio è sentito come un'attività manuale. Poco importa di che tipo: più prossima alle arti applicate che a quelle figurative. Come è noto, questa opposizione permetteva ancora di stabilire una gradazione fra le specialità dei produttori di immagini. Pur essendo giudicate nel complesso inferiori rispetto alle arti liberali, le arti meccaniche non erano tutte situate allo stesso livello: "nel contesto della sottovalutazione del 'manuale' rispetto allo 'spirituale' - scrive ancora N. Heinrich - un certo privilegio era accordato a ogni tecnica che, impegnando una mano - piuttosto che una molteplicità di mani anonime o, peggio ancora, di macchine -, manifestava la preminenza del gesto (segno di matita o pennellata) sull'azione meccanica (fusione, pressione, tessitura), dell'organo (mano, occhio) sull'utensile (forno, martello, telaio) e, di conseguenza, dell'individuo sulla materia, dell'umano sull'inanimato, dell'unico sul ripetitivo. Una frontiera separava i 'procedimenti di espressione diretta' dalle altre tecniche, dipendenti principalmente da fattori concreti come la dimensione, il costo dei materiali e la mano d'opera". (19) Per tutte queste ragioni i tappezzieri, i ricamatori, gli ebanisti, i bronzisti erano sottovalutati rispetto a coloro che realizzavano direttamente le immagini: i pittori.
 |
Si comprende quindi facilmente perché i diversi mestieri che partecipano alla confezione delle vues naturelles, come delle vues composeés, si avvicinano più allo statuto delle arti applicate che a quello delle arti figurative. Il gesto di chi gira la manovella, per essere perfetto, deve perdere ogni individualità fino a divenire meccanico, ripetitivo. Il paradosso dell'operatore è che la sua abilità manuale deve tendere a una perfezione tale da far dimenticare la sua mano: egli si avvicina a tal punto alla macchina che può essere sostituito da qualsiasi altro operatore altrettanto abile. Ne testimonia il fatto che durante tutto il periodo del muto l'espressione tourneur de manivelle, talvolta trasformata in tourneur de moulin à café, avrà una connotazione fortemente dispregiativa. (20) |
Quanto ai film girati in studio, per il ruolo determinante delle tele dipinte - di cui Méliès ricorda le grandi difficoltà di esecuzione -, degli arredi, dei costumi e dei diversi trucchi utilizzati, si situano al tempo stesso sul versante delle arti applicate e della decorazione mediatisée, e non godono quindi del privilegio relativo che si conferisce all'espressione diretta. Non stupisce che in queste condizioni coloro che li eseguono non possano innalzarsi al rango degli artisti.
Incisione, disegno, esecutore, interprete, copia... Dietro queste parole, emerse nel corso di una ricognizione storica, traspare in filigrana un'altra problematica, più filosofica, quella dell'autografia e dell'allografia. Ricordiamo che secondo Nelson Goodman un'opera autografica si definisce per la sua possibilità di essere copiata e per il fatto che si può legittimamente distinguere l'originale dalle eventuali contraffazioni. Con l'opera allografica, al contrario, l'idea stessa della copia non ha più alcun senso: copiare l'opera equivale a rieseguirla. Mentre è possibile, ad esempio, rifare dei falsi Rembrandt o dei falsi Vermeer (come del resto è accaduto), non si può copiare rigorosamente La Recherche du temps perdu senza riscriverla tale e quale, e si può proporla al lettore in svariate tipografie senza cambiarla di una virgola. Secondo il filosofo americano l'opera allografica è legata prima di tutto all'esistenza di un sistema di notazione che permette a diversi esecutori di riprodurre l'opera senza modificarla e contraffarla: posso certamente spacciare un'esecuzione per un'altra - attribuire a Menhuin una registrazione del Concerto alla memoria di un angelo quando invece è interpretato da mio zio -, ma questa frode sull'esecutore non la rende certo una copia dell'opera di Berg.
Per qualificare i sistemi di notazione che permettono di identificare l'opera diversamente interpretata, Goodman impiega il termine "spartito", che definisce in questo modo: "Uno spartito, che sia usato o meno come guida per un'esecuzione, ha quale sua funzione primaria quella di identificare con autorevolezza un'opera da un'esecuzione a un'altra". (21) Per quanto la riflessione del teorico non tratti apertamente la questione dell'autore, essa traccia nondimeno una frontiera fra due forme di autorialità, autografica e allografica, prospettando implicitamente diversi tipi di relazione, più o meno stretta, fra l'autore e l'opera.
Il pittore o il disegnatore mantengono sempre una relazione diretta con la propria opera. Lo schizzo può certo contenere in nuce il quadro, ma non definisce un'opera nel senso in cui delimiterebbe una classe di esecuzioni: è un'opera esso stesso, dal momento che non vale come carattere di un linguaggio notazionale. In questo regime autografico, l'autenticità si giudica solo attribuendo l'atto al suo autore, concepito come causa efficiente, e dunque legato al suo oggetto da una relazione indiziaria.
Al contrario, l'opera del musicista è "svincolata" dalla "dipendenza da un autore particolare o dalla data o dai mezzi di produzione". (22) O, per meglio dire, circola lontano da esso, ma con la garanzia di una permanenza assicurata dalla notazione. La partitura definisce l'opera, delimitando la classe di esecuzioni che le appartengono (anche quando prevede dei percorsi facoltativi come in certi compositori moderni). Inversamente, essa è determinata unicamente dal sistema di notazione che la regge: l'esecuzione non è, secondo Goodman, che l'esemplificazione della partitura. L'autore è presente nelle diverse esecuzioni della propria opera sotto la forma astratta di un'autorità il cui potere si arresta là dove comincia la performance.
Quando ci si rivolge verso le arti dello spettacolo - e, specificamente, della scena - queste idee sull'autorialità perdono di chiarezza. In quanto ripete i dialoghi scritti da un drammaturgo, la performance teatrale corrisponde più o meno all'esecuzione di una partitura. Al contrario le indicazioni sceniche, la recitazione degli attori, la descrizione delle scenografie - le didascalie - sono piuttosto scripts. Denotazioni di oggetti non verbali, "approssimativamente notazionali", lasciano al regista un ampio margine di manovra. Quanto alla versione cinematografica e muta del dialogo, ecco l'opinione di Goodman: "Il copione di un film muto [sarebbe meglio dire la sceneggiatura] non è né l'opera filmica né un suo spartito ma, per quanto usato nella produzione del film, è semmai correlato vagamente all'opera come la descrizione verbale di un quadro al quadro stesso". (23)
Come definire allora il cinema?
In questo Goodman non è di grande aiuto. Certamente per il fatto che il cinema, come osserva Genette, appartiene alla categoria dei "mostri multimediali". Mescolanza di materie dell'espressione molteplici, esso dipende senza alcun dubbio da diversi regimi.
In quanto fotografia animata, ubbidisce alla stessa logica della fotografia. Anch'esso si situa sul versante delle arti autografiche "multiple", intese con Goodman come arti "che [solamente] al loro primo stadio sono singole". (24) In quanto impronta, incontro del mondo e di un agente chimico, è singolo; per le copie che se ne possono trarre, è multiplo. Bisognerebbe inoltre restringere queste osservazioni all'immagine canonica: certi film come Arnulf Rainer (Peter Kubelka, 1957-1960), che avvicenda durate di immagini nere e bianche, possono essere rifatti da chiunque possieda la formula del montaggio. Meglio: un film di immagini sintetiche, come Toystory, interamente prodotto secondo un sistema di notazione numerico, può essere eseguito da chiunque possieda l'algoritmo che le genera e può anche circolare indipendentemente dalla sua rappresentazione visiva sotto forma di fichiers.
Questi due tipi di film si prestano perfettamente alla prova di concordanza ortografica che permette di verificare se l'esecuzione corrisponde alle proprietà della partitura che la genera o che ripete. Contrariamente all'incisione, i cui diversi esemplari non possono essere sottoposti a un simile test.
| Nella sua dimensione scenica, quella dell'interpretazione dell'attore, il cinema resta ancora situato sul versante dell'autografia, poiché riproduce, poiché capta l'identità numerica di una performance così irripetibile che il regista, prima del montaggio, deve scegliere la ripresa che preferisce. Questa unicità è tuttavia contestabile: la recitazione dell'attore - soprattutto quella di un attore noto - è spesso codificata a tal punto che le diverse performance costituiscono una serie di gesti ripetuti così di frequente da divenire imitabili. Si pensi a Charlot e alle sue innumerevoli imitazioni o a Louis de Funès, imitazione di se stesso: la contraffazione è questione di costume e di maquillage. | 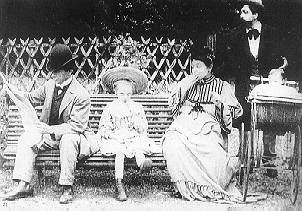 |
E la messa in scena? Genette concorda con Goodman sul fatto che essa sfugge parzialmente alla notazione. Tuttavia per il teorico francese la notazione, pur essendo indubbiamente un indice dell'allografia, (25) non costituisce una sua condizione indispensabile: da una parte "non è affatto necessario saper leggere la musica per riprodurre ad orecchio una frase musicale" (26); dall'altra ogni opera può divenire oggetto, un giorno o l'altro, di un sistema di notazione, ivi compreso un piatto per un critico gastronomico capace di ricostruirne la ricetta, (27) di modo che, come sostiene Goodman, l'autografia è sempre uno stadio di evoluzione artistica anteriore all'allografia. Ma Genette afferma soprattutto che l'opera autografica, nonostante le difficoltà di notazione che pone, si offre alla (de)notazione, concetto che sostituisce alla "partitura" di Goodman. Mentre quest'ultimo considera "l'opera allografica come una semplice collezione di occorrenze o di esemplari ('repliche') non totalmente identici, ma che una convenzione culturale pone come equivalenti", per Genette non è chiaro "in che cosa consista questa equivalenza senza fare appello a una qualche idealità, fosse anche nei termini di 'proprietà costitutive', di 'identità letterale' (sameness of spelling) o di 'conformità' (compliance) di un'esecuzione a una (de)notazione", (28) in modo tale che si possa concepire l'opera allografica come un "oggetto di pensiero che definisce esaustivamente l'insieme delle proprietà comuni a tutte le manifestazioni". (29) Questo oggetto "ideale" è costituito dalla riduzione allografica, operazione che "ha luogo ogni volta che un atto fisico (movimento del corpo o emissione vocale) è 'ripetuto' o che un oggetto materiale è riprodotto in maniera diversa da un'impronta meccanica", (30) e che consiste nel ricondurre "un oggetto o un avvenimento, dopo analisi e selezione, ai tratti che condivide, o può condividere, con uno o diversi oggetti la cui funzione sarà di manifestare al pari di esso, sotto aspetti fisicamente percepibili, l'immanenza ideale di un'opera allografica". (31) Detto altrimenti, il fatto che un'esecuzione ecceda largamente il suo sistema di notazione non impedisce di considerarla come una delle sue manifestazioni: il fatto che Mozart, dopo avere ascoltato il Miserere di Allegri nella Cappella Sistina, torni a casa e annoti a memoria tutto ciò che ha udito non significa, per Genette, che egli abbia trascritto tutte le sfumature dell'interpretazione, ma soltanto che ha ridotto l'opera alle sue "proprietà costitutive". (32) Per quanto concerne le opere che non possiedono (diversamente dalla musica e, in certi casi, dalla coreografia) un sistema rigoroso di notazione in grado di designare i mezzi verbali o d'altro genere che permettono di prescrivere l'esecuzione di un oggetto immanente, Genette preferisce parlare di denotazione piuttosto che di notazione, "poiché si tratta ogni volta di stabilire, utilizzando questo o quel modo, di solito convenzionale, di rappresentazione, la lista delle proprietà costitutive di tale oggetto ideale". (33)
La relazione fra il dramma e la rappresentazione teatrale, fra la sceneggiatura e il film, non è dunque più così vaga come affermava Goodman, poiché le istruzioni di scena costituiscono un sistema di denotazione che prescrive l'esecuzione, anche se "le indicazioni verbali incaricate di 'notare' degli oggetti non verbali, come le didascalie drammatiche o le ricette di cucina, soffrono (sotto questo aspetto) di tutti gli equivoci e gli slittamenti progressivi propri del 'linguaggio discorsivo': se una didascalia prescrive una 'poltrona Luigi XV' senza precisarne il colore, il regista, non potendo rispettare questa alchimia, mette ad esempio una poltrona Luigi XV blu". (34) Genette propone lo schema seguente: (35)
Immanenza messa in scena
Come risulta da questo schema, l'opera messa in scena è in parte allografica, in parte autografica. Il lato destro, quello della "denotazione", presuppone che le diverse versioni di un dramma, le diverse messe in scena possano essere più o meno trascritte e dunque rieseguite, e che, in sostanza, le differenze inevitabili fra una serata e l'altra non oltrepassino ciò che si giudica accettabile in nome della riduzione allografica. Il lato sinistro, al contrario, lascia alla rappresentazione, performance singolare di una compagnia di attori, la sua parte di autografia.
Bisogna ritenere come Genette che la relazione di denotazione con l'immanenza ideale della messa in scena sia sufficientemente prescrittiva per poter generare una serie di esecuzioni equivalenti o si deve accettare la concezione più restrittiva di Goodman, che subordina (checché ne dica Genette) l'allografia alla notazione? Per rispondere a questa domanda, non mi sembrerebbe inutile sottoporre l'opera a una prova di reversibilità: la messa in scena prescritta dalle didascalie è equivalente a quella annotata a posteriori? Senza dubbio no, e Genette lo ammette. Si può ugualmente, malgrado questa restrizione, trattare la messa in scena secondo il regime allografico? Il problema meriterebbe una lunga discussione che mi allontanerebbe dal tema: tornerò quindi all'ambito da cui sono partito, il cinema delle origini, per constatare che conferma la tesi di Genette. Se si pensa con lui che il regime allografico è meno una questione ontologica che di convenzione culturale e d'uso, e che non esistono opere allografiche senza un'arte allografica, si è costretti a constatare che il film viene accolto inizialmente come un'arte allografica (anche se questa ipotesi contraddice la tesi di Goodman, secondo il quale l'autografia precede l'allografia).
Le diverse versioni delle vedute Lumière - ad esempio le tre versioni di La sortie des usines - non sono considerate dallo spettatore del 1900 come copie, cosa che conferirebbe loro uno statuto autografico, ma come pellicole intercambiabili o equivalenti (non va diversamente al giorno d'oggi, del resto, per il pubblico non specialista). Quanto alle vues composées, si sa che per diversi anni gli sceneggiatori depositavano i loro "scripts" tanto per il teatro che per il cinema, circostanza che attesta che le differenze materiali fra dramma e messa in film non erano considerate pertinenti e che la sceneggiatura era, più ancora del testo teatrale rispetto alla messa in scena, un'idealità. Non vi è migliore illustrazione di ciò che questa esclamazione di Delluc alla visione di La dixième symphonie: "Ecco un film che non avrebbe potuto essere eseguito da nessun altro, perché il suo autore vi si manifesta in tutto". (36) Non si potrebbe dir meglio... e in termini goodmaniani!
La nascita del cineasta coincide col momento in cui il film è pensato come un'attività autografica. Prima, l'operatore o il compositore di vedute non è altro che l'esecutore anonimo e sostituibile di quell'immanenza ideale che è il testo dell'autore drammatico o la sceneggiatura dell'autore cinematografico. Alcuni, indubbiamente assai rari, giungono perfino a pensare che il film dipenda dalla notazione: "La cinematografia è una forma di notazione attraverso l'immagine, così come l'aritmetica e l'algebra sono notazioni mediante figure e lettere". (37) Dunque, per circa due decenni, l'autografia del film è percepita soltanto nella performance dell'attore, come attesta la sua preminenza nelle pubblicità (oppure nelle avventure di un personaggio, ad esempio Rigadin, che spostano l'autorialità dall'"a monte" del film alla sua manifestazione cinegrafica). Nel cinema delle origini esiste senza alcun dubbio l'idea che i personaggi, come sostiene lo sceneggiatore di Sunset Boulevard, siano i veri autori della sceneggiatura. La registrazione visiva non toglie né aggiunge nulla all'autografia della performance - il film è un'opera autografica multipla, secondo la definizione di Genette, perché è ridotto all'attore o al suo versante fittizio, e non perché definirebbe una maniera di vedere il reale, unica al punto da essere irriducibile a una semplice esecuzione.
Per il momento abbiamo considerato il film in quanto tale, fuori contesto, come manifestazione visiva meccanica, senza prestare attenzione a ciò che diviene quando è proiettato nella sala. Spettacolo commentato, subisce qui due importanti trasformazioni. La presenza - nonché la pregnanza - di un testo orale pronunciato nella sala, conferisce una preminenza all'attività narrativa: da attività meccanica, sottomessa alla mano, il film diviene un racconto, prescritto e organizzato dalla libertà del logos, slittando un po' di più verso l'autografia grazie alla singolarità di questa performance di un attore nella sala. Lo spettatore si ritrova, in definitiva, in una situazione che ricorda l'ascoltatore dell'aedo antico o del trovatore medievale. La chanson de Roland, ad esempio, conosciuta oggi attraverso sette manoscritti differenti per data, dialetto e versificazione, è "un'opera fondamentalmente mutevole", come osserva Zumthor, le cui versioni scritte che costituiscono i testi attuali non sono che gli stati di un'opera situata al tempo stesso "al di fuori e gerarchicamente al di sopra delle sue manifestazioni testuali". (38) I cataloghi che riferiscono le storie dei primi film fissano uno stato dell'opera di cui ciascuna delle interpretazioni commentate, lasciando libero corso all'immaginazione del conferenziere, può essere considerata come una versione, sfortunatamente perduta. Poiché l'autografia si misura ampiamente con il metro dell'improvvisazione, si può immaginare quanto questo racconto, sottomesso a una parola proveniente dallo stesso luogo dello spettatore - e dotata del potere di ancoraggio che la semiologia ha messo in evidenza -, dovesse contribuire a costruire agli occhi del pubblico un vero e proprio autore (39) (in modo analogo si tende oggi a identificare l'autore di un reportage televisivo con il giornalista che commenta le immagini). Per usare la terminologia genettiana, che fa molto al caso nostro, si potrebbe descrivere lo statuto dei primi film nel modo seguente: allografici in quanto registrazioni del reale o di una performance concepita come autografica, essi si presentano, in quanto spettacoli, come opere (l'espressione è contestabile) che si manifestano in diversi oggetti, i quali non appaiono realmente identici e intercambiabili a causa della performance in sala dell'imbonitore. Pluralità di immanenze che, come aggiunge Genette a proposito della chanson de geste medievale, "si accompagna a una pluralità di autori che firmano, se così si può dire, l'anonimato di questo tipo d'opera o la sua incertezza di attribuzione, simboleggiata dalla dubbia esistenza di Omero". (40) In queste condizioni, l'identità autoriale si regge sulla convinzione di partecipare a una tradizione del racconto, di cui l'imbonitore non fa che allungare la serie. Da ciò la presenza, in tutto il cinema delle origini, della Passione, delle leggende e delle epopee medievali proprie di ciascun paese. Rainer Rochlitz osserva che "storicamente la riduzione 'allografica' in letteratura dovrebbe essere situata al momento del passaggio alla letteratura scritta, anzi alla stampa, che definisce l'identità dell'opera indipendentemente tanto dalla voce del narratore e dalle sue intonazioni che dalla presenza del suo pubblico". (41) Allo stesso modo, si potrebbe formulare l'ipotesi che l'autorialità del cineasta nascerà solo con il trasferimento del racconto dall'autorità dell'imbonitore - che sa, come l'autore-venditore già evocato, vendere il film che presenta grazie al suo commento - alla mediazione indefinitamente riproducibile delle didascalie. Con queste parole nel film egli si stabilizza, abbandonando una mobilità che solo le improvvisazioni consentite dall'oralità favorivano. Non è un caso, evidentemente, se l'avvento delle didascalie è contemporaneo alla lotta degli sceneggiatori per essere pagati in funzione del loro successo. Poiché la parola circola sotto la forma allografica della scrittura - a tal punto allografica che oggi in certi casi si pone la questione dell'autenticità delle didascalie -, l'autore-venditore è in qualche modo espulso dalla sala e contemporaneamente l'esercente diviene semplice esecutore di uno spettacolo prestabilito, notato e impressionato sulla pellicola.
Queste argomentazioni convinceranno, o almeno lo spero, che l'autore di un'arte allografica non si identifica con l'autore di un'arte autografica, conclusione su cui non insistono né Goodman né Genette, che del resto non affrontano questo problema. Da cosa dipende la loro differenza? Prima di tutto, come ho già detto, dal fatto che nel regime allografico l'autorità è in qualche modo allontanata dall'esecuzione dell'opera, per il semplice motivo che è indiretta. Chi si applaude a una rappresentazione del Don Giovanni? Mozart o Van Dam? Mozart o Lorin Maazel? Senza dubbio più i secondi che il primo. Questo esempio suggerisce che quando siamo in presenza di arti che mescolano regime allografico e regime autografico il secondo prevale nella nostra valutazione. Un Don Giovanni eseguito male sarà fischiato, e Mozart non può farci niente. Ne darò la spiegazione seguente: ciò che valorizza l'autografia è il sentimento che attraverso di essa il corpo, come individualità unica e insostituibile, vi si inscrive. Il manoscritto di Madame Bovary vale di più della sua edizione Garnier-Flammarion (benché sia molto più difficile da leggere) e oggi si preferisce sentire la mano di un pittore che trovarsi di fronte a un quadro troppo "leccato". E' la rivincita delle arti meccaniche.
Cos'è dunque l'autore di un film?
Inizialmente una condizione trascendentale che permette di distinguerlo dagli oggetti naturali: è lo stadio dell'autorializzazione. Poi un'istanza variabile a seconda che si riconduca il film alla sua sceneggiatura, come accade all'inizio del secolo, costruendo l'identità autoriale come un'autorità indiretta, che lo si ancori alla recitazione dell'attore, riducendo la trasformazione apportata dalla registrazione, o infine che si situi la sua origine in un corpo particolare, quello dell'operatore o del presunto-realizzatore che esercita uno sguardo particolare sul mondo. (42) Apparse in momenti diversi della storia del cinema, queste diverse figure, allografiche, autografiche - a cui corrispondono rispettivamente l'autore adattato, lo sceneggiatore e la sceneggiatura, l'attore e l'interpretazione scenica, il presunto-realizzatore e l'operatore -, sono anche tre modi, per lo spettatore attuale, di costruire l'autore.
Per il "produttore" considerare l'autore come istanza di un regime allografico significa pensare che la cinepresa non traduca uno sguardo, ma una veduta (gli operatori Lumière), oppure che la sceneggiatura sia a tal punto codificata, organizzata secondo un sistema di notazione che la avvicina alla partitura, da rendere l'esecutore cinematografico che opera la messa in immagini secondario: è il caso di Pathé o di Gaumont con i loro diversi registi; è il caso, soprattutto, del producer-unit-system, nel quale il "director" era condannato, salvo rare eccezioni, a seguire una sceneggiatura scritta da altri, e il film in certi casi veniva rifatto da un nuovo regista; nel quale la stessa sceneggiatura, al pari delle riprese, era oggetto di un vero e proprio sistema di notazione. Con esso si assiste alla standardizzazione non solo del formato dello script, con una strutturazione infinitamente reiterabile, ma anche dello stesso maquillage, notato grazie a una tabella che descrive le superfici della pelle e i prodotti da applicarvi, per meglio assicurare una continuità durante tutto il periodo delle riprese. Ugualmente, degli schemi estremamente precisi prescrivono come una vera partitura l'illuminazione, la posizione della macchina da presa e i movimenti del microfono. (43) In tal modo la sceneggiatura, assai più di quanto Goodman non creda, è concepita come uno spartito la cui esecuzione da parte di un regista non ne modifica la natura profonda.
Se, dunque, come ho avanzato in Un Monde à notre image, la ricezione del film come artefatto presuppone tre operazioni - l'autorializzazione, l'identificazione dell'autore, che passa in particolare attraverso l'attribuzione di un nome, e il riconoscimento di un'intenzione -, l'autore non è solo un nome e sostituirgli delle iniziali non è sufficiente ad annullare né la sua funzione né l'idea che ci si fa della sua autorità, più o meno indiretta. Conta soprattutto, nell'interpretazione del film, questa oscillazione fra l'attribuzione allografica e l'attribuzione autografica. Dire di un film che è della Warner Bros o della MGM significa collocarlo in una serie in cui nessun'opera si discosta dall'altra, in cui nessun film è imitabile o falsificabile, perché discendono tutti dalla ripetizione indefinita di un modello senza inizio né fine (come è testimoniato, ad esempio, dall'espressione "serie B"). Attribuirlo a Mervyn Le Roy o a Minnelli, come fa il cinefilo, significa estrarlo da questo sistema di notazione, concepito come una partitura e postulare che i due directors abbiano marcato con la loro identità corporea - sguardo, direzione degli attori, visione del mondo - la registrazione della denotazione genettiana.
Storicamente il processo di attribuzione del film a un autore è stato lungo e fluttuante. Questa esitazione, lo si sarà compreso, dipende in prima istanza dalla pluralità dei campi artistici da cui il cinema ha preso a prestito non solo il suo linguaggio composito, ma anche la condizione dei propri artigiani. Si può certamente troncare la discussione sull'autore cinematografico con l'affermazione perentoria di una gerarchizzazione tra coloro che concorrono alla fabbricazione del film. Per quanto mi riguarda, preferisco pensare che se l'autorialità passa di mano in mano, o di figura in figura, dipende dal fatto che l'opera cinematografica congiunge intimamente l'autografia e l'allografia, intese come convenzioni d'uso e non come realtà costitutive.
(Traduzione di Alberto Boschi)