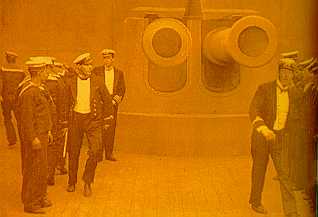
di Monica Dall'Asta e Guglielmo Pescatore
Nel 1895, quando gli spettatori del Grand Café vengono scossi dall'immagine di una locomotiva immateriale in movimento, la visione che li sorprende è in bianco e nero. Il cinema fa la sua apparizione come una visione di luci e ombre acromatiche in movimento, visione terribile per il fatto di derivare da un meccanismo di riproduzione. Il colore arriva solo in un secondo tempo, come un qualcosa di aggiunto rispetto alla sublime capacità di "fissare" il movimento nelle immagini. Come nota Tom Gunning nell'articolo che presentiamo in apertura di questo numero, (1) la storia delle tecnologie di riproduzione delle immagini sembra essere marcata da una sorta di "resistenza" nei confronti del colore: la litografia, la fotografia, il cinema e infine la televisione nascono tutti in bianco e nero e arrivano al colore solo in un secondo tempo. A prescindere dai motivi tecnici che la determinano, la resistenza al colore da parte dei mezzi di riproduzione è un dato oggettivo, storicamente immanente all'esperienza del pubblico. La questione potrebbe essere posta in questi termini: nel momento della sua novità più elettrizzante, quando appare come l'ultimo "ritrovato" in cui il moderno si è per il momento cristallizzato, ogni nuova tecnologia della visione è come costretta al bianco e nero. Lo shock del nuovo, di ogni nuova forma della riproducibilità, è, ogni volta che si produce, uno shock in bianco e nero. Ciò conduce inevitabilmente a chiedersi in che rapporto venga a trovarsi il colore, quando viene finalmente conquistato dalle diverse tecnologie (ma ciò che ci interessa è, qui, ovviamente il cinema) con il moderno e il suo immaginario.
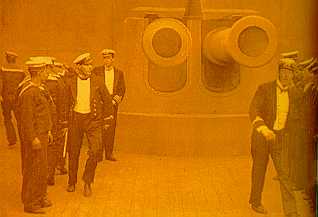 |
Gli articoli di questo numero offrono diversi spunti per riflettere su questa questione. Da parte americana, sulla scorta della grande attenzione che negli Stati Uniti viene rivolta da tempo allo studio della società dei consumi e al ruolo che in essa spetta al cinema, (2) ci giunge l'invito a considerare gli inizi del colore nel cinema muto nell'ambito della storia della "estetica commerciale", ovvero della pubblicità, del marketing o più in generale della cultura come produzione (la stampa e l'editoria di massa, ad esempio). |
Secondo Richard Abel, (3) l'esigenza di colore che si manifesta molto presto nel cinema rispecchia e in qualche modo contemporaneamente rafforza una tendenza socio-culturale più generale, rappresentata da una crescita evidente della domanda e dell'offerta di colore nelle immagini delle merci e nel mercato delle immagini. Dalle vetrine ai manifesti pubblicitari, dalle riproduzioni d'arte ai prodotti editoriali, all'inizio del secolo le merci cominciano a rivestirsi dei colori più sgargianti per adescare gli sguardi. In verità, questo processo di colorizzazione delle merci ha inizio diverso tempo prima della nascita del cinema, in quella fase "preistorica" della modernità indagata da Benjamin nel suo studio sui passages parigini. Nei passages, infatti,
sono possibili i colori più artificiali; pettini rossi o verdi non fanno meraviglia a nessuno. La matrigna di Biancaneve ne aveva uno simile, e quando esso non sortì il suo effetto, le venne in aiuto la bella mela, mezza rossa e mezza verde come i pettini a buon mercato. (4)
Questa offerta di colore nelle immagini delle merci è un elemento determinante nel processo di costituzione del mercato come "terra fatata", così come si presenta allo sguardo, ad esempio, nelle esposizioni universali di metà Ottocento. Il palazzo delle esposizioni del 1867 appare a Théophile Gautier come "un monument élevé jeans un autre planète, Jupiter ou Saturne, d'après un gout que nous ne connaissons pas et des colorations auxquelles nos yeux ne sont pas habitués". Infatti, "le grand gouffre azuré avec sa bordure couleur de sang produit un effet vertigineux et désoriente les idées qu'on avait sur l'architecture". (5) Dal corpo delle merci si sprigiona inoltre una quantità di immagini autonome, i manifesti pubblicitari, che tappezzano dei loro colori i muri delle città. "Molti palazzi sembrano oggi decorati col costume di Arlecchino; è tutta un'assemblea di grossi pezzi di carta verdi, gialli [...] e rosa". (6) Anche i passages sono costellati di affiches:
Vidi un foglio che a prima vista pareva rappresentare qualcosa come il bagno di Sigfrido nel sangue del drago: verde solitudine boschiva, mantello purpureo dell'eroe, carne nuda, uno specchio d'acqua - era la carezza complicatissima di tre corpi, degna dell'immagine di copertina di una rivista di poco prezzo. Tale è la lingua cromatica dei manifesti fioriti nei passages. Se venissimo a sapere che al loro interno sono apparsi i ritratti di famose ballerine di cancan come Rigolette e Frichette, dovremmo immaginarceli colorati così. (7)
A questa lingua cromatica delle merci non è estraneo, naturalmente, il mercato delle immagini. Nei passages si aprono qui e là ingressi oscuri che conducono di fronte, o perfino in mezzo, a sorprendenti paesaggi artificiali, panorami o diorami dai colori sgargianti. Arrivare in uno di questi paesaggi "era come entrare in un'acquario, Si allungava sulla parete della grande sala scura, interrotto da esili giunture, come una pellicola dietro il vetro dell'acqua illuminata. Il gioco dei colori della fauna degli abissi non può essere più ardente". (8) Questa apparenza di acquario, mondo artificiale percorso di strane iridescenze, pervade interamente la descrizione che Benjamin ci ha consegnato della preistoria della modernità. È l'immagine più emblematica di quello che è per Benjamin il sogno dell'Ottocento, il torpore di un secolo che si culla nella fantasmagoria del progresso, nell'illusione di un futuro da fiaba. Questo sogno dominato da colori a cui, come nota Gautier, l'occhio dei contemporanei non è ancora abituato è il trionfo di un'estetica del "carino" che Abel ci invita a riconoscere pienamente come una "estetica commerciale" dai caratteri infantili - e femminili, certo, nella misura in cui il femminile è ideologicamente costretto nello spazio delle bambole, dei giocattoli e dei belletti. Per questa estetica commerciale del "carino" il colore diventa una sorta di narcotico, una sorta di comfort percettivo (9) addizionale elargito all'immagine, "rivestimento" o fodera cromatica di una visione in cui sprofondare come negli interieurs traboccanti di tappezzeria e di peluche, così come gli oggetti sprofondano in una miriade di astucci, custodie, involucri colorati concepiti per non essere altro che confortevoli protezioni. (10)
| Di tutto questo certo partecipano gli inizi del colore nel cinema. I film colorati di Méliès o della Pathé, che sono molto spesso féeries, piccole messe in scena di favole per bambini promosse a divertimento per adulti, (11) hanno un aspetto di giocattolo, città-giocattolo per bambole e modellini finalmente in movimento. I film di Méliès tendono quasi sempre a presentarsi come miniature di mondi, microcosmi autosufficienti, fantastici mondi astrali, infernali o sottomarini. (12) |  |
In un film come La Syrène (1904), ad esempio, l'acquario metaforico di Benjamin si materializza in una visione dai colori impossibili: è il modellino ingigantito di un mondo ovattato dalle profondità subacquee, popolato di enormi meduse e stelle marine, un gigantesco acquario fosforescente che rischiara l'oscurità della sala. Applicare a questo film la metafora benjaminiana dell'acquario-vetrina (13) significa aprire una nuova prospettiva allo studio del colore nel cinema delle origini. Perché è soprattutto il colore ciò che fa apparire questo film come un'inconsapevole rappresentazione del mondo della merce, mondo parallelo e autosufficiente, artificial environment in cui la merce nidifica come la fauna di un confortevole mondo subacqueo che osserva i passanti da dietro una lastra di vetro, emanando i suoi colori innaturali nella luce artificiale dei passages. Non sarà inutile ricordare, infatti, che da sempre nella storia dell'umanità il colore è associato al lusso e alla ricchezza: in certe fasi storiche alcune sostanze coloranti si videro perfino assegnare il ruolo di moneta. (14) L'esplosione di colore che si verifica nel diciannovesimo secolo (e di cui il pochoir è l'espressione cinematografica) è perciò intimamente legata alla crescita di quel senso di disponibilità della ricchezza, lusso inesauribile e sempre a portata di mano, che caratterizza la società dei consumi. Ed è proprio questo carattere "consumistico", infantile e consolatorio del colore ottocentesco ciò che Epstein sembra voler evocare a proposito del pochoir, quando scrive che di fronte a un Pathécolor non può impedirsi di cercare, nell'angolo dell'inquadratura, la scritta "Buone feste" in lettere dorate. (15)
Se dunque la fantasmagoria dei film colorati a pochoir rimanda alla fantasmagoria delle merci attraverso questo insistito carattere di giocattolo, questo gusto del colore tutto infantile, nel cinema delle origini la natura di merce del colore appare però anche sotto un secondo aspetto, certamente più diretto. Qualità aggiuntiva rispetto alla capacità riproduttiva che fonda la visione cinematografica, il colore si costituisce immediatamente, come nota Gunning, come "valore aggiunto" della merce-film. I film colorati, insomma, costano di più, giungono sul mercato come "specialità", così giustificando il loro sovrapprezzo. Essi contribuiscono a diversificare e a rendere più complesso il mercato del film, iniettandovi il fattore dinamico della varietà.
I film colorati e virati sono sempre un piacevole sollievo rispetto alla cosa ordinaria, che in questo caso è il bianco e nero. [...] [Questi film] piacciono agli uomini, e le donne e i bambini (ai quali il cinema piace molto, come ci dicono) li amano in modo speciale. Per parlare in termini commerciali invece che estetici, ovvero in termini di dollari e centesimi, [...] è certo che qualunque produzione colorata di qualità sarà assolutamente benvenuta dagli esercenti, il che ovviamente significa ottime vendite. (16)
Il colore come portatore di varietà nel mercato del film richiama inevitabilmente la questione della novità. "La novità è tanto essenziale a livello della fotografia [leggi: della visione] quanto a livello delle trame". Perché infatti, "troppa uniformità tende a spegnere l'interesse del pubblico per il cinema". (17) Ma che tipo di novità è quella che il colore come allettante rivestimento conferisce all'immagine cinematografica? È la novità della vecchia modernità ottocentesca, quella che la prima volta incontra le merci come fantasmagoria nelle grandi esposizioni, quella che ancora si stupisce delle affiches multicolori e dei mondi in miniatura dei panorami. O, detto diversamente, è il nuovo come semprenuovo, il nuovo come semplice "effetto" ricorrente prodotto dal mercato.
Poi, arriva il treno dei Lumière. Rispetto a questo mondo-acquario tutto imbellettato di tinte artificiali che tentano però di comunicare un effetto auratico di "antichità", lo shock percettivo di questa visione in bianco e nero è paragona- bile a quello provocato dall'architettura in vetro e ferro, vera e propria architettura della luce fondata su un'estetica della trasparenza che si annuncia nel diciannovesimo secolo per trionfare nel ventesimo. Piuttosto che alle vetrine-acquario dei passages, il treno dei Lumière rimanda alle architetture di questi edifici, al gioco che intrecciano con la luce, con "lo spazio aereo libero, per così dire uranico, che getta una nuova luce sugli eccessi della tappezzeria negli interni di allora". (18) Così come, "con i suoi tessuti, la tappezzeria oppone resistenza all'armatura in vetro e ferro", (19) creando un guscio in cui restare "ermeticamente avviluppati" come "in una tela di ragno", (20) allo stesso modo le prime colorazioni a mano o a pochoir (quelle ad esempio che decorano gli interni soffocanti dei films d'art della Pathé) non fanno che attutire il puro shock della luce in movimento, rimanendo nostalgicamente legati al sognante torpore dell'Ottocento. Ma "il XX secolo con la sua porosità, la sua trasparenza e la sua inclinazione alla luce e all'aria aperta la fa finita con l'abitare nel vecchio senso della parola", (21) così come rompe con i panorami, i diorami e tutti gli altri giocattoli della visione.
 |
Piuttosto che di una conquista del colore si dovrebbe perciò parlare per il cinema delle origini di una conquista del bianco e nero. Non a caso il momento in cui il cinema si scrolla di dosso questo colore ottocentesco è quello in cui comincia a imporsi il cinema americano, il cinema del paese in cui il processo di modernizzazione è più avanzato. Mentre nei primi anni del secolo il colore aveva funzionato come motivo promozionale, adesso, intorno al 1910, i nuovi produttori americani cominciano piuttosto a pubblicizzare il fatto che "nei loro film i colori apparivano come sfumature del bianco e nero". (22) |
Dalla preistoria della modernità, o dalla modernità come puro prodotto del mercato, si va progressivamente sviluppando una sensibilità modernista, una coscienza della modernità che qui in America non è ancora, e non sarà mai, avanguardista, ma che è già abbastanza chiaramente un modernismo industriale. Per questa sensibilità, il bianco e nero è il colore del cinema. Sebbene le usi in un'intervista che ha lo scopo di promuovere il nuovo processo di colorazione denominato Handschiegl, (23) che avrà peraltro vita breve, queste parole di DeMille sembrano deporre invece in favore di un puro bianco e nero:
Siamo giunti alla conclusione che la fotografia colorata, nel senso di una riproduzione assolutamente fedele dei colori della natura (24) o di qualunque metodo di colorazione provvisto di una varietà di tinte sgargianti, non possa essere universalmente adottata nel cinema, perché per l'occhio dello spettatore ne deriverebbe uno stress troppo forte e la varietà dei colori distrarrebbe l'attenzione dalla narrazione. (25)
Il cinema nel suo stato percettivo più essenziale, lo stato che ne esalta le facoltà espressive senza introdurre elementi di disturbo, è il cinema in bianco e nero. Emersa nel mercato americano verso il 1910, questa estetica del bianco e nero ritorna sotto forma di poetica in alcune zone dell'avanguardia (in proposito, si veda fra l'altro l'articolo di Chiel Kattenbelt) (26), e in particolare in alcuni film dell'espressionismo. Certo, la documentazione attualmente disponibile non consente ancora di formulare un discorso definitivo o anche solo parzialmente attendibile sul rapporto complessivo del cinema espressionista con il colore e il bianco e nero. E in realtà, riportando alla luce con sempre maggiore frequenza copie imbibite o virate di classici come II gabinetto del dottor Caligari, Il Golem o Nosferatu, la pratica filologica degli ultimi anni ha provocato un piccolo terremoto in questo campo, mettendo radicalmente in discussione il punto di vista tradizionale che vedeva nell'espressionismo il cinema del bianco e nero per antonomasia. L'articolo di Inge Degenhardt (27) ci mostra invece come nell'espressionismo tedesco la scelta del bianco e nero conviva con la pratica più consueta della colorazione tramite viraggio e imbibizione in un rapporto di scambio dialettico e di confronto. Di particolare interesse risulta in questo senso l'analisi di due film che presentano una opposta attitudine nei confronti del colore. Da un lato II gabinetto del dottor Caligari non solo fa uso del viraggio secondo un preciso programma d'autore, ma piega il colore profilmico a una complessa strategia fotografica che resterà esemplare anche per le pratiche successive di ripresa in bianco e nero. I set vengono colorati al fine di ottenere, nella copia in bianco e nero, una complessa gradazione di grigi, che il viraggio ha poi il compito di trascolorare in un'ampia gamma di sfumature monocrome. (28) L'obiettivo è quello di produrre, attraverso le sfumature monocrome, un effetto di rilievo e profondità che superi i limiti intrinseci dell'immagine filmica. Dall'altro lato Dall'alba a mezzanotte, pubblicizzato come "il primo film in bianco e nero", assume l'assenza di colore come il "grado zero" del cinema che qualunque "rivestimento" cromatico non farebbe che inquinare dall'esterno. In altri termini, la scelta del bianco e nero risponde alla precisa determinazione di "strappare" l'essenza del cinema alle fodere cromatiche sovrapposte all'immagine come residuo di una cultura pre-cinematografica. Dato il legame che sussiste fra colore e rilievo, il cinema nel suo stato più essenziale dovrà dunque esaltare la qualità bidimensionale dell'immagine in un bianco e nero fortemente contrastato {i contrasti accesi costituiscono d'altra parte una propensione naturale per la pellicola ortocromatica). Alcuni anni più tardi, con II dottor Mabuse, anche Lang si sarebbe schierato in favore di un puro bianco e nero, respingendo la tendenza "coloristica" dell'espressionismo fantastico. Questa estetica in cui il bianco e nero si presenta come la forma "pura" dell'immagine cinematografica appare così come una strategia simmetrica e contraria a quella del cinema astratto analizzato da Guy Fihman, (29) dove l'esigenza di rompere con il colore-rivestimento passa piuttosto attraverso il tentativo di inventare un colore in movimento, o un movimento colorato improntato all'esempio della musica.
L'estetica del bianco e nero sviluppata, pur se in modo discontinuo, dall'espressionismo tedesco ha com'è noto una discendenza diretta nel film noir americano. Ma al di là di questa eredità, l'insistenza del monocromo nel film noir è storicamente così marcata da richiedere una riflessione specifica. Come osserva Leonardo Gandini nel suo articolo, (30) il noir è il genere che più a lungo resiste all'introduzione del Technicolor, come se la sua stessa esistenza dipendesse dalla possibilità del bianco e nero. Questa "necessità" del bianco e nero è legata senza dubbio alle ambientazioni metropolitane di tale genere, all'esigenza cioè di rendere "il grigio dominante della città moderna" e il senso di anonimato a cui è associato. Secondo Manlio Brusatin,
il corpo della città moderna assume tonalità entro la gamma del grigio, non soltanto per il processo di offuscamento e di imbrattamento dei materiali oggi accelerato dalle polveri e dagli inquinamenti dell'industria e del traffico, ma anche per la diffusione di materiali costruttivi, senza un vero colore, come l'asfalto e il cemento [...]. L'assenza del colore dagli edifici delle metropoli diurne è perfettamente riproducibile con il bianco e nero fotografico e contrasta con il suo effetto notturno, costruito con la policromia delle insegne pulsanti e degli arredi effimeri. (31)
Ma nella "giungla d'asfalto", il turbinio policromo delle insegne e dei manifesti pubblicitari ha un effetto diametralmente opposto a quello prodotto nella città ottocentesca dalla variopinta "estetica commerciale" della merce, Questi "colori atoni (rosso, giallo, blu) che sono chiamati fondamentali ma che nessun pittore userebbe", queste tinte aggressive che sostituiscono nei manifesti e nelle insegne le sfumature più delicate del gusto ottocentesco, finiscono per risolversi in un grigio generalizzato, "scompaiono nel momento stesso in cui si allineano come sollecitazioni visive di segnali o insegne tanto inespressivi quanto equivalenti". (32) Questo grigio generalizzato non è tuttavia "del tutto inerte" se è vero che l'occhio "dell'uomo urbano [...] del XX secolo" è in grado di distinguerne "più di cento tonalità". (33) Il bianco e nero del cinema hollywoodiano classico, che trova nel noir il suo terreno d'elezione, esprime allora proprio la modernità come grigio infinitamente sensibile, capace di assumere le più varie qualità di trasparenza, opacità e lucentezza. Nel noir, insomma, il bianco e nero pare esprimere una sorta di involontaria coscienza della modernità. Ciò che i suoi complessi chiaroscuri mettono in primo piano non è più, come nei primi film a pochoir, la modernità come fantasmagoria della merce ma come mondo di cose alienate, un mondo anonimo abitato da cose e da persone estranee. Il lusso e la ricchezza non sfoggiano più i colori dei giocattoli, ma rilucono in bagliori accecanti nella sfaccettatura di un gioiello, negli specchi e nelle cromature dei bar notturni o nei capelli biondo-platino di bellissime sconosciute. Espulso da questo universo in grigio, il colore si trasfigura nel gioco dei luccichii improvvisi che esprime ormai, nel noir come nel musical e nella commedia sofisticata, l'intenso potere erotico delle cose e delle persone estraniate. Il gusto per le superfici luccicanti e riflettenti, che appare davvero quasi come sostituto del colore, trionfa ad esempio nelle strane magie in grigio dell'effetto-notte, dove gli smalti delle automobili riflettono, di notte, i raggi di un sole inesistente. (34)
| Rispetto alla lucida e inquietante visione della "modernità in grigio" che il noir ci ha consegnato, i colori pastello dei primi film a pochoir rivelano tutto intero il loro carattere di leziosa decorazione. Si comprende allora perché, nonostante l'ampiezza della "cromo-civiltà" ottocentesca, sia così raro, come spiega l'articolo di Hannu Salmi, (35) che una raffigurazione storica ambientata nel tardo Ottocento e fino a tutta la prima metà del Novecento possa essere a colori. |  |
Un discorso a parte va fatto invece per i processi di viraggio e imbibizione (o tintura). Assolutamente dominanti negli anni Dieci e Venti rispetto al bianco e nero puro, queste tecniche di colorazione si prestano a effetti di senso che vanno ben al di là di una mera pratica decorativa. Qui non si tratta di abbellire l'immagine, ma di dotarla di significati che altrimenti di per sé non avrebbe. La questione del colore (imbibizione) come "aiuto alla creazione di un'atmosfera drammatica" viene affrontata, ad esempio, in un articolo del 1929, che, per quanto tardo, può offrire alcuni importanti spunti di riflessione. (36) Il testo contiene una piccola guida, analoga ad altre pubblicate nel periodo del muto, a quelle che con un'espressione moderna potremmo definire le informazioni diegetiche veicolate dal colore. Queste informazioni muovono spesso da un processo sinestesico, come nel caso dei colori associati alle diverse temperature. Ma il significato dei colori non è stabile e dipende dal contesto in cui appaiono. La tinta denominata Purplehaze ("un blu-violetto o lavanda, leggermente pastello") può produrre, od esempio, "un pronunciato effetto di freddo" quando sia usata per "una scena contenente distese di neve, ghiacciai, montagne con le vette innevate". Usata per "una scena di tramonto sul deserto", la stessa tinta tende invece a suggerire "un sentimento di distanza, di mistero, riposo e languido calore". (37) Allo stesso modo, sempre per via sinestesica, se associata a un paesaggio marino, la tinta Aquagreen "suggerisce un'idea di bagnato". (38) Particolarmente importanti sembrano poi essere le informazioni di natura temporale che i colori sono in grado di veicolare. Come suggeriscono i loro stessi nomi, la tinta Nocturne si presta a creare un effetto-notte in esterni, mentre, se usata per un interno, Candleflame "suggerisce decisamente l'effetto dell'illuminazione artificiale". (39)
Inoltre, pur nella sua ingenuità, questo piccolo articolo ci offre lo spunto per riflettere su una questione tuttora irrisolta relativa al funzionamento semiotico del colore. L'autore fornisce infatti una classificazione delle tinte in base alle loro qualità eccitanti o al contrario tranquillizzanti. Aquagreen, ad esempio, è "tranquillizzante ma non avvilente", Sunshine è "dolcemente stimolante", mentre Azure è "tranquillizzante al punto da diventare deprimente". (40) Ci troviamo qui nel campo del colore come sensazione pura, immediata, elementare; sensazione per così dire "neutra", priva di ogni altro contenuto che non sia il suo puro aspetto di stimolo. Prima ancora di essere investiti di un contenuto passionale (la rabbia, la gelosia, la tristezza), i colori si presentano come gli agenti di un timismo puro, operando quasi come ciò che governa la distribuzione di energia, somministrandola al soggetto in quantità precise. (41) Se questo è vero, l'analisi delle colorazioni a viraggio o imbibizione potrebbe aprire alla teoria del cinema un campo di indagine assolutamente nuovo: quello relativo all'economia timica del film, ai modi di produzione e di funzionamento delle sue "curve passionali". Tale indagine potrebbe avere, inoltre, importanti conseguenze soprattutto in relazione alla dimensione del montaggio. L'articolo di William Uricchio (42) rappresenta un primo contributo in questa direzione, le cui potenzialità ci sembrano tuttavia assai più ricche di quanto non appaia allo stadio attuale delle ricerche. Perché è evidente che, intrecciandosi con il montaggio, questa economia timica potrebbe arrivare a configurarsi come una economia dello shock. Seguendo lo schema di Jones, ad esempio, le inquadrature azzurre e rosse che si alternano nella sequenza del salvataggio di The Lonedale Operator avrebbero rispettivamente un carattere relativamente "deprimente" e fortemente "eccitante". Il montaggio alternato fra la situazione opprimente della stazione dove la telegrafista si trova minacciata dai banditi (in azzurro) e la corsa disperata del ferroviere che si sta precipitando a salvarla con il suo treno (in rosso) è anche un montaggio di stati timici fra loro incongrui, una successione di scosse decisamente destabilizzante. I colori che si susseguono o si alternano nel corso del film creano un montaggio parallelo che si intreccia con il montaggio vero e proprio delle inquadrature. La giustapposizione dei colori lungo l'asse lineare del film, inoltre, produce contrasti nei quali i colori agiscono l'uno sull'altro. Per citare un'ultima volta l'articolo di Jones, accade così che
l'occhio ormai abituato, o affaticato da un verde, come Verdante, percepirà all'inizio della scena successiva, tinta in rosa, un colore di incantata saturazione soggettiva. Questo fissa immediatamente il tono emotivo della scena, dopodiché cominciano ad operare i processi di adeguamento della retina, causando un'apprezzabile diminuzione della saturazione effettiva. Avendo così compiuto la sua missione, il colore [...] scivola nello sfondo [...] [e] permette all'azione di proseguire il suo percorso drammatico senza l'influenza distraente di un colore pronunciato. (43)
Si potrebbe provare a esprimere in termini semiotici e testuali ciò che Jones si accontenta di spiegare come fenomeno fisiologico. Si direbbe, allora, che il contrasto fra colori si presenta come una sorta di shock prolungato, che non si consuma nel momento puntuale del passaggio a una nuova tinta ma resiste, attenuandosi via via che ci si allontana dal punto di contrasto. Ne deriva che se associato a un cambiamento di inquadratura, il cambiamento di colore tende da un lato a rafforzare (per mezzo del contrasto cromatico), dall'altro a prolungare (per mezzo del carattere durativo del contrasto) l'effetto puntuale di shock prodotto dal taglio di montaggio. Considerata come elemento di montaggio, la colorazione monocroma è dunque (almeno potenzialmente) lontana dal rappresentare una fonte di comfort percettivo, come talvolta si tende ancora a concepire il colore anche in epoca posteriore alla pratica del pochoir. (44) Qui il colore appare piuttosto come un elemento destabilizzante, qualcosa che si oppone per sua natura all"'invisibilità" del montaggio.
Tuttavia, pur innestando il colore nella dimensione temporale e tensiva del film, i processi di imbibizione e viraggio producono un colore "statico", che non può legarsi alle figure e muoversi con loro. Ciò ci porta a considerare una delle difficoltà, delle aporie, che sembra comportare l'indagine sul colore nel cinema: l'opposizione colore/movimento. Si è appena detto come il colore, nella pratica del viraggio e dell'imbibizione, possa avere un valore "ritmico", se a questo termine conferiamo il suo senso più ampio: organizzazione per alternanza e opposizione di effetti sensibili, prima ancora che di effetti di senso. Il colore shock, dunque, finalmente congruo alla nuova organizzazione della visione veicolata dal cinema, contro il colore peluche degli stampini ottocenteschi. Consolante vittoria della modernità del cinema, che si scrolla di dosso il gravame confortante della "carineria" per mostrare il suo vero volto di medusa, terribile e sublime, come già lo era stato il magnificato treno Lumière. Purtroppo, anche la fiducia nel progresso e nell'avvenire della storia può essere interrogata. Tre questioni ci sembrano di particolare imbarazzo: a) quali ragioni, estetiche o mercantili che siano, determinano un cambiamento di tale portata? b) quali prove, empiriche o testuali, è possibile produrre a dimostrazione dell'effetto ritmico/timico attribuibile alle colorazioni? c) che rapporto intrattiene questo "movimento dei colori" - sia nella versione sintagmatica, per blocchi, del cinema colorato, sia nella successiva versione "disseminata" propria del colore riprodotto - con il movimento delle figure, sia esso inteso in senso fisico, narrativo o ritmico?
Il lettore che cerchi una risposta complessiva a questi problemi rimarrà probabilmente deluso: nell'affrontare lo studio del colore cinematografico troppo scarso è sia il lavoro empirico sui testi che l'apparato teorico perché si possano fornire, seppure fossero possibili, soluzioni complessive, soprattutto riguardo a una questione cruciale, e al tempo stesso sfuggente, come quella del rapporto colore/movimento. In questo primo numero di Fotogenia si troverà però, negli articoli di Fihman (45) e Roque, (46) un primo tentativo di delimitare il campo. Apparentemente periferici rispetto al filone principale d'indagine, i due testi in questione offrono - uno seguendo l'ascendenza musicale, l'altro quella pittorica - un contributo prezioso nello stabilire i contorni di quell'area incerta che si determina dalla sovrapposizione di colore e movimento e che vede nel cinema uno dei suoi momenti catalizzanti.
Da parte nostra non vorremmo esimerci dal fornire delle indicazioni, anche frammentarie, sulle domande che ci siamo appena posti. Per quanto riguarda le ragioni del passaggio dal colore come comfort percettivo al colore mobile, possiamo ritenere che esso sia dovuto in parte a ragioni esterne al cinema e che rimandano ai mutamenti di quell'estetica commerciale a cui si è già fatto riferimento, in parte a ragioni tecnico-economiche specifiche della produzione cinematografica, in parte, cosa più interessante, al fatto che l'estetica del colore dipinto contrastava necessariamente con il nuovo assetto della visione e della produzione di immagini che il cinema realizzava. Un'ipotesi di questo genere metterebbe in questione la dicotomia corrente tra cinema primitivo e cinema istituzionale e porrebbe l'accento sulla novità immediata del cinema, sia pure ammantata di sopravvivenze ottocentesche, tra le quali il colore sarebbe la più ingombrante. Ipotesi che andrebbe provata e che qui ci limitiamo invece ad avanzare a puro titolo speculativo. Certo che se così fosse, apparirebbe ben evidente quanto lo studio del colore possa modificare categorie acquisite della storiografia cinematografica.
Quanto al modo in cui venivano percepiti i film virati o imbibiti e, più in generale, al modo in cui viene recepito il colore, non ci sembra che al momento siano disponibili dati sufficienti, anche se la relativa mancanza di discorsi sul colore potrebbe essere di per se stessa indicativa. A questo proposito vorremmo segnalare come Moussinac, nel suo Naissance du cinéma del 1925 inserisca un breve paragrafo (47) in cui immagina le possibilità che si apriranno al cineasta con l'avvento del cinema a colori. Descrive, tra l'altro, la possibilità di realizzare particolari effetti emotivi attraverso la successione di due scene che abbiano una dominante cromatica diversa: curiosamente non si rende conto che ciò è esattamente quanto realizzava il cinema a lui contemporaneo attraverso i procedimenti di colorazione. Questa testimonianza, anche autorevole, sembrerebbe accreditare l'ipotesi che il colore dei film colorati non fosse affatto percepito come tale e che quindi fosse parte più dell'aspetto comunicativo, fatico, del cinema che di quello espressivo. Ovviamente, questo non implica necessariamente che le colorazioni non avessero un effetto espressivo, ma la dicotomia tra percezione ed effetto sembra introdurre un'altra aporia che forse attraversa tutta la storia del colore al cinema.
Sulla terza questione che abbiamo posto, quella del rapporto tra il movimento del colore e il movimento della rappresentazione, si troverà più di un'utile indicazione nell'articolo di Aumont, (48) il quale, affrontando il tema del colore della carne, analizza le soluzioni originali che il cinema è riuscito ad offrire ad un problema pittorico classico, quello del rapporto tra disegno e coloritura. Una contrapposizione che Simmel, ad esempio, formulava come segue:
Se nella forma si presenta in certo qual modo l'idea astratta del fenomeno, il colore si pone sia al di qua che al di là di essa: è più sensibile e più metafisico, il suo effetto è da un lato più immediato, dall'altro più profondo e più misterioso. Se la forma si può definire approssimativamente come la logica del fenomeno, il colore equivale invece al suo carattere psicologico e metafisico, e anche qui si manifesta la contrapposizione di entrambe queste intenzioni, del tutto distinte tra loro, al principio logico. (49)
Dunque il colore si pone al di qua o al di là della forma, e si potrebbe anche dire, parlando del cinema, della rappresentazione. Al di sotto di essa si troverà quell'aspetto sensibile, timico, di cui si è detto; al di sopra, ci piace pensare ad un aspetto simbolico più che metafisico, aspetto che al cinema prende anche la forma di un'iconografia. In questa direzione va l'analisi proposta da Fievet (50) di Vertigo, utile soprattutto a delineare i procedimenti e le valenze simboliche dell'Hitchcock colorista.
Curiosamente, ma poi non tanto, gli scritti sul colore di Ejzenstejn, analizzati da Mayer, (51) che ne ricostruisce e ne riafferma l'unità teorica, sembrano prospettare un'idea del colore non dissimile da quella di Simmel. Il colore organizza nel testo, secondo Ejzenstejn, una serie di corrispondenze e legami fondati sulla sinestesia. Ma, e qui risiede l'originalità dell'interpretazione di Mayer, perché ciò accada è necessario che il senso del colore trovi fondamento anche in una corrispondenza assoluta che si situa fuori dall'organizzazione testuale. Come si vede, basta variare solo leggermente i termini, psicologico al posto di sinestesico e metafisico al posto di assoluto, per ritrovarci esattamente alla formulazione di Simmel.
Una nuova aporia - o un dualismo, se si preferisce - del colore, e non necessariamente l'ultima, con cui confrontare i risultati, provvisori, di un'indagine che è solo all'inizio. Ma forse, per parafrasare Simmel ancora una volta, interrogarsi sul colore vuoi dire necessariamente porsi al di qua o al di là di esso.