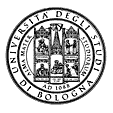-
- GENERAZIONE SCENARIO 2000
- LA PAROLA AGLI ARTISTI
- di Daniela Turco Liveri
-
- Quattro sono stati i vincitori, che dopo aver superato le
precedenti tappe del premio, che consistevano
nell'elaborazione cartacea del progetto teatrale e la
successiva presentazione di venti minuti dello stesso,
hanno la possibilità di debuttare con il loro lavoro al
teatro San Martino di Bologna.
- Scenario è un canale per cui un artista, assumendosi un
certo margine di rischio per trasmettere il non
preventivato e il non definitivo, può presentarsi. Una
sorta di trampolino di lancio, da cui può spiccare il
volo solo chi è spinto da una forte vena artistica e si
sente capace di affrontare la realtà.
- I registi dei diversi lavori selezionati, di cui uno solo
è il vincitore del Premio Scenario 2000, mentre agli
altri tre è stato assegnato un premio speciale, sono
stati attivamente presenti alla conferenza, durante la
quale sono intervenuti parlando della loro esperienza e
in particolare dei loro spettacoli.
 Ha
iniziato Giorgio Simbola, ricordando con un po’ di
nostalgia la sua terra natale, la Sardegna, e i racconti
della nonna quando era bambino. Simbola è interessato al
tema dell'emigrazione e lo dimostra concretamente
attraverso l'esperienza della compagnia del Lazzaretto
Occupato, un’esperienza che egli condivide con altri
componenti di sei famiglie emigrate per di più
dall'Albania, con le quali convive in uno stabile
occupato.
Ha
iniziato Giorgio Simbola, ricordando con un po’ di
nostalgia la sua terra natale, la Sardegna, e i racconti
della nonna quando era bambino. Simbola è interessato al
tema dell'emigrazione e lo dimostra concretamente
attraverso l'esperienza della compagnia del Lazzaretto
Occupato, un’esperienza che egli condivide con altri
componenti di sei famiglie emigrate per di più
dall'Albania, con le quali convive in uno stabile
occupato.- Simbola spiega come sia difficile la condizione di vita
di chi tutti i giorni pulisce i vetri ai semafori, o
chiede denaro all'angolo della strada. Sono proprio loro
gli pseudo attori che interpretano "Com'è fatta la
terra di mio padre?" C’è imbarazzo nella
compagnia, che non solo non è mai salita su un palco, ma
che addirittura non è mai entrata in un teatro.
- Gerardo Lamattina, regista della compagnia Bassini-Bruni,
già nervoso per problemi tecnici, parla del suo odio,
anzi della sua noia per il teatro e soprattutto per la
danza, a tal punto che, quasi scommettendo con se stesso,
ha preso la regia di un progetto prevalentemente
coreografico, stravolgendolo, da filmaker purosangue.
"Tangaz": il risultato! Un po’ ballo,
un po’ poesia, un po’ attori, un po’
ballerini.
- "Inconsciamente non sappiamo perché si fa teatro,
inconsciamente diamo senso al nostro modo di lavorare,
nessun motivo, nessun senso, è come stare su un
filo" questo afferma Sergio Longobardi della
Compagnia Babbaluck. Il suo intervento tende a
sottolineare insistentemente il modo "non
conscio" di lavorare e i segreti motivi che ne
stanno alla base. "Core", altro non è che
un'esperienza di vita, ma non necessaria né per chi la
guarda né per chi la fa.
- Come per cavalleria interviene per ultimo il vincitore
del premio. Patrizio Dall'Argine spiega la lunga e
travagliata storia che ha portato alla creazione di
"Contraerea", un lavoro che nella sua
evoluzione ha portato lo stesso regista a una maturazione
artistica, seppur non definitiva.
- "Contraerea" è un monologo che egli
intraprende con il suo alter ego, a parer suo, un po'
scemo. Nel monologo egli pone due punti su cui
arrovellarsi, "un qui", rappresentato da lui
stesso e "un là" che corrisponde alla guerra
nei Balcani. "Lo spettacolo è finito" sostiene
l’autore "ma la prima sarà una sorpresa anche
per me!"
-
-
- QUANDO LA VITA PICCHIA DURO SIMBOLA CE
LA RACCONTA A TEATRO
- Conversazione con Giorgio Simbola
- di Cristina Vercellone
-
- Parlo con uno degli attori albanesi di Giorgio Simbola.
"E' da quindici anni che sono in Italia", cerca
di spiegare in una lingua che non è la sua. Ziwko sta
fumando una sigaretta e sorride. "Sto tutti i giorni
ai semafori". In Serbia ha lavorato in fabbrica
dieci anni. Era anche impegnato a livello sindacale:
lottava per la strenua difesa di quei pochi diritti che
là gli operai riuscivano ad ottenere. Adesso tutti
rimpiangono Tito e le attività lavorative sono sospese.
- Ziwko Milovanovic è venuto qui, ma in Serbia sono
rimasti i suoi due figli. Ogni volta che telefona per
parlare con loro sono venti mila lire, l'incasso di una
giornata al semaforo. Lo chiamano l'uomo dei cento
scatti. Non può stare all'apparecchio un minuto in più.
- E’ questo il mondo che Simbola riesce a far
diventare teatro senza perciò travestirlo o truccarlo.
Anzi, la scena restituisce a tutte queste persone
quell’umanità, quella bellezza, quella ricchezza di
caratteri personali e culture antiche, che gli avvilenti
incontri quotidiani che abbiamo con loro ai semafori o
per strada sembrano voler negare e cancellare, quasi con
rabbia.
- Dalla musica al teatro
- Giorgio Simbola ha quarant'anni e un passato drammatico.
"Sono nato in una famiglia povera del Nuorese -
racconta - proveniente a sua volta da una famiglia ancora
più povera, con una tradizione endemica di emigrazione
alle spalle. Mio padre aveva sei bambini da
mantenere". Per lui, la professione teatrale è
iniziata con la musica. In casa sua non c'era neanche un
disco, ma lui si è impegnato ed è diventato un esperto
trombonista. Ancora oggi, per mantenersi, suona con
alcune band italiane, soprattutto musica etnica e
d'avanguardia. Due universi lontani e incomunicabili?
- "No - spiega -. Credo ci sia un legame tra i due
generi. Oggi, più nessuno suona le pizziche per guarire
un tarantolato e chi lo fa compie un'operazione
intellettuale di recupero. Ci sono degli artisti che
sentono il bisogno di rifarsi alle origini, guardando in
avanti. John Zorn, Don Byron, Trilok Gurtu, ma anche
Riccardo Tesi e Trovesi sono dei grandi sperimentatori
che hanno ripreso a suonare le musiche della tradizione.
Invece del jazz americano utilizzano come base le
tarantelle".
- E' stato suonando a teatro, guardando le compagnie
lavorare, che Simbola ha imparato a fare l'attore e il
regista. "Il teatro è più potente della musica -
dice -. Ti riporta all'essenza di te stesso".
- Il limite della situazione teatrale oggi, secondo il
regista, è che si è cristallizzata troppo sulla
tecnica. "Ogni persona, secondo me, può essere
artista. Il teatro non è esclusiva di una élite. Tutti
devono avere la capacità materiale di fare arte. Io ho
creduto che fosse possibile fare questo lavoro, a livello
professionale, solo a 35 anni. Ancora oggi, quando torno
al mio paese, mi chiedono della mia occupazione.
"Fai teatro? - dicono -. Sì, teatro, ma per campare
cosa fai?". Io mi chiedo perché il figlio del
professionista deve avere la possibilità di fare tre
mila stage e io, a tredici anni, devo lavorare. Quando
parlo con alcuni musicisti, loro mi dicono che no, non
hanno avuto problemi. Allora, perché, invece, io devo
suonare all'Ipercoop vestito come un cretino per avere
dei soldi? Lavorare nel teatro e nella musica è un fatto
talmente serio che devi avere una forte passione per
farlo. Il colmo, poi, sono i teatri stabili che bruciano
miliardi e miliardi ogni anno. Ieri i rom sono entrati
per la prima volta nella loro vita in un teatro e sono
rimasti senza fiato. A me sono scesi i lacrimoni. Pensa,
sarebbero morti senza conoscere il teatro. Se andare di
fronte a un palcoscenico e vedere Canale cinque, però,
è la stessa cosa, allora il teatro non dovrebbe
esistere. Io non sono un teorico o un intellettuale,
quando decido di lavorare è perché mi trovo di fronte a
situazioni che mi fanno piangere".
- Una delle attività preferite dal regista è quella del
pugilato. Scopriamo che, nella sua formazione, due libri
sono stati fondamentali: "Il teatro e il suo
spazio" di Peter Brook e "Teatro e box" di
Franco Ruffini.
- "Il pugile agisce con immediatezza - spiega -.
Quando un boxeur perde sta male fisicamente, deve stare a
letto alcuni giorni, pieno di botte. Lo stesso è per un
attore o un regista quando "buca" uno
spettacolo. A me è successo al Kismet di Bari. Sono
stato male per tre giorni: era come se avessi la
febbre".
-
- Bramacieli, solstizio d'estate
- Il primo spettacolo che ha realizzato come autore, un
paio di anni fa, è "Bramacieli": nella lingua
dei calderai, i lavoratori di rame del suo paese,
significa "Solstizio d'estate".

- Il metodo usato nella costruzione di questo primo
spettacolo è identico a quello applicato a "Com'è
fatta la terra di mio padre?"
- "Parto dal principio dell'evocazione, riporto a
galla dei ricordi del passato, poi associo delle
immagini, alcune le uso come sottotesto e altre, invece,
le faccio emergere sul palcoscenico. Nello spettacolo che
avete visto voi ho elaborato dei materiali emersi dalle
conversazioni con i miei compagni. Poi io davo delle
indicazioni sceniche e montavo il tutto. In
"Bramacieli", invece, sono andato indietro, a
ripescare nella mia infanzia e nel mio passato di
emigrante".
- Simbola infatti ha viaggiato una decina d'anni, è stato
in Australia, in Israele, dove faceva il camionista, e
poi, nel '90, è tornato in Italia. E' arrivato a Bologna
e si è messo a fare l'autista per una ditta che
collaudava contenitori per gas compressi. Poi sono
iniziati i problemi con la casa. Gli hanno dato in
affitto un appartamento che era già stato venduto: gli
hanno tolto la residenza ed è stato mandato dal comune
in un campo nomadi. Questa esperienza riemerge nello
spettacolo, insieme all'infanzia in Sardegna.
"Quando ero piccolo la vita era regolata da una
sorta di codice barbaricino: una serie di norme non
scritte che poi sono state devastate dalle leggi italiane
e che stanno man mano scomparendo". Il furto di
bestiame, per la sua comunità, era un atto di valore.
- "La colpa - commenta - era di chi si faceva fregare.
C'erano anche delle norme di riparazione: ogni famiglia
doveva donare una parte del suo gregge al derubato, ma la
colpa restava sua".
- Mesina, che era un super ricercato, si faceva
tranquillamente fotografare allo stadio. Per quella gente
il sequestro è normale. In Sardegna c'è una percentuale
di poliziotti più elevata che altrove. I rom sono come i
sardi: hanno un forte senso del valore individuale. La
persona da rispettare non è quella ricca, ma quella che
riesce a portare benessere alla comunità.
- Il prossimo spettacolo
- Simbola sta già pensando ad un nuovo spattacolo. Infatti
è appena morta una donna del Lazzaretto occupato così
il regista ha cominciato a raccogliere molti materiali
orali, analizzando le reazioni e i sentimenti dei suoi
compagni. Studia il serbo e il romki e vuole far
rientrare nella rappresentazione i temi dell'infanzia e
dell'aldilà. Tra pochi giorni dovrebbero arrivare a
Bologna gli operai di una fabbrica serba distrutta dai
bombardamenti Nato. "Abbiamo deciso - spiega il
regista - dopo varie liti, di fare lo spettacolo e di
donare il cachet, nonostante il sacrificio, per la
ricostruzione della fabbrica".
- Compagnia del Lazzaretto occupato
- "Come è fatta la terra di mio padre?"
- regia Giorgio Simbola
- con gli abitanti di Via del Lazzaretto 17, Bologna
-
-
- QUEGLI ATTORI CHE VENGONO DAI SEMAFORI
- A teatro le fatiche di vita quotidiana
della famiglia di attori del Lazzaretto Occupato
- di Cristina Vercellone
-
- Con il nuovo spettacolo "Com'è fatta la terra di
mio padre?", Giorgio Simbola continua la ricerca
sulle tradizioni popolari già avviata nel precedente
monologo "Bramacieli". In esso Simbola operava
estraendo dalla sua memoria infantile i rituali della
Sardegna, ma anche il dramma dell'immigrazione iscritto
nel suo Dna da generazioni. Rispetto a ciò si definisce
il compito del teatro: portare alla consapevolezza
collettiva la tragedia dei poveri: poveri come i pastori
nuoresi di cui è figlio, ma poveri anche come i rom con
i quali vive da dieci anni.
- E proprio insieme agli zingari del Lazzaretto occupato è
realizzato questo suo ultimo lavoro che si è aggiudicato
il premio speciale dell'associazione Scenario.
- Il lavoro non poggia su alcun testo letterario: solo
materiali viventi, il dramma quotidiano degli attori
costretti a elemosinare ai semafori delle strade.
- Ma in ciò è anche il suo limite: questa dura realtà
viene spiattellata sulla scena, senza alcuna ulteriore
elaborazione drammaturgica. Così invece di guadagnare
freschezza, lo spettacolo la perde. Manca lo spessore dei
personaggi e gli attori sono semplicemente sul palco a
rappresentare se stessi. Dov'è la differenza tra teatro
e vita?
- Non c'è sviluppo, la performance sembra procedere sempre
sullo stesso tono, senza un'idea veramente folgorante.
- In realtà l'elemento trainante è la musica composta
dalla saxofonista italiana, in scena insieme ad altri
suoi compagni d'orchestra: brani jazz fusi con melodie
tratte dal repertorio etnico. A Simbola però gli spunti
non mancano, i presupposti per un intreccio drammaturgico
più maturo ci sono tutti, a partire dai racconti
imbastiti su materiali etnici.
- Forse il tema della morte e dell'aldilà nella tradizione
rom, che è l'oggetto del nuovo spettacolo in
preparazione al Lazzaretto occupato, offrirà alla
compagnia maggiori possibilità per andare oltre la
semplice presentazione dei fatti. Da Simbola ci
aspettiamo solo questo, ma ci vuole tempo. Tempo che
consenta anche agli attori di superare almeno la barriera
della lingua. Per questo non risulta ingiustificato il
premio assegnato alla troupe di immigrati.
-
-
- SULLA SCENA LA REALTÀ SUPERA LA
FINZIONE
- Premio speciale al teatro militante di
Simbola
- di Elisa Orlandi
-
- Alla prima di "Com’è fatta la terra di mio
padre?" si accede alla suggestiva sala in penombra
del Teatro San Martino accompagnati dalle note di quattro
musicisti nascosti dietro le gradinate della platea: un
brano svagato ma grintoso, che infonde un certo brio e
contemporaneamente cala il pubblico in un’atmosfera
di luoghi lontani.
- Un pubblico, a ben guardare, piuttosto eterogeneo: a
parte gli abituali frequentatori di un teatro di tipo
alternativo, sono riconoscibili diversi volti già visti
qualche ora prima a Palazzo Marescotti (in occasione
dell’incontro che ha inaugurato le due giornate di
debutti dei vincitori del Premio Scenario), ma
soprattutto numerosi ed euforici i parenti, gli amici, o
forse solo i conoscenti dei membri dell’esordiente
Compagnia del Lazzaretto occupato di Bologna.
- Le luci si abbassano del tutto, mentre i musicisti
proseguono in una sorta di ouverture, escono allo
scoperto, si fanno avanti tra gli spettatori per poi
scomparire nuovamente donde erano venuti.
L’attenzione si sposta finalmente sulla scena,
essenziale al massimo (un tavolo, qualche seggiola), con
l’ingresso di un uomo spaesato e stravolto, a cui
sono avvinghiati quattro bambini, i suoi figli. Dalle
battute amare e allo stesso tempo ironiche che scambia
col tecnico luci si evince immediatamente la situazione:
quest’individuo è uno dei tanti profughi
"illegali" che, in mezzo a mille difficoltà e
consapevole di doverne affrontare mille altre, ha
lasciato il suo Paese devastato dalla guerra, convinto di
andare incontro a un futuro sereno per la sua famiglia.
- Questa prima scena, che è un po’ l’antefatto,
il prologo, sembra anche essere l’unica in cui è
percepibile il desiderio di indagare
sull’immaginario e sulle aspettative di chi non per
scelta, ma per forza, è costretto a emigrare. Sappiamo
che questo era il tema originale del progetto di Giorgio
Simbola, ideatore, regista e principale interprete dello
spettacolo e sappiamo anche che la sua prospettiva è
cambiata col passare del tempo, avendo egli preso
coscienza che, arrivati ad un certo punto, non era più
possibile parlare di sogni, ma bisognava lasciar spazio a
un’impellente necessità di gridare la condizione di
malessere che attanaglia l’esistenza di queste
persone.
- Tutto ciò si riscontra chiaramente nella drammaturgia
scenica: quell’ingenua sensazione di certezza, di
fiducia e d’illusione che accompagna l’uomo
appena sbarcato in terra straniera viene subito
abbandonata e il palcoscenico si trasforma in una
finestra, in una sorta di "fotogramma fisso"
(come il regista ama definire il suo Teatro del
Lazzaretto) su una realtà drammaticamente vicina e
presente.
- Dosando in maniera efficace e pregnante il dato di
cronaca e la reazione emotiva, ci viene mostrata la
rabbia di un uomo umiliato e risentito che è costretto a
scrivere cartelli imploranti un aiuto e trascorrere la
giornata sul ciglio di un marciapiede o presso un
semaforo; l’impotenza e l’avvilimento di un
ragazzo che confessa, come se sottoposto a un
interrogatorio, l’estenuante vagabondaggio per le
continue istanze di sgombero imposte dalle forze
dell’ordine; l’esigenza collettiva di dare
sfogo all’aggressività e alle tensioni accumulate
scatenando liti tanto furibonde quanto innocue.
- Nulla in queste scene è finzione, a cominciare dai
protagonisti, che sicuramente non sono attori
professionisti, eppure non devono ricorrere a chissà
quali tecniche recitative per ottenere la perfetta
immedesimazione. E non si tratta di talento innato: sono
persone che raccontano se stesse esprimendosi con la
lingua che conoscono oppure che non dicono proprio nulla,
ma la cui sola presenza ha già un valore, quello della
testimonianza e dell’autenticità. Il gruppo,
infatti, se si eccettuano Simbola e i quattro musicisti,
è costituito da alcuni membri di sei famiglie
prevalentemente di etnia rom che da circa nove anni
vivono insieme e, come conseguenza, hanno maturato la
convinzione che l’arte debba appartenere alla
quotidianità, come il mangiare, il dormire,
l’abitare.
- "Come è fatta la terra di mio padre?",
tuttavia, non è costruito soltanto attorno alla cronaca,
alla fedele ricostruzione di frammenti di vita. Vi sono
anche degli abbandoni a parentesi, se vogliamo, più
liriche, che danno voce in modo diretto ed esplicito,
alla soggettività dell’ideatore e della compagnia.
- È il caso della sequenza (forse fin troppo lunga, nella
generale economia dello spettacolo) in cui Simbola
propone, rielaborandole, leggende della secolare
tradizione rom, come a voler recuperare nella dimensione
teatrale le radici di una cultura che sta definitivamente
scomparendo, in una realtà quotidiana su cui gravano
preoccupazioni ben più impellenti. È anche il caso di
altri episodi tratti dalla loro diretta esperienza, ma
proposti con espedienti drammaturgici volti a toccare le
corde più sensibili dell’animo dello spettatore e
dove, sinceramente, il limite tra partecipazione commossa
e patetismo affettato si fa sottilissima. Il riferimento
è all’ultima parte della rappresentazione: dalla
voce di donna fuori campo che narra il suo passato,
lasciando intuire che si tratta dell’attuale
condizione di due bambine che, nel frattempo,
distribuiscono fiori e disegni tra il pubblico, al
monologo di Simbola sull’ennesimo dramma di una
giovane profuga, privata della possibilità di cure
adeguate e morta di leucemia, che solo dall’interno
di una bara ha potuto smettere di preoccuparsi dei
documenti per tornare in patria.
- Con questi due quadri si chiude lo spettacolo, anche se
il regista non ha rinunciato all’opportunità di
spendere ancora qualche parola sulla realtà tragica di
cui è testimone ogni giorno e sull’eccezionalità
di quest’evento teatrale per i suoi
"attori", la maggior parte dei quali calcava
per la prima volta un vero palcoscenico. Forse per questo
motivo il lungo e festoso ballo che ha trascinato tutta
la compagnia durante gli interminabili applausi finali
pareva avere un non so che di liberatorio: che fosse un
attimo di congedo dai problemi di sempre o molto più
semplicemente la reazione alle tensioni che seguono un
debutto teatrale poco importa: quel che si è percepito
sono stati, ancora una volta, la spontaneità,
l’autenticità e l’affetto che li unisce.
-
-
-
- QUESTA TERRA È ANCHE LA MIA TERRA
- Considerazioni in margine al teatro-vita
di Giorgio Simbola
- di Samanta Picciaiola
-
- Il teatro entra nella quotidianità.
- Per raccontare, testimoniare e denunciare la realtà di
sofferenza e di emarginazione di un gruppo di rom vissuta
nel cuore della colta e ricca Bologna.
- Per rivendicare un modo di fare arte impegnato, militante
che molti liquidano come retorico e banale: strada
vecchia già battuta da tanta avanguardia novecentesca
che sembra aver perduto ormai ragione di essere di fronte
al dilagare di un benessere pago e compiaciuto di sé.
- Ma a ben vedere le intenzioni non sembrano le stesse né
possono esserlo: la realtà italiana è cambiata
nell'arco di un cinquantennio, riservando allo sguardo
capace di coglierle nuove inquietanti contraddizioni.
- E’ proprio tutto dentro tali contraddizioni che va
ricercato il teatro di Simbola, le sue intenzioni, le sue
urgenze.
- Quando chiediamo al regista il perché di una scelta di
campo così radicale, risponde che il teatro costituisce
per lui un'esigenza di tipo biologico: esigenza di
raccontare e di esprimere che può radicarsi solo entro
un contesto di vita vissuta, di esperienze e di
emergenze.
- Emergenze che da tempo condivide con la sua famiglia di
attori, occupando illegalmente uno stabile di via del
Lazzaretto.
- La sua arte nasce nell'incontro di bisogni schiaccianti,
di domande senza risposte, di illusioni e di umiliazioni
quotidiane.
- Di fronte a tutto ciò il teatro si fa tramite di
comunicazione, la sua forza risiede nella sua peculiare
relazionalità: in scena le emozioni arrivano ad un
pubblico forzatamente presente, incapace di nascondersi
cambiando canale.
- Per questo è necessario riempire i teatri in modo
diverso da come avviene ora: Simbola denuncia la vuotezza
di un certo teatro fermo alla ricerca formale e ripiegato
su se stesso.
- Un teatro per intellettuali incapace di creare relazioni
significative con il contesto reale in cui si inserisce,
rinunciatario nei confronti di qualsiasi esigenza sociale
e comunitaria.
- A esso Simbola oppone un'istanza che è innanzitutto di
tipo etico, ancorchè estetica: la solidarietà.
- Solidarietà a una condizione che lega il destino del
regista a quello dei suoi attori: la condizione di
emigrato che lo stesso Simbola ha vissuto, lontano da una
ventina d’anni dalla sua terra di Sardegna, e che
non esita a definire come una sorta di deportazione.
Deportazione in quanto esito scontato di una situazione
di stasi quale si delinea in tutte quelle realtà di
povertà, ben presenti al nostro regista, cresciuto in un
paesino del nuorese, in una famiglia già profondamente
lacerata da precedenti di emigrazione.
- Ma anche solidarietà che diviene fusione e commistione
di ricordi che prendono corpo sul palcoscenico, andando a
costituire i nuclei narrativi della rappresentazione
stessa.
- Lavorando entro il comune paradigma dell'emarginazione e
dell'esclusione Simbola è giunto alla stesura di questo
spettacolo. Infatti attraverso il dialogo con i suoi
compagni rom, il regista rievoca cammini e desideri,
speranze e illusioni, fino a giungere al cristallizzarsi
di immagini a partire dalle quali si dipana tutta la
rappresentazione e che di essa costituiscono una sorta di
sottotesto, di codice nascosto.
- Si tratta di un lavoro di scavo interiore, attraverso il
confronto costante con gli altri nella quotidianità
condivisa della casa occupata.
- Di qui la necessità di ricorrere ad una continua pratica
della relazione, ad una sorta di training forzato, che il
contesto di convivenza della Compagnia del Lazzaretto
occupato sperimenta ogni giorno.
- Attorno alla dimensione diaristica si costituisce un
immaginario comune che può essere portato in scena quale
segno esistenziale inconfondibile.
 Pertanto il teatro
di Simbola riconosce una istanza innanzitutto etica:
quella della fedeltà ai contenuti, ovvero agli obiettivi
che la ricerca stessa si pone nel momento di ideazione
del progetto: un'ideale di trasparenza necessario a ogni
opera d'arte che si collochi entro una reale volontà di
incisione e modificazione della realtà.
Pertanto il teatro
di Simbola riconosce una istanza innanzitutto etica:
quella della fedeltà ai contenuti, ovvero agli obiettivi
che la ricerca stessa si pone nel momento di ideazione
del progetto: un'ideale di trasparenza necessario a ogni
opera d'arte che si collochi entro una reale volontà di
incisione e modificazione della realtà. - Ma la peculiarità di un'opera come questa, che il nostro
regista è riuscito a mettere in scena grazie all'aiuto
di attori non professionisti -uomini nella parte di se
stessi - è nella volontà di superamento di un intento
meramente propagandistico.
- Non si tratta di elogiare la poesia del popolo rom come
accade in tanta cultura a basso costo circolante oggi,
desiderosa solo di esotismo tzigano, ma di recuperare la
tradizione della propria comunità, entro un contesto di
emarginazione in cui il desiderio di sentirsi accettati
porta ad assumere come propria quella che Simbola chiama
la cultura dominante.
- E' necessario salvaguardare le differenze perché solo a
partire da esse possiamo sperare di radicare la nostra
identità: restituiamo a un popolo il suo immaginario
collettivo, nella sua radicale diversità e alterità.
- E pur nella diversità Simbola ritrova un elemento di
forte vicinanza con questo popolo, al punto di dichiarare
una sostanziale contiguità della tradizione, della
cultura e della lingua rom a quella della sua infanzia,
che è lingua di un villaggio di ramai della Sardegna.
- Con questa rappresentazione si approfondisce il rapporto
con la propria terra d'origine, che aveva visto Simbola
impegnato in un precedente spettacolo dove i ricordi
della propria infanzia riemergevano attraverso il
recupero della tradizione pastorale sarda.
- Simbola ribadisce con forza il proprio attaccamento a una
tradizione archetipicamente rivissuta attraverso il
teatro. Tradizione inoltre fortemente vicina a quella dei
rom: rommonais è detta la lingua del villaggio di ramai,
romschi quella dei gitani.
- La radice comune dei due termini richiama la vicinanza
dei due popoli, della vita del regista a quella dei suoi
compagni-attori.
- Così con "Come è fatta la terra di mio
padre?" il cerchio immaginario di questo viaggio
della memoria si chiude.
-
-
- IL TEATRO MI DA' NOIA
- MA IL BALLETTO ANCOR DI PIU'
- Lamattina punta alla contaminazione tra le
arti
- di Daniela Turco Liveri
-
- Tutto parte dalla dichiarazione che Gerardo Lamattina ha
espresso durante la conferenza di presentazione dei vari
artisti, "Dopo il Premio", tenutasi a palazzo
Marescotti sabato 5 gennaio.
- Lamattina, per prima cosa, confessa la sua noia per il
teatro e soprattutto per la danza.
- Fatto sta che il lavoro presentato in collaborazione con
la compagnia Bassani-Bruni altro non è che una sintesi
tra teatro, danza e musica dal vivo.
- Il lavoro di collaborazione tra il regista e i vari
artisti, danzatori e musicisti, si è basato
fondamentalmente sul concetto di libertà.
- Ciò ha permesso ai singoli attori di gestire il proprio
ruolo e di costruire un'adeguata personalità all'interno
dei vari momenti della performance.
- Si è trattato come affermano le due coreografe di un
lavoro corale: loro sono Selina Bassini e Claudia Bruni,
che assumono un ruolo guida per il coordinamento dei
ballerini, tutto il resto è affidato alla creatività.
- Interessante il fatto che le due coreografe provengano da
due scuole formative diverse: la Bassini possiede un
passato da ginnasta artistica e ha sempre seguito un
percorso di ricerca; al contrario Claudia Bruni, ha una
formazione più classica, prevalentemente solistica.
- La spiegazione della presenza di due coreografe è da
esse subito chiarita: il loro lavoro si basa su una
reciproca compenetrazione e un incastro di idee: una
innova, mentre l'altra pulisce con il suo tecnicismo,
l'una usa troppa dovizia, mentre l'altra scompagina
l'eccessivo schematismo.
- Obiettivo finale è di portare un gruppo di danzatori a
scoprire se stessi.
- Il ruolo di distruttore che Lamattina si è assunto, nel
momento in cui si è reso disponibile a seguire il
progetto, ha tenuto conto della sua esperienza di
filmaker.
- Dell'originario studio, "L'anacoreta della
pioggia", è rimasto ben poco; il regista si è
permesso in coerenza con le sue idee sulla danza, di dare
al tutto un taglio cinematografico per dare così anche
un taglio alla noia, con picchi di esagerazione sparsi
qua e là.
- Per lui un gesto di danza è un segno della personalità
di ognuno, per lui ogni segno è immagine.
- Durante le varie coreografie si alternano canzoni e frasi
frammentarie, tutte atte a rappresentare situazioni ed
esperienze di vita differenti, anche i movimenti dei
ballerini talvolta si fanno goffi e ridicoli per
sottolineare stati d'animo forti e penetranti.
- L'orchestra formata da un terzetto (tastiera e
fisarmonica, fagotto e voce, violoncello) aiuta a
ricreare talora un'atmosfera da balera, ora quadretti
sfocati di una realtà passata; così si susseguono le
note di un malinconico tango argentino e quelle più
caserecce della musica della Romagna, che in questo caso
viene eletta a provincia del mondo.
- Significativa è inoltre l'irruzione della memoria sulla
scena, ognuno tenta di raccontare frammenti della propria
storia ma ciò che ne rimane dalle continue interruzioni
di musica e ballo non è altro che ricordi proiettati su
uno schermo, frasi smorzate, emozioni segrete e pensieri
d'infanzia.
- La memoria si allarga fino a diventare una memoria che in
qualche caso accomuna tutti nella situazione del
presente.
- "Che musica Maestro" ricomincia a cantare
Selina, tutto ritorna al proprio posto proprio com'era
all'inizio; come un circolo infinito la magia si spegne e
la vita continua il suo corso sempre uguale.
-

-
- Compagnia Bassini Bruni/Tangaz
- Coreografie Claudia Bruni e Selina Bassini
- Cura degli spazi e coreografie Gerardo Lamattina
- Musiche dal vivo eseguite da Federica Maglioni (voce e
fagotto), Michele Guidi
-
-
-
- (tastiere e fisarmonica), Cecilia Zanni (violoncello)
- Interpreti Selina Bassini, Aldo Rendina, Rhuena Bracci,
Claudia Bruni, Sergio Scarlatella
-
-
-
- APPARENTEMENTE LA ROMAGNA STA BENE
- Aporie della provincia romagnola
- di Alberto Marchesani
-
- "Apparentemente sto bene" è una delle poche,
pochissime battute che in Tangaz gli attori e i ballerini
pronunciano. Un collage fatto di soggetti smarriti,
visioni sfocate, appena percepite e presto sfuggite, un
dipinto tragicomico della Romagna falsamente spensierata.
Libere associazioni di idee, rimandi blandi, movenze
semicomiche per rappresentare un bel ritratto di una
provincia, che può essere qualunque provincia. La
formazione cinematografica del regista Gerardo Lamattina,
laureato appunto in cinema, salta subito agli occhi per
il taglio frenetico del montaggio che non lascia un solo
momento lo spettatore in balia di quella mortale noia di
brookiana memoria. Come lui stesso afferma: il teatro lo
annoia molto, ed è da questo presupposto che decide di
montare le scene come per accatastamento,
un’efficace narrazione frammentata, ponendosi dal
punto di vista dello spettatore tipo che a teatro non
vuole sbadigliare.
- Frenesia, movimento, atleticità, ma anche malinconia e
un velato senso di rispecchiarsi all‘interno, tutto
questo crea la performance. Una balera in cui i tre
ballerini e un attore, assieme al tango e al liscio
romagnolo, raccontano se stessi, per farlo però
pronunciano una sola frase a testa, da loro stessi
scritta. Frasi lapidarie. Spesso di ritorno
dall‘infanzia. Sempre fermando la musica, suonata
- sul momento da tre abili musicisti. Uno spettacolo che
vuole essere estremamente pop, ma che per la sua tensione
intensa e introspettiva, risulta andare ben oltre le
intenzioni dei suoi ideatori. La provincia romagnola,
dietro le balere e i divertimentifici, scopre che le
curve della vita riservano infinite sorprese. La
compagnia Bassini & Bruni si è formata nel 1997,
prende il nome dalle due coreografe che solo un anno dopo
si legano col filmaker Lamattina in un proficuo
sodalizio.
-
-
- QUANTA NAPOLI BATTE IN QUESTO
"CORE"
- La tradizione partenopea nello spettacolo
della compagnia Babbaluck
- di Samantha Picciaiola
-
- "Core": ovvero sono di scena il varietà,
Eduardo de Filippo, la tradizione partenopea e i
funamboli, in un continuo susseguirsi di quadri, bozzetti
e caricature. Ogni tentativo di ricostruzione di uno
spettacolo di questo tipo è destinato a infrangersi
contro le intenzioni stesse che lo sottendono: fissare in
quadri provvisori il flusso di emozioni e sensazioni
della vita. Ecco come ce ne parla la scenografa Annapaola
Bartolomeo.
- Come nasce uno spettacolo come "Core" e
quali sono le intenzioni fondamentali che lo animano?
- "Core" nasce dal desiderio di armonizzare
esperienze diverse quali quelle che i membri della
compagnia Babbaluck hanno compiuto prima di approdare
qui. In particolare mi riferisco alle differenti
attività che ciascuno di noi ha svolto e svolge quali la
fotografia, la pittura, la recitazione, l'arte di
strada... Si tratta comunque di ritrovare un'armonia tra
queste diverse esigenze espressive, non di tentare una
contaminazione tra diverse arti.
- E' per questa vostra familiarità con le arti visive
che "Core" si presenta come una lunga sfilata
di quadri e immagini?
- Direi di sì, si può parlare di una molteplicità di
immagini a cui sono legate tante possibili storie che lo
spettatore deve intuire e inventare.
- Per questo la Compagnia Babbaluck ritiene fondamentale
il rapporto con il pubblico?
- Sì, per noi sono gli spettatori, con le loro emozioni e
con le loro reazioni, a dare senso e significato a ciò
che proponiamo.
- Nello spettacolo sono spesso presenti rimandi alla
tradizione partenopea: possiamo affermare che essa
costituisce il vostro punto di riferimento?
- No, non direi punto di riferimento, piuttosto essa
costituisce il nostro modo di sentire e di essere, ne
siamo impregnati. La nostra poetica si radica
sull'incoscienza, non c'è storia all'interno dei nostri
spettacoli.
- Tutto nasce da un'esigenza puramente comunicativa,
dunque?
- Sì da un'esigenza espressiva direi, visto che il nostro
intento è quello di mettere in scena ciò che parte
dalla nostra incoscienza, dal suo flusso continuo.
- E' per questo che nel vostro spettacolo prevalgono
elementi visivi e auditivi?
- Sì, proprio questa esigenza espressiva determina la
maggiore presenza di suoni, luci e colori rispetto al
parlato. Anche perché il linguaggio visivo e auditivo è
dotato di un'universalità sconosciuta al linguaggio
verbale, come abbiamo avuto modo di sperimentare negli
spettacoli che abbiamo portato all'estero, riscuotendo
molto entusiasmo da parte del pubblico.
- Secondo te che cosa caratterizza il teatro rispetto
alle altre forme artistiche, che cosa lo rende a voi più
consono?
- Nulla, il teatro ci consente semplicemente una migliore
espressione; altri artisti, invece, si riconoscono di
più nella danza o nella pittura.
- Un'ultima domanda, che cosa ha significato per voi
essere premiati da questa edizione di Scenario?
- Credo che si tratti di una bella possibilità perché va
ad incidere proprio su quell'aspetto che a una compagnia,
numerosa come la nostra, manca: l'organizzazione, la
possibilità di avere un sostegno concreto alla
realizzazione dei nostri progetti. Ci auguriamo che possa
costituire un punto di svolta per la nostra compagnia che
fino ad ora è sopravvissuta autofinanziandosi e
autopromuovendosi, al di fuori di qualsiasi intervento
istituzionale.

-
- Compagnia Babbaluck
- "Core"
- regia: Sergio Longobardi
- aiuto regia: Emanuele Valenti
- con: Nicola Laieta, Sergio Longobardi, Cecilia Muti,
Julia Sorano
- costumi: Daniela Salernitano
- con il lavoro di: Marcella Angrisano, Chicca Bartolomeo,
Olivia Bignardi, Alessandro Federico, Carmine Pierri,
Alberto Sarcina, Giulia Urciuoli, Marco Zezza.
-
- MALEDETTA QUESTA INCOSCIENZA
- Una rappresentazione senza capo né coda,
immagini sconnesse e prive di ironia
- di Jean Claude Capello
-
- Cosa scrivere di una rappresentazione fatta di immagini
senza alcuna connessione drammaturgica come
"Core"? Esistono un gusto estetico e una
ricerca poetica che legittimino questa scelta della
compagnia Babbaluck?
- Di questo lavoro si può dire solo che è inaccettabile e
a questo punto bisogna dubitare anche
dell’opportunità del premio speciale assegnato ex
aequo alla compagnia dall'associazione Scenario.
- Già in occasione della presentazione in pubblico dei
primi venti minuti dello spettacolo, al festival di
Santarcangelo, il gruppo aveva destato più di un dubbio
negli spettatori. Allora "Core" grondava di
stereotipi della napoletanità riproposti senza eccessivo
mordente; oggi, lo spettacolo non è affatto migliorato,
è semplicemente più lungo; anzi, alcune intuizioni
comiche, tipiche del teatro di strada, che allora avevano
reso digeribile la rappresentazione, non bastano più a
salvare un lavoro così povero. Un po' di ironia in più
avrebbe potuto dare una svolta alla trita trattazione dei
materiali proposti. In "Core" abbonda solo
l'incoscienza, parola magica con cui il gruppo spiega la
propria poetica e la sua non-necessità di fare teatro.
- Forse gioverebbe agli attori, nonostante le difficoltà
che da sempre affliggono i giovani artisti e la notevole eterogeneità
di un gruppo proveniente per lo più da esperienze
extrateatrali, tentare di capire cosa stiano facendo
realmente e dove stiano andando. Non dovrebbero
confondere la freschezza espressiva propria del neofita
con quello che loro definiscono incoscienza. Ciò che lo
spettatore vede è una articolazione paratattica delle
scene assolutamente poco intrigante, ma anche una
adesione stanca e macchiettistica ad alcuni fastidiosi
stereotipi, scelti a caso fra la contaminazione con le
arti visive, le gag da clown e un po' di napoletanità.
-
- IN SCENA SOLO UN PO' DI CATTIVO
VARIETÀ
- Troppa confusione che annoia lo spettatore
- di Samantha Picciaiola
-
- Si apre il sipario ed è subito un turbinio di colori e
luci: tanto ricco da sembrare confuso.
- La scena si anima con l'ingresso degli attori che danno
il via ad un lungo carosello di gag e sketch: lo
scontro-incontro delle valigie di due giovani viandanti,
la lite filosofico-quotidiana di marito e moglie ad
inizio giornata, l'elogio della "tazzuriella"
di caffè napoletana e poi tutto un rincorrersi di tanti
piccoli bozzetti, schizzi di vita lontana.
- E' impossibile completare l'elenco delle piccole storie
contenute dentro uno spettacolo come "Core":
nessuno degli elementi presenti in scena si collega agli
altri. Non ci sono, né si cercano, disegno organico né
uno sviluppo drammaturgico rinvenibile alla fine della
visione.
- Forse esso si è volutamente smarrito nella mente degli
autori presi dal desiderio di far sembrare il tutto
volontariamente involontario, in altre parole
"incosciente".
- Il cartello luccicante di brechtiana memoria che
campeggia sulla scena dall'inizio dello spettacolo,
sembra successivamente trasformarsi da cometa e
rassicurante guida per lo spettatore, in una bussola
impazzita: frammenti di storie si accavallano
disperatamente e freneticamente.
- Dopo la prima mezz'ora di spettacolo l'occhio è
assuefatto da tanta abbondanza di colori e costumi e
l'orecchio è stordito dalla musica roboante mescolata,
non sempre egregiamente, a dir la verità, dai tecnici
del suono. Così la noia prende il sopravvento.
- Ad attirare l’attenzione rimangono solo le
passeggiate degli attori-funamboli sulla scena che si
inframmezzano a nuovi seducenti quadretti di banalità
quotidiane: foto viventi di famiglia, balletti sensuali,
ammiccanti strisce pubblicitarie, tutto può rientrare
dentro questo grande contenitore spettacolare.
- A ben vedere il modo migliore per parlare di questo
spettacolo è quello di abbandonare ogni dimensione
spazio temporale, ogni nesso logico, accettando di cedere
a un flusso continuo incapace però di catturare
veramente colui che guarda.
- Forse perché la corrente è troppo debole e si ha
l'impressione di voler nuotare in un mare troppo basso:
di banalità e di espedienti che ricordano tanto il
peggiore varietà.
-
- DALL’ARGINE: FACCIO TEATRO PER
CAPIRE IL PRESENTE
- "La pallottola del cecchino a
Sarajevo è come un’auto killer sulle nostre
strade"
- di Jean Claude Capello e Morena Cecchetti
-
- Tu sei mai stato nella ex Jugoslavia?
- Sono stato in Croazia due volte. Una volta fu a Sebenic,
con il Comitato Emergenza Infanzia e il Teatro delle
Briciole. Lì c’era un festival ormai chiuso da
diversi anni, e nel ’95, prima dell’operazione Tempesta
che avrebbe liberato le Krajne, sai la Krajna di Knin, e
le avrebbe liberate definitivamente dai Serbi, grazie al
lavoro degli Americani che armarono i Croati con le nuove tecnologie. In un anno avrebbero
cacciato via i Serbi da Knin, che poi sono quelli che
arrivarono in Kossovo: questa gente è stata profuga due
volte. Io sono andato lì a fare questo spettacolo per
bambini, e per una settimana ho dipinto con loro dei
portoni a Knin.
- Sono ritornato in Croazia con la mia donna in moto,
quando la guerra era relativamente finita. Ho viaggiato
lungo la Costa Dalmata in moto, rischiando lo stesso la
pelle dove sono arrivato a Dubrovnic, dove mi sono
fermato quindici giorni. Lì sono stato ospite presso
delle famiglie e andando un
po’ ad intrigarmi, in giro a vedere, raccogliendo
delle impressioni che non sono state belle. Sono tuttora
luoghi in mano ai militari e alla mafia. Io ho preso
molto dai giornali, di mio c’è il mio alter-ego: la
forma del sacco è quella del mio personaggio, quello che
penso, l’umanità che ci metto dentro. Io non sono
stato nei luoghi di cui parlo, ho soltanto preso da libri
di giornalisti come Paolo Rumiz, Luca Rastelli, Demetrio
Volcic. Loro raccontano, ognuno con un modo proprio,
molto più bello rispetto ai poeti o ai filosofi che
hanno parlato delle guerre balcaniche come se fossero
avvenimenti che non ci appartenessero, ma riguardassero
invece solamente i cattivi. I giornalisti sono riusciti a
tirare fuori anche della poesia. Ho mantenuto il discorso
delle città come luoghi di profumi e, purtroppo, anche
di morte…
- Il libro di Rastelli l’hai letto prima o dopo il
tuo viaggio?
- No, no… dopo.
- Allora stavi già pensando di fare uno spettacolo sui
Balcani?
- No, assolutamente. Io ero in un periodo abbastanza
strano. Non sapevo cosa avrei fatto nella vita e di
teatro non avevo più voglia.
- A me ha intristito la Slovenia che in teoria doveva
essere quella messa meglio…
- La Slovenia è tristissima, invece man mano che arrivi
giù, anche se sono stati più devastati, nei villaggi
dove ci sono anche i musulmani è un’altra vita, è
un’altra cosa. La Slovenia doveva essere la
repubblica liberata, ma è senza un’identità.
Quella della Jugoslavia era un’altra cosa. Quella
nazione era veramente un’utopia: il tentativo stesso
di mettere insieme dei popoli che andavano dalla Slovenia
fino alla Macedonia era pieno di contraddizioni. La
bandiera stessa, che si vede all’inizio, con la
stella in centro, ne è il simbolo di questa utopia:
rappresentava l’idea di tutte quelle etnie messe
insieme e dell'autogestione. In un modo o nell’altro
era comunque un modo
di stare fuori dai due blocchi, magari di rosicchiare,
anche, un po’ di qua ed un po’ di là.
- Però nell’infanzia, questa stella
dell’autogestione jugoslava mi ha sempre dato
qualche cosa, anche solo a livello visivo o simbolico,
visto che lavoro per intuizione, quindi attraverso i
simboli e gli archetipi. Per questo c’è la palla a
cui do il nome di Sarajevo. All’inizio questa palla
era soltanto un’entità. Veniva da un racconto di
fantascienza che avevo letto, "Il nemico", dove
c’è questa palla che è il nemico; Mi è piaciuto
anche il fatto di usarne tre di
grandezze diverse, che in questo caso rappresentavano i
Balcani (Bosnia, Serbia e Croazia).
- Quest’estate, quando presentasti i primi venti
minuti di Contraerea, mi avevi detto che volevi lavorare
con le marionette. Oggi c’è la scena dei soldati
e, non so se ti ricordi quando eravamo piccoli, mi hanno
ricordato i cartoni animati dell’est europeo, che
oggi non si vedono più. Erano tutti fatti in quel modo.
- Infatti, la mia Jugoslavia era quella. Fruttino,
con i tappini delle bandiere. Spesso i film slavi avevano
addirittura delle scene animate in quel modo, con quello
stile. Erano bellissimi e a me piacevano molto. Poi
studiando è venuto fuori che tutto questo veniva fuori
dall’autogestione, dal mettere insieme delle culture
diverse, che adesso è moderno.
- Che cos’è la Sfinge?
- Quella è la morte. Nello spettacolo c’è il
discorso dell’essere qui mentre là si scrive la
storia. Prima la Sfinge era una sirena e lei l’ho
vista come il problema delle comunicazioni, che
nonostante vediamo i telegiornali, internet, man mano che
le distanze si accorciano, più in realtà sono i vuoti.
- E allora, prima di vedere "Guerre Stellari" e
"Matrix", mi sono fatto questo campionato delle
sirene. Il monologo avrebbe dovuto continuare con i
campionati. Il primo finale che avevo scritto era un
campionato intergalattico dove mi trovavo a giocare, dopo
essere stato battuto dalla Medusa, contro la Sfinge. La
Medusa, con il casco blu irto di serpenti, rappresenta la
Nato, e vince perché mi è entrata nella testa. Con la Sfinge non c’è più niente da
fare, non gareggi neanche. È un simbolo di morte ed è
anche il mio doppio, la voglia di restare fuori le
guerre… La Sfinge rappresenta anche le domande dalle
quali non hai risposte. Inoltre l’ho ricoperta di
questa polvere bianca, che per me ha un significato
personale.
- La sirena è anche il fatto di dire basta: sai quando ti
rovini la vita perché vai dietro alle donne. In quel
periodo lì io me la sono rovinata più volte, per cui la
gara con la sirena significava anche vincere il sesso. La
Medusa era i pensieri, quel nido di vipere che hai in
testa.
- Quel pezzo viene dopo il discorso nel supermercato,
quello sulla società civile che vende armi per creare
nuovi mercati. Dopo di quello non c’è più niente
da dire. La Sfinge è l’Occidente, la
globalizzazione, la morte. Perché
nel supermercato, quando parlano, non c’è futuro,
non è nemmeno più possibile immaginarlo perché non si
riesce nemmeno più a sognarlo visto che in un certo
senso anche i sogni sono preconfezionati. Non sono così
pessimista nella vita, però rispetto alla storia della
Jugoslavia sì.
- In quel momento c’è la perdita completa della
spiritualità, per poi essere disarmato alla fine,
riducendosi a fare l’elenco di quello che ti accade
nella vita: le ciabatte che mancano, che vai a mangiare
una pizza, che devi pagare il bollo della macchina.
Questa è la guerra quotidiana.
- Parlando della parte più tecnica, nel passaggio dai
primi venti minuti al lavoro completo, mi sembra che tu
abbia usato lo stesso finale. Se non sbaglio inizia la
nuova parte dove tu esci per poi rientrare, poco dopo,
come se fossi un profugo.
- Esco di scena, perché ci sono gli aeroplani, e rientro
con la sacca.
- Volevo rincominciare con un risveglio un po’
tossico, per il cloroformio, dicendo alla palla:
"Sai una cosa: mi sa che abbiamo esagerato."
Cloroformio è una parola che compariva un sacco di volte
nei libri che ho usato come fonti: il cloroformio
dell’Occidente e dei media. Ho trovato difficile
ripartire da lì, perché bisognava farlo piano…
Inoltre subito dopo c’è il supermercato che è
stata un’intuizione felice, perché ho trovato il
modo di dire tante cose, magari solo accennate, per voce
di altri personaggi, salvaguardando così la credibilità
del mio alter ego, altrimenti alla fine non potevo più
giocarlo sulla leggerezza. Questa seconda parte è stata un lavoro di scrittura a tavolino.
Dopo ho stravolto le cose, perché a quel punto lì, dopo
i primi venti minuti, la questione jugoslava poteva
essere un pretesto per fare uno spettacolo e così non
andava più bene.
- Cos’è che allora ti spinge a fare del teatro?
- A me non interessa il discorso della memoria, quanto di
codificare il presente attraverso la comunicazione. Cerco
di sacrificare il mio corpo sul palco
per arrivare a capire qualcosa del presente e di darne una lettura non
scontata. I problemi di là sono i problemi di qua: la
pallottola del cecchino a Sarajevo può essere
un’auto killer che investe qualcuno, può essere una
dose di eroina sbagliata… Io mi sento in guerra
anche qua, assediato da una società che ragiona troppo
poco su se stessa, preferendo ragionare sul suo passato
perché così è più facile creare dei prodotti da
vendere…
- Ho trovato più sostenitori tra i coetanei perché sono
più immersi nella contemporaneità di altre persone, fra
le quali metto specialmente ai teatranti. Con mio padre,
che non ama il teatro, di queste cose ne parliamo spesso,
invece chi fa teatro mi sta a dire: "Lì c’è
un po’ più energia…". Io lo spettacolo
non l’ho fatto per fare una prova d’attore, ma
per provare a cimentarmi con la comunicazione, partendo
dal reale.
- Per quanto riguarda le scenografie?
- Sono molto semplici e stanno tutte in macchina. Oggi
avevamo anche la familiare, ma di solito mi sposto con
una macchina normale. L’obiettivo era proprio che
fosse uno spettacolo agile. Spesso, quando giro con gli
spettacoli per teatro ragazzi come pittore, scenografo e
a volte anche come attore, non si finisce più di montare
il camion. Poi magari ti chiedono: "Dai, vieni a
fare lo spettacolo qua, sarebbe bello". Si, sarebbe
bello, ma poi il costo sale tra trasporto e il
montaggio… la mia contraerea era anche rispetto
questo andare delle cose, dove uno non ha più nemmeno la
libertà di prendersi la macchina e raccontare delle
storie. Diciamo che il sistema teatrale mi aveva un
po’ stufato e avevo voglia di prendermi questa
parentesi, anche se so che purtroppo è solo una
parentesi, perché il nuovo lavoro non sarà così.
- Questo lavoro è una sorta di punto di partenza di te
come autore. L’altro giorno, in conferenza stampa,
parlavi, appunto, del prossimo spettacolo. Dicevi che non
vuoi più lavorare da solo e vorresti trovare degli
interlocutori, immagino a livello artistico, con cui
costruirlo.
- Sì. Per il prossimo lavoro, ne parlavo oggi con Mirto,
ho un’idea per partire un po’ dalle pelli di
animali. Come la pelle di mucca messa in scena oggi, e
continuare il discorso delle mappe e della geografia. Poi
sono incuriosito da questi amici giornalisti, quando
cambiano città. Quando cambio città, sono tornato da
poco da Lisbona, all’inizio mi sento una belva, sai
la storia del ventre di Parigi, dove le strade ti
sembrano vive. Voglio partire da una mappa urbana, con
gli animali e la pelle umana, prendendo a riferimento un
racconto di Borges, l’Aleph, la scrittura del dio.
- Inoltre sei anche il regista dello spettacolo…
- E’ tutto mio se non fosse per il lavoro tecnico di
Mirto Baliani, lui è del ‘77 e io sono del
‘71: è molto più giovane di me, ma è stata
l’unica persona che ho trovato a Parma fra i miei
colleghi che aveva voglia di mettersi a lavorare su
questa cosa, perché diciamolo: Scenario è soprattutto
un investimento, non ti pagano. È una cosa che tu fai e
poi se vinci bene, perché sarai retribuito.
- Esistono allora dei problemi, soprattutto se sei un
emergente?
- Le difficoltà le sto scoprendo soprattutto a livello
giuridico, ad esempio per l’agibilità
- del posto. Io ho già fatto spettacoli per strada, in
locali… Ma con una sala teatrale è un po’ più
difficile, anche se il suo fascino è più grande,
perché lì ciò che fai viene letto ai raggi X. Inoltre
vorresti anche mangiarci qualcosa, non dico
arricchirsi…
-
-
- Come hai scelto le musiche?
- Così. (ridendo) Finalmente era un mio spettacolo, così
ho scelto delle canzoni che mi piacciono, come ho fatto
anche per il manifesto … queste sono le piccole cose
un po’ ruffiane…
-
-
-
- PALLOTTOLE DI "CONTRAEREA"
DAI BALCANI ALL'ITALIA
- Il vincitore del premio in scena con le
cause del conflitto
- di Jean Claude Capello
-
- Quando ormai la questione jugoslava sembrava accantonata
per più recenti sciagure e relativi scandali, ecco che
il teatro offre un’occasione di riflessione su ciò
che è avvenuto dall’altro lato dell’Adriatico
nell’ultimo decennio. Con bravura attorica e una
buona documentazione non allineata alle ragioni ufficiali
adottate, Patrizio Dall’Argine, con il suo Contraerea,
ci guida in un percorso che vuole offrire una forma di
comprensione del presente, trovando un felice equilibrio
tra l’esposizione della storia recente e il momento
personale, che stempera e allo stesso tempo istituisce un
parallelismo con la tragedia della Bosnia.
- La trattazione dei materiali, presi da alcuni reporter di
guerra, può a tratti ricordare il Paolini dei Diari, ed
è su questa falsariga che si articolano
l’alternanza delle immagini dei carnefici, mentre
lui racconta di come quella terra è sempre stata
coattamente multietnica fin da prima dell’Impero
Asburgico, alla presenza di un’alterego
dell’autore. Egli attraverso momenti assurdi, mostra
un quotidiano conflitto minore, lontano dai Balcani, ma
che è ugualmente in grado di alienare. Così, come ci ha
detto lo stesso Patrizio, il cecchino a Sarajevo può
diventare un nostro pirata della strada, mentre le
ragioni del primo trovano la propria ottusa
giustificazione nello stesso modo in cui i personaggi del
supermercato lanciano le proprie facili sentenze, tutti
convinti di possedere una propria e valida ricetta ai
mali del mondo.
- La scenografia ridotta ed essenziale non
limita la riuscita dello spettacolo, ma, al contrario,
permette all’autore, che ha una provenienza
esplicitamente pittorica, di mettere in mostra le proprie
capacità senza sacrificare il gusto estetico.
- Insomma, tra i finalisti del Premio
Scenario, Contraerea è sicuramente il lavoro più
compiutamente teatrale. È stato perciò meritato il
premio attribuito a questo pezzo, che concilia tanto il
risultato artistico quanto l’impegno sociale, non
deludendo le attese nel passaggio dagli iniziali venti
minuti allo spettacolo finito.
-
- Contraerea
- di e con Patrizio Dall'Argine
- auito alla regia, luce e suono: Mirto
Baliani


 Ha
iniziato Giorgio Simbola, ricordando con un po’ di
nostalgia la sua terra natale, la Sardegna, e i racconti
della nonna quando era bambino. Simbola è interessato al
tema dell'emigrazione e lo dimostra concretamente
attraverso l'esperienza della compagnia del Lazzaretto
Occupato, un’esperienza che egli condivide con altri
componenti di sei famiglie emigrate per di più
dall'Albania, con le quali convive in uno stabile
occupato.
Ha
iniziato Giorgio Simbola, ricordando con un po’ di
nostalgia la sua terra natale, la Sardegna, e i racconti
della nonna quando era bambino. Simbola è interessato al
tema dell'emigrazione e lo dimostra concretamente
attraverso l'esperienza della compagnia del Lazzaretto
Occupato, un’esperienza che egli condivide con altri
componenti di sei famiglie emigrate per di più
dall'Albania, con le quali convive in uno stabile
occupato.
 Pertanto il teatro
di Simbola riconosce una istanza innanzitutto etica:
quella della fedeltà ai contenuti, ovvero agli obiettivi
che la ricerca stessa si pone nel momento di ideazione
del progetto: un'ideale di trasparenza necessario a ogni
opera d'arte che si collochi entro una reale volontà di
incisione e modificazione della realtà.
Pertanto il teatro
di Simbola riconosce una istanza innanzitutto etica:
quella della fedeltà ai contenuti, ovvero agli obiettivi
che la ricerca stessa si pone nel momento di ideazione
del progetto: un'ideale di trasparenza necessario a ogni
opera d'arte che si collochi entro una reale volontà di
incisione e modificazione della realtà.