 |
|
-
- La compagnia
ravennate "Teatro
delle Albe" ha
portato in scena a
Bologna i primi frutti
del Cantiere Orlando,
progetto pluriennale
promosso dalla Biennale
di Venezia. Il centro di
promozione teatrale
"La Soffitta"
ne ha ospitato due
"movimenti" e
un "preludio"
laboratoriale al
conclusivo "Orlando
Innamorato",
incontri fra la
drammaturgia di Marco
Martinelli e antenati
illustri quali Ludovico
Ariosto, Teofilo Folengo
e Matteo Maria Boiardo.
Sul palcoscenico del
Teatro Testoni (22
gennaio 2001) il primo
"movimento":
"L’Isola di
Alcina. Concerto per
corno e voce
romagnola" di Nevio
Spadoni, interpretato da
Ermanna Montanari.
- In
collaborazione con Link
Project la seconda tappa
(31 gennaio, 1 e 2
febbraio): Il
"Baldus" dei
Palotini, giovane
generazione delle Albe.
|
Concerto
per Circe romagnola
- di
Valentina Bertolino
-
-
- Assi
da palcoscenico, schegge di
versi, cocci di personaggi e
cataste di oggetti deformati dal
tempo: sono gli insoliti
materiali del "cantiere
Orlando", progetto teatrale
che impegna il Teatro delle Albe
in assemblaggi e restauri sulle
fondamenta letterarie di un
ambiguo Cinquecento.
- Lo
smaliziato sguardo del presente
ritocca l’armonioso profilo
del Rinascimento alla luce degli
accenti passionali
dell’Ariosto e degli
scarabocchi ironici di Teofilo
Folengo: incontrano così la
scena le voci ribelli di Alcina,
ammaliante insidia per i
paladini, e Baldus, dissacrante
riflesso dell’ideale
cavalleresco.
- La
prima, novella Circe, rinasce
nella campagna ravennate in un
passato prossimo, e, ai nostri
occhi, in un "concerto per
corno e voce romagnola"; una
"riscrittura per lampi"
ritrae invece il secondo, con
un’esuberanza che si
divincola da ogni prigionia
temporale.
- Entrambi
frutto di quella
"phantasia" che, oggi
come allora, confina con la
realtà rivelandone le zone
d’ombra, sono però
ridisegnati secondo
sperimentazioni espressive
differenti: "L’isola di
Alcina" e il
"Baldus" sono il
risultato di
"movimenti"
complementari di ricerca, cui
corrispondono due generazioni
delle Albe, multiforme compagnia
romagnola che si ramifica nei
percorsi individuali per poi
riannodarli in un originale
contesto corale.
- Il
"Concerto" affida così
la melodia alla proprietà vocale
di Ermanna Montanari,
un’Alcina dai toni violenti,
aspri o sofferenti, che in questa
Romagna al crocevia fra
l’immaginario e il reale ha
un duplice volto: è qui una
donna coinvolta in una vicenda
d’amore e abbandono, il cui
nome evoca le suggestioni del
fantastico ariostesco, sfumando i
confini con una dimensione
magica.
- In
una narrazione per frammenti, che
ricostruisce l’emozione e
non il fatto, Alcina è voce
sola, e le sue invettive
descrivono la dolorosa
esasperazione amorosa che ella
condivide con la sorella
Principessa, soffocata in un
folle mutismo. Il testo si
nasconde in oscuri suoni
dialettali, e la regia supplisce
con un linguaggio parallelo di
gesti e oggetti trasfigurati in
simboli: un giglio, una cornice,
un divano, si inseriscono in una
trama di mani che si stringono
spasmodiche, si irrigidiscono, si
attraggono e si respingono.
Sembra un’isola il palco
rialzato su cui troneggia la
fisicità statica delle sorelle;
sono uomini e sono cani quelle
creature che mugolano o latrano
nella gabbia sottostante, il
canile ereditato dal padre…
- Se la
partitura del concerto affida la
melodia alla recitazione, il
ritmo è scandito da scatti di
luce e buio, da rumori, da note
elettroniche e dal corno, che
lacera lo spazio come
l’emozione il personaggio.
- Si
percepisce la ricerca
dell’orchestrazione, della
compenetrazione costruttiva di
elementi drammaturgici diversi
secondo principi di equilibrio.
Una precisione formale quasi
"rinascimentale", e
dunque necessariamente minata
dall’uso estremo dei mezzi
espressivi: suoni acidi e
fastidiosi, toni corrosivi, e il
dialetto, radice maligna
estirpata con cura
dall’Ariosto, che con i suoi
versi coltivava le prime gemme
dell’italiano letterario.
Quella stessa radice che, al
contrario, Folengo fece
attecchire alla base degli
antichi pilastri del latino, per
incrinare con divertito sguardo
polemico gli ideali
cristallizzati delle Corti: il
"Baldus", secondo
"movimento", compie lo
stesso processo esprimendosi
nella lingua viva, moderna, dei
"Palotini", giovane
generazione delle Albe.
- In
un’epica dei contrari,
questo anomalo autore faceva
nascere a Cipada, piccolo
villaggio "oltre il
Po", un paladino dal sangue
reale, di stirpe francese: ma le
premesse per un aureo destino si
scontrano con la vocazione
godereccia dell’eroe.
Secondo il suo "codice
d’onore", cerca la
rissa, si riempie la pancia e si
affoga nel vino, non riconosce
nessuna autorità se non quella
dei suoi desideri e
"combatte
valorosamente" per
soddisfarli.
- Nelle
mani dei Palotini la vicenda di
Baldus diventa una travolgente
accozzaglia di parole, urla,
risate, bottiglie che passano di
mano in mano arruolando anche il
pubblico fra i briganti ,
compagni d’avventura e
piccolo esercito dai valori
sovvertiti.
- Sembra
di assistere a un gioco nato per
caso, che si prende sul serio
proprio perché ingenuo: sembra
che gli attori si avventino sui
personaggi come bambini su un
giocattolo, e che su di essi
riversino la propria natura,
gettando sulla scena la realtà
che la circonda. Musica, fumo,
insulti, gioiose volgarità e una
rigorosa etica del disordine sono
i cardini di questo gioco tutto
al maschile, dove basta una
parrucca e il falsetto a ricreare
Baldovina, principessa di
Francia, o un’armatura per
rendere goffe le caricature di
arrugginiti rappresentanti del
potere.
- I
fatti sembrerebbero accumularsi
orientati da una fantasia libera
dai vincoli del testo, se Folengo
non lanciasse qualche frecciata
dal passato ridefinendo i
caratteri del suo paladino,
facendogli calpestare le vere
bassezze umane, le malignità
della corruzione e
l’ipocrisia della forma.
- Inesauribile
l’energia degli attori, che
non si risparmiano, correndo,
gesticolando, ballando, e che,
con la stessa intensità, si
fermano per recitare dei versi,
guardando estasiati a paradisi di
birra.
- Serio
e ingenuo come un gioco, finisce
all’improvviso, lasciando
immaginare tutto il caos che il
paladino irrequieto si lascerà
alle spalle nelle sue ubriacanti
peregrinazioni.
- Il
ritratto di Alcina compariva in
un prezioso mosaico di emozioni;
Baldo e i suoi compari irrompono
senza complimenti. Nella platea
dell’ "Isola"
regnava il silenzio attento di un
pubblico impegnato nella ricerca
di una chiave di lettura
personale, approfittando magari
di quella emotiva, modulata sulla
voce della protagonista.
- Nel
covo di "Baldus", al
caos sonoro si aggiungono le
risate degli spettatori,
coinvolti anche spazialmente:
l’azione straripa , e il
pubblico la circonda, ma spesso
ne viene circondato.
- Prendendo
le mosse dai classici di un
secolo lontano, i due
"movimenti" del
"Cantiere Orlando"
sembrano aver raggiunto poli
opposti. Ma questa distanza è la
stessa che separava Ariosto da
Folengo, la Corte dal Popolino,
l’Artificio dalla Natura,
l’Ordine dal Disordine:
l’uno non esisterebbe se non
fosse il negativo
dell’altro.
- Così
Alcina è il tumulto delle
passioni confinato
nell’interiorità, mentre
Baldus è l’anarchia che
dissolve la forma: la realtà
umana, nel suo presente eterno,
conserva il suo duplice volto,
incurante dei secoli.
- Il
Teatro delle Albe coglie il
rumore di fondo che accompagna il
frastuono dello scorrere del
tempo e, con frammenti di
"ieri", porta alla luce
l’essenza velata dell’
"oggi".
| LA
FOLLIA DI ALCINA di Laura
Romasco
|
 |
- Si è
parlato di musica inquietante; si
è detto che il dialetto
romagnolo era ai più
incomprensibile, ci tagliava
fuori da una piena
partecipazione. Non importa. In
questo spettacolo hanno - devono
avere – un netto predominio
i sensi sulla comprensione. Il
lavoro drammaturgico di Marco
Martinelli lega insieme il mito
della maga Alcina a una storia
dal gusto popolaresco, molto
semplice. È il regista stesso
che ce la racconta in un breve
prologo prima dell’inizio
dello spettacolo.
- Siamo
in Romagna: Alcina è la figlia
maggiore di un uomo appassionato
dell’ "Orlando
Furioso". Sua sorella minore
è la prediletta: per questo la
chiamano Principessa. Entrambe
destinate a un doppio abbandono:
il primo è quello del padre, che
come unica cosa lascia loro il
suo canile. E poi quello del
bellissimo "furistir",
che la innamora e poi scompare,
improvvisamente così
com’era comparso. È subito
pazzia per la
"principessa"; sarà
Alcina a doversi prendere cura di
lei, incondizionatamente. Ma
anche lei è malata della stessa
follia; in paese si dice che si
sia presa piacere con lo stesso
uomo, all’insaputa della
sorella.
- Questo
ci racconterà Alcina: più che
una storia la raffigurazione di
uno stato, per noi, questa sera
come tutte le altre sere. Un
copione che si ripete, per
ricordare, per rievocare, come si
fa per un rito.
- La
scena è buia. Alcina e la
sorella ci appaiono in un primo
lampo di luce; sono sedute su un
divano. Sembrano imprigionate da
quel divano, così come da una
gabbia luminosa intorno a loro.
Di nuovo buio. È la musica ad
introdurci in uno stato inquieto.
Ancora luce. Le intravediamo;
c’è un sottile velatino che
ispessisce l’idea onirica di
ciò che abbiamo davanti ai
nostri occhi.
- Stavolta
c’è anche lui, il bel
forestiero. È a torso nudo. Le
guarda sedute. Ci guarda. Ha una
maschera animalesca. Più tardi
capiremo che è uno degli
uomini-cani che abitano il piano
inferiore della scena, il piano
inferno. È il canile. Lo capiamo
dai latrati. Ma è anche una
sorta di prigione per quegli
uomini visti come cani.
- E
sarà per entrambi
l’invettiva di Alcina: per i
cani e per gli uomini, che sono
come loro, sono falsi, meschini,
capaci di ogni bassezza.
- Il
lavoro sulla voce di Ermanna
Montanari crea una musicalità
inedita. Le parole vengono
plasmate, appena sussurrate e
subito dopo gracchiate. È il
metro che ci viene dato per
misurare la follia che le brucia
dentro, quasi volesse nasconderla
all’inizio, ma che
esploderà in un crescendo
finale.
- Il
"risuonatore-Ermanna"
si intreccia alla voce del corno
inglese e ai suoni elettronici
come fosse un ulteriore
strumento. È il terremoto che
Alcina ha dentro, quello del
quale ci rende partecipi.
- Funzione
drammaturgica affidata anche alle
luci , che colorano la tenda
drappeggiata alle spalle delle
due attrici, continuamente,
passando dal viola al verde
acido, da toni scuri alla
inondazione di oro quando il
drappo verrà sollevato, al
momento della rivelazione di
Alcina. Le stesse luci che
dipingono sul suo volto una
maschera innaturale, accentuando
inevitabilmente i tratti di
follia, ma anche di rabbia,
furore, sofferenza.
- Principessa
è diversa. È come chiusa in una
teca di cristallo, dove vive il
suo mondo insensato, che ce la
mostra in uno stato di purezza,
quasi. La calla che ha in mano
evidenzia forse proprio questo.
È lei che ciba i cani; questi
esseri affamati, mai paghi. Che
si assomigliano, ma che in fondo
sono uno solo: il bello
straniero, chiuso in gabbia e
consapevole di esserlo. Questo ci
riporta alla mente le magia della
maga Alcina, che affascinava,
innamorava e poi trasformava le
sua vittime in pianta o animale.
- È un
dramma, un vero dramma che
colpisce i nostri sensi, e che
raggiunge il suo culmine quando
lei, Alcina, confessa
l’amore per lo stesso uomo,
quell’amore che l’ha
portata all’istupidimento,
nella voglia di perdersi nella
nebbia.
La reazione che si poteva
leggere sui volti degli spettatori alla
fine della rappresentazione del Baldus
era completamente diversa da quella che
si era potuta vedere, magari sui volti
delle stesse persone, una settimana prima
all’uscita del teatro Testoni. Quasi
opposta si potrebbe insinuare, proprio
perché opposti e, in un certo senso
complementari, erano i due spettacoli
ideati e diretti da Marco Martinelli. Il
primo, L’Isola di Alcina, è
un quadro perfetto, nitido, di una follia
e un caos interiori alla protagonista
interpretata dalla superba Ermanna
Montanari. Una tecnica vocale e una
mimica facciale che si fondono
all’unisono in una melodia di
lamenti, grida, parole e frasi lanciate
in aria come frecce o solo sussurrate a
labbra strette: il tutto arricchito e
forse a tratti camuffato da un dialetto
ravennate strettissimo, comprensibile
solo a una parte della platea, ma che
riesce comunque a coinvolgere tutti
coloro che decidono di lasciarsi
trasportare dalla sua vorticosa
musicalità. Perché come lo stesso
regista ci svelerà poi, nell’Isola
di Alcina non c’è nulla da
capire, tutto ciò che lo spettatore deve
capire lo racconta egli stesso in un
breve prologo, tutto il resto va vissuto
ad un altro livello che non è quello
della comprensione razionale. Infatti la
trama è abbastanza semplice: due sorelle
vengono colpite da una doppia sciagura,
la morte del padre che le lascia così
sole e la partenza, improvvisa come
l’arrivo, del forestiero che le
aveva amate entrambe. Ma il ruolo di
sorella maggiore e l’onore
costringono Alcina a non rivelare nulla
sulla propria relazione ufficiosa e sul
dolore che la tormenta e ad occuparsi
della sorella minore Principessa, ingenua
e indifesa pupilla del padre, ora
smarrita e priva di senno per la fine di
un amore invece più ufficiale. Il resto,
ovvero lo spettacolo vero e proprio dal
punto in cui lo iniziamo a vedere noi, è
un crescendo di confidenze, di
confessioni, di ingiurie contro gli altri
e forse anche se stessa, da parte di
Alcina che lentamente ma con la furia di
un temporale lascia scrosciare fuori di
sé fiumi di odio e di follia ormai da
troppo tempo soffocati nelle sue viscere.
Un terremoto di parole e passioni
rinchiuso in uno spazio scenico limitato
da una pedana rialzata, da un divano da
salotto e da un fondale che come un muro
delimita lo spazio vitale delle due donne
: la precisione tecnica quasi maniacale
di luci suoni e colori psichedelici che
racconta il caos più totale di
sentimenti. Nulla è lasciato al caso in
questa ricerca spasmodica del "bello
perché perfetto" e si può intuire
nella sua totalità il lungo e faticoso
lavoro svolto dal regista, dagli attori,
dal musicista Luigi Ceccarelli e da
Vincent Longuemare per il progetto luci.
Di tutto questo il Baldus
è l’altra faccia della
medaglia, l’immagine speculare, il
rovesciamento di causa ed effetto: la
struttura lineare e semplice della storia
fa da catapulta per un gruppo di giovani
scapestrati e agili come gazzelle a
correre davanti dietro intorno al
pubblico tra schiamazzi e grida di
battaglia. Sono gli otto briganti amici
di Baldo che lo seguono nelle sue
avventure e sventure in nome di
un’anarchia di gesti, di risate e di
allegria: come Folengo volle allontanarsi
dall’Ariosto e dal Bembo dalla
ricerca di una lingua uniforme,
mescolando latino e dialetti del nord
Italia, così i giovani coautori di
Martinelli danno corpo a una vera e
propria drammaturgia d’avanguardia,
testi di allora e parolacce di oggi,
monologhi in versi e slang degli
adolescenti discotecari dei giorni
nostri! Un terremoto vero e proprio di
balli urla e corse folli che avvolge e
travolge il pubblico in risate più che
chiassose, ma pur sempre soffocate dalla
voce degli attori. Perché anche se molto
giovani e alle prime armi, di veri e
propri attori si tratta: lo si percepisce
dalla concentrazione che mettono in ogni
passo o parola dall’inizio alla fine
dello spettacolo, dalla bravura a
mantenere un perfetto equilibrio tra
confusione di gesti e parole, sia
improvvisata che studiata, e pathos nei
monologhi poetici del Folengo, perché
anche se due di loro sono attori adulti
professionisti la differenza si nota ben
poco, se non nei pezzi in dialetto di
Luigi Dadina. Ma dietro a tutto questo si
può notare la presenza di un maestro
quale è Martinelli, una mente che non
solo guida e coordina le parti di un
tutto, ma che più che insegnare osserva,
lascia liberi i suoi allievi di
esprimersi nel proprio modo e linguaggio
e ne trae, "risucchia" come
dicono loro, tutto il materiale possibile
e immaginabile da mettere in scena, che
poi viene rielaborato non solo da lui ma
dall’intera squadra "delle
Albe". Così come un vero alchimista
Marco compone e scompone ogni sostanza a
sua disposizione, passa da un estremo
all’altro, da materia a caos e da
caos a materia per costruire
un’architettura completa e solida di
quello che è il "Cantiere
Orlando", progetto promosso dalla
Biennale di Venezia di cui aspettiamo il
terzo e ultimo blocco, e di tutta la sua
ricerca teatrale come regista.

Baldus,
nostro contemporaneo
Siamo al Link,
locale "underground" di
Bologna. Tra lamiere luccicanti, luci
coloratissime e cemento, si è svolta la
grintosa performance dei
"palotini" di Marco Martinelli:
uno sguardo contemporaneo al cinquecento
di Teofilo Folengo, fra musica hard-core
e versi in latino maccheronico, tra
"montagne di frittole, cocaina,
spinelli" i ventenni di Ravenna si
sono destreggiati in una calibratissima
esplosione di energia, facendo rivivere
ai giorni nostri il Baldus
di cinquecento anni fa, trovando una
corrispondenza "quasi
millimetrica" tra le due epoche,
come afferma lo stesso regista-alchimista
Marco Martinelli. Alle ore ore 22.30 del
1 febbraio 2001 incontriamo gli attori
dello spettacolo Baldus.
Riscrittura per lampi da Teofilo Folengo
andato in scena a Bologna dal 31 al 2
febbraio 2001.
- -
Quanto di vostro avete messo nei
testi, nella drammaturgia?
- A
parte i monologhi, i blocchi,
tutto il resto è improvvisazione
nostra, l’inizio, per
esempio, è metà mio e metà di
Folengo. La visione inizia con
Folengo: "l’enorme
montagna, gnocchi,
frittole…"
"cocaina,
spinelli…"
l’abbiamo aggiunto noi.
- -
La musica è vostra?
- La
musica è stata scelta fra varie
cassette del "Number
One" di Brescia.
- -
Da dove nasce il Cantiere
Orlando? Vi piace questo
progetto? Ve l’ha proposto
lui o l’avete scelto
insieme?
- Noi
abbiamo iniziato a lavorare con
Jarry per I polacchi .
Lavoravamo già con la Non
scuola.
- Finiti
I polacchi c’era già da
tempo questo "Progetto
Orlando" che va avanti fino
a Giugno 2002 quando ci sarà il
terzo blocco, l’ultimo.
Quindi guidati da Marco siamo
stati dentro il progetto orlando.
- -
Ma eravate più numerosi ne I
Polacchi…
- -
Sì, eravamo in 12.
- -
E gli altri?
- Gli
altri si sono scelti altre strade
- -
Comunque avete contribuito a fare
anche i testi…qualsiasi cosa
venisse fuori da voi…
- È
proprio la particolarità del
lavoro di Marco: lavorare
sull’attore; lui succhia
dall’attore ciò che può
essere utile, si lavora con
l’improvvisazione…Marco
è come un alchimista! Un
succhiatore! Che lavora
sull’attore…più
materiali gli dai e più Marco
riesce a costruire
l’architettura di tutto lo
spettacolo.
- (
pausa…Roby, si è offeso ed
è scappato perché Delia non
l’ha riconosciuto ne L’Isola
di Alcina in cui ricopriva la
parte di Forestiero!!!)
- -
Le prove come avvengono?
- Ogni
lavoro ha un tipo di prove
diverso. Per i polacchi abbiamo
lavorato per tre mesi tutti i
giorni sei, otto, dieci ore al
giorno, era proprio intensivo,
disciplina "a paletta".
- -
Era un laboratorio a scuola?
- Il
primo passo oltre, diciamo. Nel
senso che il laboratorio a scuola
era due giorni alla settimana.
- -
Però voi avete cominciato a
scuola.
- Ma I
Polacchi è tutta
un’altra cosa! È il primo
passo oltre…e poi il Baldus
è un altro passo. Marco ci ha
chiesto, oltre alla
disponibilità, perché ne
"I polacchi"
all’inizio c’era solo
la disponibilità, di lavorare
molto di più, nel senso che
c’era da portare ancora più
materiale su cui poi lui
chiaramente ci lavora e ti dice
"va bene, non va bene"
, anche se alcune cose te le dice
anche sul momento: dieci minuti
prima (dello spettacolo) ti dice:
"No, guarda, facciamo
un’altra cosa…"
"Ma Marco, sta per entrare
la gente…"rispondi
tu…ma non c’è niente
da fare, è un classico che ti
dica una cosa del genere prima di
uno spettacolo!
- -
Perciò vi chiede di
improvvisare?
- Di
improvvisare no, però ti chiede
di esserci sempre, cioè, non
puoi "smollare", usando
un termine calcistico: fino al
novantesimo, anzi fino al fischio
dell’arbitro…e se
l’arbitro fischia al
novantadue bisogna star lì fino
al novantaduesimo.
- -
Perché il Cantiere Orlando
riprende dei testi così antichi,
epici e li rielabora così in un
modo attuale, diciamo?
- Questo
è un modo di lavorare
"Albe": il dare vita
alle cose. Folengo, se lo leggi
adesso, com’è scritto, è
morto, nel senso che è di
quattrocento anni fa, comunque
senti che ha una vitalità
interna. Per l’epoca magari
quella che incomincio a dire
all’inizio "gli
gnocchi, frittole, dorate
polpette…" era la fame
vera, invece i ragazzi di oggi,
le persone di oggi che
cos’è che cercano? Al di
là della ricchezza, che
cos’è? Magari trovare fiumi
di cocaina, montagne di spinelli.
Roby: allora segnati questa: il
lavoro delle Albe è sempre non
una messa in scena, ma una messa
in vita. Comunque da sempre Marco
prende i testi classici: è un
lavoro che fa anche con la Non
scuola, che è l’insieme di
tutti i laboratori che le Albe
fanno nelle varie scuole di
Ravenna, a cui partecipano più
di quattrocento ragazzi. Quindi
si prende il testo classico e lo
si prende a sassate, lo si
distrugge, per ridargli nuova
vita, per ridargli la vita che
aveva.
- -
Voi non siete tutti di
Ravenna…
- Lui
è di Castiglione di Ravenna, lui
di Torre del Greco…però
abitiamo tutti a Ravenna
- -
Qualcuno vi ha definito "una
compagnia teatrale che sta
diventando una famiglia
d’arte"
- Ah!
questa tu l’hai letta in Jarry
2000!!!
- -
Comunque si vede, lavorate così
uniti che alla fine lui è come
un padre, no?
- Che
bello! E l’Ermanna è la
nostra mamma!(ironico)NO! NO!
Questo NO! Ermanna ti chiedo
scusa!
- -
Chi vi fa le luci?
- Vincent
Longuemare lavora col Kismet, è
il light designer, un genio che
da ragazzo si è visto tre volte
i Sex Pistol dal vivo! È
arrivato Marco!
- Le
domande vengono poste ora a Marco
Martinelli, regista dello
spettacolo.
- -
Da cosa nasce il progetto
"Cantiere Orlando"?
- È
nato dalla fascinazione mia e di
Ermanna, che avete visto
nell’Alcina, per questi
poemi del nostro rinascimento.
Sono poemi di fantascienza
straordinariamente moderni,
futuri, non c’è psicologia
dentro, ci sono psiche impazzite
che schizzano di qua e di là, ci
sono paladini che si perdono nei
labirinti amorosi, ci sono tre
rimbambiti, una narrazione molto
potente, reale e fantastica allo
stesso tempo, ci piace questo
intreccio di realtà e fantasia,
gran fantasia!
- -
Però poi la porti nella realtà
più viva, perché anche loro ( i
palotini) ci dicevano che questo
usare i dialetti è un voler
tirare fuori la vita
all’interno di questi poemi,
che magari leggendoli così con
questa lingua arcaica sembrano
morti.
- In
realtà, se vai sotto alla pelle,
alla superficie, trovi proprio
una grande forza, una grande
vitalità. Folengo era il nostro
Baldus, noi abbiamo fatto
un’opera che uno, se la vede
e non sa nulla di Folengo, dice:
"Questi hanno raccontato del
mondo di oggi!". Ma è la
stessa cosa che faceva Folengo
del suo mondo: lui raccontava gli
sballati, i malandrini, i ragazzi
affamati di vita, di vitalità e
io l’ho trovato
assolutamente contemporaneo,
quasi in maniera millimetrica. A
parte che in questo lavoro ci
sono proprio delle sforbiciate
dal poema di Folengo, ci sono
proprio delle
"rasoiate".
- -
Hai equilibrato la drammaturgia
creata dai ragazzi con la
drammaturgia dei testi, ho visto
che ci sono cose scritte da loro.
- Sono
uscite da tante improvvisazioni
che abbiamo costruito. Io
lavoravo avendo questi due poli
così apparentemente lontani: il
poema in latino maccheronico di
Folengo e tutta
l’improvvisazione, tutto il
mondo che loro tiravano fuori. Si
trattava di costruire
un’architettura che tenesse
in piedi questi due poli, senza
che fossero appiccicati
l’uno all’altro, ma che
si potessero vivere dentro lo
spettacolo come profondamente
intrecciati, per cui nella faccia
di Roberto, di questo ragazzo
della statale 16, tu vedi il
Baldus di cinquecento anni fa; è
questo che mi piacerebbe che lo
spettatore vivesse. Sono ragazzi
di oggi e nello stesso tempo
c’è dietro di loro una luce
che li rende degli archetipi
lontani.
- -
Come fai a tirare loro fuori
questa energia?
- Molta
ne hanno di loro, sono ragazzi,
tra l’altro, scelti su uno
squadrone.
- -
Infatti i palotini erano più
numerosi.
- I
palotini erano dodici. Poi qui
abbiamo Marco (Mercante ndr) che
è stato preso apposta per fare
una sorta di legame anagrafico
tra Luigi Dadina l’attore
che fa il re, che è diciamo un
quarantenne, mentre loro sono
tutti sui venti, e allora non
volevo che ci fosse questo
gradino troppo alto. In questo
covo dei briganti lui mi fa
questo link perfetto, anche per
l’uso del dialetto mantovano
che è proprio il dialetto di
Folengo.
- -
Ma c’è anche un equilibrio
perfetto tra il loro slancio e
l’insegnamento. Si vede la
guida forte di un maestro, che
tira fuori un’energia che
viene poi indirizzata
perfettamente.
- Questo
è uno spettacolo che, uno che lo
vive, che lo vede, a parte che si
diverte, ma mentre
nell’Alcina la precisione
maniacale viene fuori
immediatamente, qui uno può
anche essere tratto in inganno e
pensare che questo sia il frutto
di energia, spontaneità,
vitalità. Queste ci sono
sicuramente, ma lo spettacolo è
costruito con la stessa logica
dell’Alcina, cioè noi
lavoriamo tutti i giorni perché
il dettaglio sia costruito alla
perfezione, anche in questo
"caos", ma è un caos
con metodo, e proprio attraverso
il metodo il caos diventa più
forte. Se noi diamo una forma
teatrale alla grande vitalità
che abbiamo, allora arriva con
potenza, altrimenti si disperde,
e tante volte capita di vedere
spettacoli dove c’è
confusione, dove non c’è un
caos organizzato e ordinato.
Tutto questo viene costruito
senza spegnere la loro furia,
anzi, mantenendo sempre un
equilibrio vivo tra furia, caos,
metodo, follia, architettura,
lavoro di alchimia. Lo spettatore
molto bravo e sensibile lo coglie
questo.
- -
In questo spettacolo il pubblico
è molto coinvolto, mentre
nell’isola di Alcina
c’è una separazione netta.
- Qui
siete scese nel canile!
- -
Volevo chiedere un’altra
cosa rispetto all’isola di
Alcina, sull’uso del
dialetto. A livello sensoriale lo
spettacolo è molto forte,
perché c’è una grande cura
delle luci, delle musiche, anche
l’uso della voce di Ermanna
è calibratissimo, però non hai
mai pensato che il dialetto
potrebbe creare una mancanza
nello spettatore? Lo spettatore
esce dal teatro sapendo che non
ha capito qualcosa perché non
aveva gli strumenti. Al livello
sensoriale arrivano delle forti
emozioni…ma si sente che
mancano le parole…
- Capire
a teatro è un falso problema.
Tutto quello che c’è da
capire nell’Alcina lo dico
io nelle quattro parole iniziali.
Capite quelle, e quelle si
capiscono perché sono in
italiano, il resto è da vivere
solo ad un altro livello, cioè
tutto ti arriva direttamente
nella pancia, nel cuore, nel
sesso, oppure in qualche cosa di
profondo che sta nel cervello, ma
che non è la comprensione
razionale. E di questo abbiamo la
conferma dal fatto che lo
spettacolo ci è stato preso a
New York, andrà in Olanda, forse
in Israele e già una volta che
usciamo dalla Romagna appunto, la
gente non capisce nulla. Quindi
il problema è comprendere a un
livello profondo non tanto capire
il significato razionale, come
davanti a una sinfonia. Davanti a
una musica tu non ti chiedi:
"ma che cosa vuol
dire?" eppure questa musica
ti comunica un sacco di cose, un
mondo. Tra l’altro un lavoro
così ti arriva al cuore
indipendentemente dalla
comprensione razionale. Un
romagnolo che capisce tutto può
rifiutarlo, non passa dalla
comprensione, passa se tu ti fai
travolgere dal terremoto che è
la voce di Ermanna coniugata con
la musica di Ceccarelli. È un
terremoto, quindi puoi dire
"no, non voglio questo
terremoto", oppure ti puoi
lasciare trascinare da questo.
- -
Quindi tu hai scelto il dialetto
romagnolo per la sua musicalità.
- No.
Il romagnolo è la lingua barbara
di Ermanna, è una lingua che non
sembra neanche un dialetto
italiano, per come lo usa lei a
un certo punto diventa greco
antico, diventa qualche cosa di
arcaico e il modo con cui Ermanna
lo fa risuonare nell’Alcina
è molto diverso dal modo con cui
lavoriamo sui dialetti in questo
spettacolo. Lì è usato come una
lingua tragica, una lingua che
urla una mancanza, manca qualcosa
ad Alcina, alla sua vita ,al
mondo e lei ce lo grida in quel
modo. Qui il dialetto è usato
nella maniera opposta, come un
gioco linguistico, una capriola
del cervello. A me piace andare
in entrambe le direzioni, mi
piace lavorare sul tragico come
sulla sulla farsa assoluta e
totale.
- Ora
Marco Martinelli riunisce i suoi
"palotini" per qualche
commento allo
spettacolo…proprio come fa
un allenatore con la sua squadra
dopo una partita di calcio.
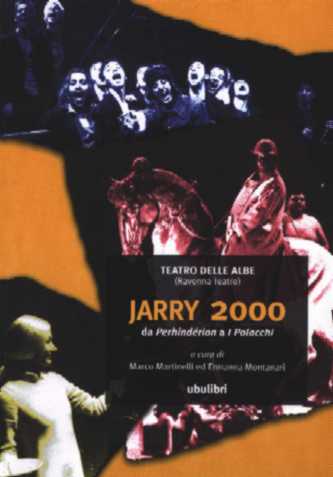
|
